 Lingua, cultura e poesia yiddish, testimoni dell’ebraismo in Europa
Lingua, cultura e poesia yiddish, testimoni dell’ebraismo in Europa
di Roberto Malini
«Lo yiddish non ha ancora detto la sua ultima parola. Contiene tesori che non sono stati ancora rivelati agli occhi del mondo. Era la lingua dei martiri e dei santi, dei sognatori e dei cabalisti, ricca di umorismo e ricordi che l’umanità non dimenticherà mai. In senso figurato, lo yiddish è il linguaggio saggio e umile di tutti noi, l’idioma dell’umanità sospesa fra paura e speranza».
Isaac Bashevis Singer, dal Discorso per il Premio Nobel, 8 dicembre 1978
(traduzione di Roberto Malini)
Vi è chi afferma, anche fra gli studiosi, che lo yiddish (in ebraico: ייִדִישׁ), sia una lingua morta. È un’opinione maturata in base alla constatazione delle distruzioni e dagli stermini avvenuti durante la Shoah – in cui almeno sei milioni di ebrei e la loro cultura furono quasi annientati – e le purghe staliniane. In quelle immani catastrofi lo yiddish, lingua degli ebrei orientali, patrimonio vernacolare dei poveri fino alla fine del XIX secolo, quando fiorì la sua grande letteratura, si avvicinò al baratro dell’estinzione. Ma sopravvisse. Lo yiddish, scritto nei caratteri dell’alfabeto ebraico, ha radici nella cultura degli ebrei aschenaziti provenienti dalla Francia e dall’Italia settentrionale, che nel X secolo si stabilirono nella valle del Reno.
La loro tradizione si diffuse ampiamente nell’Europa centrale e orientale, tanto che all’alba della Prima guerra mondiale lo yiddish era parlato da circa undici milioni di ebrei.
Le persecuzioni del XIV secolo costrinsero numerose comunità ebraiche a spostarsi ancora più a est, nelle aree che oggi fanno parte della Polonia e della Lituania, originando quello che oggi definiamo come yiddish orientale, in cui si avvertono influenze delle lingue slave.
All’inizio del XIX secolo la migrazione degli ebrei verso gli Stati Uniti condusse la lingua yiddish a stretto contatto con la cultura anglofona.
Nella seconda metà del secolo fu pubblicata la prima grammatica yiddish.
Prima, durante e dopo la Seconda guerra mondiale, molte comunità ebraiche che parlavano yiddish raggiunsero la Palestina, terra in cui sarebbe sorto lo Stato di Israele.
Lì la “lingua madre” fu a lungo in ballottaggio con l’ebraico come possibile lingua nazionale.
Prima dell’avvento del nazionalsocialismo, delle leggi razziali e dell’Olocausto, almeno due terzi della popolazione ebraica mondiale parlavano yiddish.
 Dall’XII al XVIII secolo la letteratura in quella lingua comprendeva soprattutto commentari religiosi e pochi testi di narrativa.
Dall’XII al XVIII secolo la letteratura in quella lingua comprendeva soprattutto commentari religiosi e pochi testi di narrativa.
Dalla fine del XVIII secolo, per altri cento anni i racconti chassidici e le storie di Nachman di Breslov dominarono la letteratura yiddish.
Tuttavia, dal 1864, apparve l’opera di Mendele Moicher Sforim (Kopyl,1836 – Odessa, 1917), considerato il padre della letteratura yiddish moderna insieme a Sholem Aleichem (Perejaslavl, 1859 – New York, 1916) e Isacco Leyb Peretz (Zamość, 1852 – Varsavia, 1915).
L’opera di Sholem Aleichem in particolare ebbe una straordinaria diffusione, non solo nel mondo ebraico, divulgando attraverso romanzi e racconti la vita delle comunità yiddish nei piccoli centri dell’Europa dell’est, promuovendo una visione a volte idealizzata dello shtetl, il villaggio ebraico.
Gli shtetl dell’Europa orientale, in realtà, erano insediamenti in cui l’autorità costituita relegava le comunità ebraiche, ai margini delle città. Essi divennero tuttavia il simbolo stesso della vita degli ebrei aschenaziti, discendenti dalle prime comunità ebraiche stanziatesi nella valle del Reno in epoca medievale. «Si può portare un ebreo fuori dallo shtetl – scrisse Sholem Aleichem – ma non si può portare lo shtetl fuori da un ebreo».
Fra i numerosi rappresentanti della letteratura yiddish moderna è importante ricordare Itzhak Katznelson (Karėličy, 1886 – Auschwitz, 1944), Kadye Molodowsky (Bjaroza, 1894 – Filadelfia, 1975), Isaac Bashevis Singer (Leoncin, 1903 – Miami, 1991), che nel 1978 fu insignito del Premio Nobel per la Letteratura, Yehiel De-Nur (Sosnowiec, 1909 – Tel Aviv, 2001) e Abraham Sutzkever (Smarhon’, 1913 – Tel Aviv, 2010).
Katzenelson e Sutzkever sono considerati fra i più grandi poeti dell’Olocausto.
 Anche il pittore Marc Chagall (Lëzna, 1887 – Saint-Paul-de-Vence, 1985) scrisse poesie in yiddish, mentre l’artista Jacob Vassover (Łódź, 1926 – Tel Aviv, 2008) ebbe il merito di rappresentare in una notevole serie di dipinti a olio (di cui un nucleo consistente e significativo è conservato presso il Thesaurus Memoriae della Cittadella della musica concentrazionaria di Barletta) la vita negli shtetl, sia per osservazione diretta, negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, sia a rappresentazione dell’immaginario tratto dai romanzi e dai racconti di Sholem Aleichem.
Anche il pittore Marc Chagall (Lëzna, 1887 – Saint-Paul-de-Vence, 1985) scrisse poesie in yiddish, mentre l’artista Jacob Vassover (Łódź, 1926 – Tel Aviv, 2008) ebbe il merito di rappresentare in una notevole serie di dipinti a olio (di cui un nucleo consistente e significativo è conservato presso il Thesaurus Memoriae della Cittadella della musica concentrazionaria di Barletta) la vita negli shtetl, sia per osservazione diretta, negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, sia a rappresentazione dell’immaginario tratto dai romanzi e dai racconti di Sholem Aleichem.
Quando ci si avvicina alla storia dello yiddish, è inevitabile chiedersi quante persone lo parlino ancora oggi, dopo lo sterminio degli ebrei in Europa e la scelta dell’ebraico quale lingua nazionale di Israele.
È innegabile che lingua e letteratura yiddish abbiano vissuto, dopo la Seconda guerra mondiale, una vera e propria rinascita, promossa dai suoi grandi autori.
Attualmente vi è un numero di persone che parlano yiddish compreso fra seicentomila e un milione, di cui almeno il settantacinque per cento è suddiviso equamente fra Israele e Stati Uniti.

Abraham (Avrom) Sutzkever
Sotto le tue bianche stelle
(trad. Roberto Malini)
Sotto le tue bianche stelle
tendimi la tua mano bianca.
Ogni mia parola è una lacrima
che chiede pace fra le tue dita.
Guarda, si sta facendo buio
nel mio sguardo che l’ombra chiude.
E non ho alcun luogo
dove restituirtelo.
Tuttavia, Dio indulgente,
ti affido ogni mio bene,
perché un fuoco arde in me
e nel fuoco i miei giorni.
Solo al chiuso, nell’ombra
si lamenta la pace che uccide.
Volo in alto, più in alto,
cercandoti: dove trovarti?
Mi braccano incredibili
scale e mucchi di stracci.
Li unisco in una corda logora
e ti canto così:
Sotto le tue bianche stelle
tendimi la tua mano bianca.
Ogni mia parola è una lacrima
che chiede pace fra le tue dita.
אונטער דײַנע ווײַסע שטערן
אונטער דײַנע ווײַסע שטערן
שטרעק צו מיר בײַן װײַסע האַנט.
מײַנע װערטער זײַנען טרערן
װילן רוען אין דײַן האַנט.
זע, אעס טונקלט וײער פֿינקל
אין מײַן קעלערדיקן בליק
און איך האָב גאָרניט קײן װינקל
זײ צו שענקען דיר צוריק.
און איך װיל דאָך, ג-ט, געטרײַער,
דיר פֿאַרטרױען מײַן פֿאַרמעג.
װײַל אעס מאָנט אין מיר אַ פֿײַר
און אין פֿײַער מײַנע טעג.
נאָר אין קעלער און אין לעחער
װײנט די מערדערישע רו.
לױפֿ איך העחער – איבער דעחער
און איך זוך: װוּ ביסטו, װוּ?
נעמען יאָגן מי משונה
טרעפ און הױפֿן – מיט געװױ.
הענג איך אַ געפלאַצטע סטרונע
אין איך זינג צו דיר אַזױ:
אונטער דײַנע ווײַסע שטערן
שטרעק צו מיר בײַן װײַסע האַנט.
מײַנע װערטער זײַנען טרערן
װילן רוען אין דײַן האַנט.
Continua a leggere→





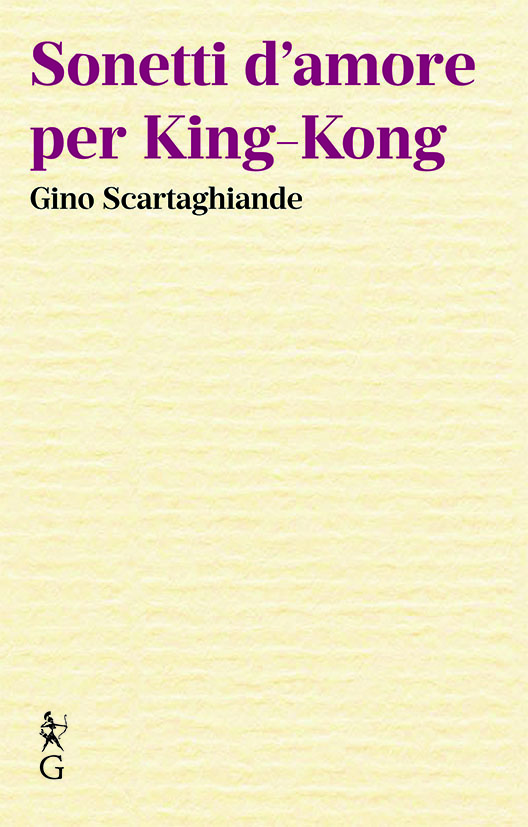





 Il libro è costruito così intorno a un tema originale, mentre viene in qualche modo evitato, ma con grazia, il confronto diretto con le grandi soglie della tradizione poetica occidentale, vale a dire Amore e Morte: eppure non si potrebbe dire che, in qualche modo, i testi di questa raccolta non abbiano a che fare anche con esse. È l’approccio di una penna sensibile sia sul piano umano sia sul piano letterario, che non vuole banalmente ripetere alcuni motivi, ma, se possibile, aggiungere qualcosa agli stessi.
Il libro è costruito così intorno a un tema originale, mentre viene in qualche modo evitato, ma con grazia, il confronto diretto con le grandi soglie della tradizione poetica occidentale, vale a dire Amore e Morte: eppure non si potrebbe dire che, in qualche modo, i testi di questa raccolta non abbiano a che fare anche con esse. È l’approccio di una penna sensibile sia sul piano umano sia sul piano letterario, che non vuole banalmente ripetere alcuni motivi, ma, se possibile, aggiungere qualcosa agli stessi. 






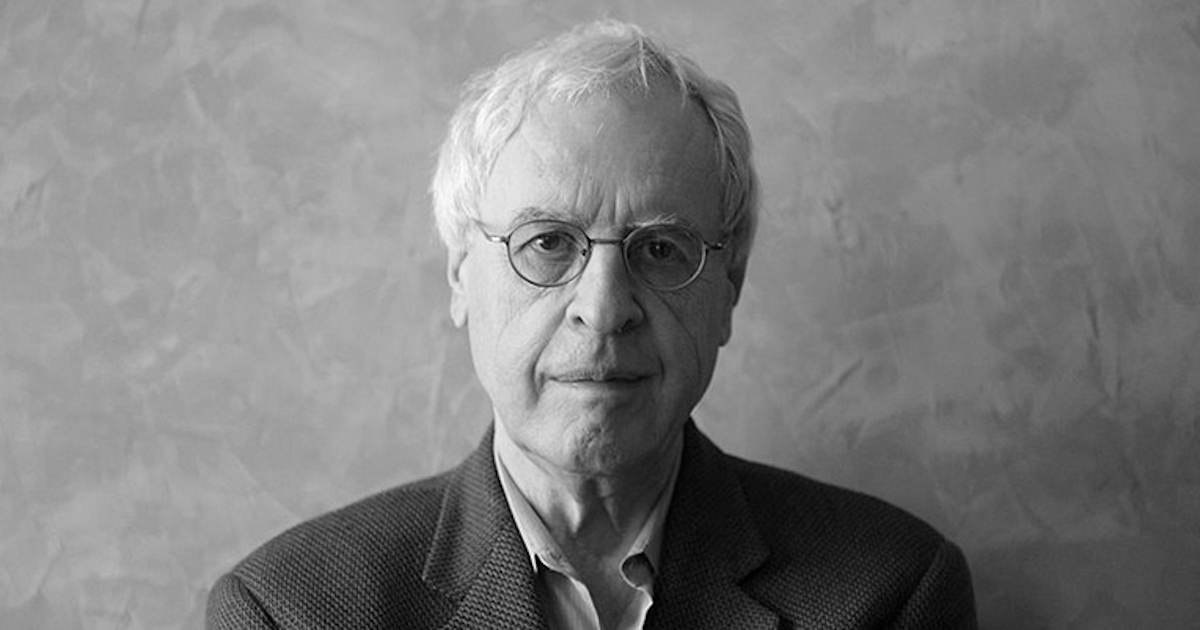









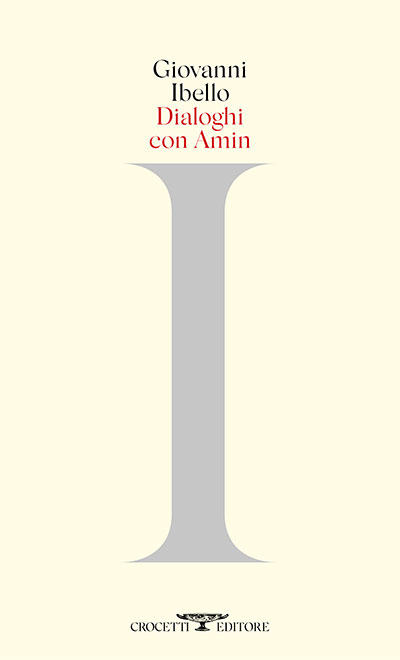 Dialoghi con Amin è un grande e originale poema notturno ed è un poema dell’imminenza. Qualcosa di terribile sta per accadere, ci viene detto e ripetuto. “Amin, è quasi giorno” e noi sentiamo che questo “quasi” è una soglia magica e questo “giorno” muterà la nostra vita, come nelle aubades della poesia provenzale, quando il giungere dell’alba separava gli amanti e li consegnava alla loro solitudine. Qualcosa di immenso sta dunque per compiersi. Ma non sappiamo ancora di cosa si tratta, non riconosciamo il volto del Mutamento. Sappiamo che non è un semplice amore, una semplice morte o una semplice rinascita. Questo ci viene detto più volte. “Credimi, noi non stiamo per rinascere”. E non si tratta nemmeno di un paradiso o di un inferno. No. L’imminenza continua a nascondere i suoi piani e ci lascia all’oscuro, come in una moderna Apocalisse, per citare un’opera cara a Giovanni Ibello. Rimane quest’estrema vigilia nel cuore della notte, rimane “la lesione tellurica del buio”, come scrive il poeta. “Di quello che sognavi veramente / non resta che un silenzio siderale / una lenta recessione delle stelle”. Rimane qualcosa che non ha tratti umani. “Ogni cosa si annuncia mentre si sfigura”.
Dialoghi con Amin è un grande e originale poema notturno ed è un poema dell’imminenza. Qualcosa di terribile sta per accadere, ci viene detto e ripetuto. “Amin, è quasi giorno” e noi sentiamo che questo “quasi” è una soglia magica e questo “giorno” muterà la nostra vita, come nelle aubades della poesia provenzale, quando il giungere dell’alba separava gli amanti e li consegnava alla loro solitudine. Qualcosa di immenso sta dunque per compiersi. Ma non sappiamo ancora di cosa si tratta, non riconosciamo il volto del Mutamento. Sappiamo che non è un semplice amore, una semplice morte o una semplice rinascita. Questo ci viene detto più volte. “Credimi, noi non stiamo per rinascere”. E non si tratta nemmeno di un paradiso o di un inferno. No. L’imminenza continua a nascondere i suoi piani e ci lascia all’oscuro, come in una moderna Apocalisse, per citare un’opera cara a Giovanni Ibello. Rimane quest’estrema vigilia nel cuore della notte, rimane “la lesione tellurica del buio”, come scrive il poeta. “Di quello che sognavi veramente / non resta che un silenzio siderale / una lenta recessione delle stelle”. Rimane qualcosa che non ha tratti umani. “Ogni cosa si annuncia mentre si sfigura”.
 Salvatore Ritrovato è poeta e critico. Dopo l’ultima raccolta (L’angolo ospitale, La Vita Felice 2013), ha pubblicato diverse plaquette (l’ultima L’anima o niente, Il Vicolo 2020), e saggi sulla poesia (La differenza della poesia, Puntoacapo 2017; La poesia e la Via. Saggi sulla letteratura e la salvezza, Fara Editore 2020).
Salvatore Ritrovato è poeta e critico. Dopo l’ultima raccolta (L’angolo ospitale, La Vita Felice 2013), ha pubblicato diverse plaquette (l’ultima L’anima o niente, Il Vicolo 2020), e saggi sulla poesia (La differenza della poesia, Puntoacapo 2017; La poesia e la Via. Saggi sulla letteratura e la salvezza, Fara Editore 2020). 









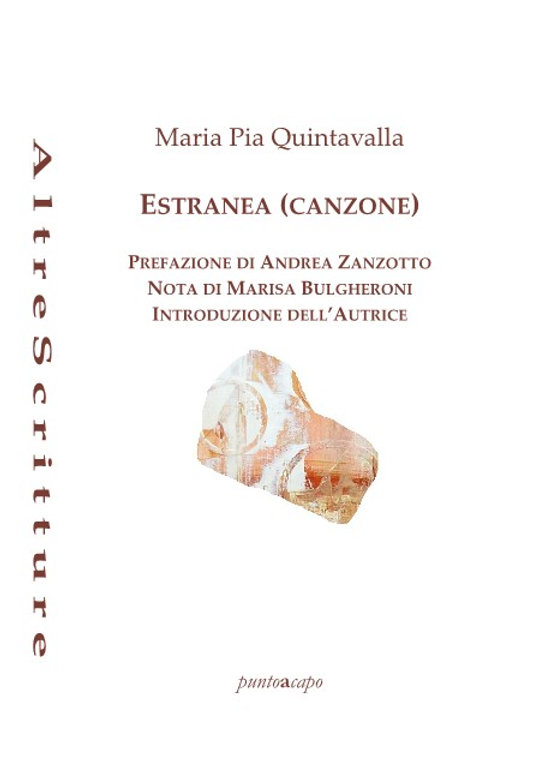

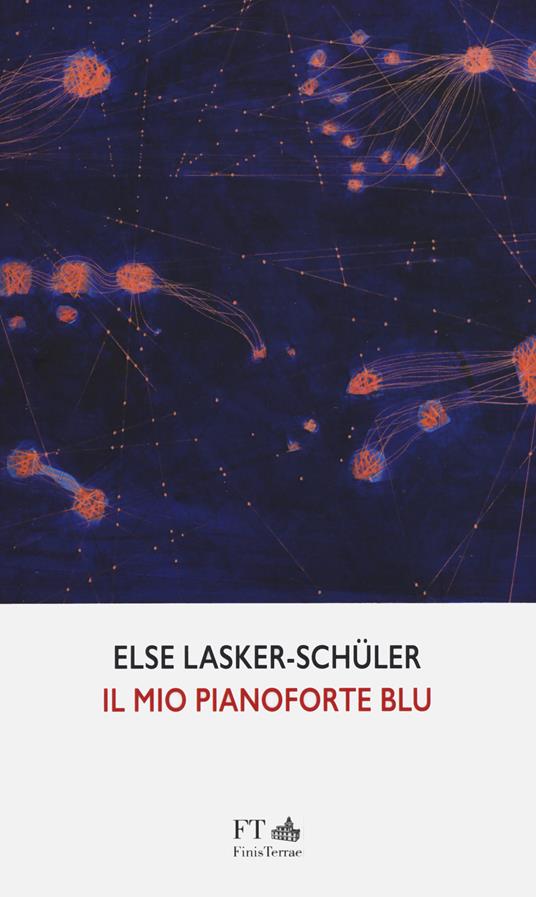
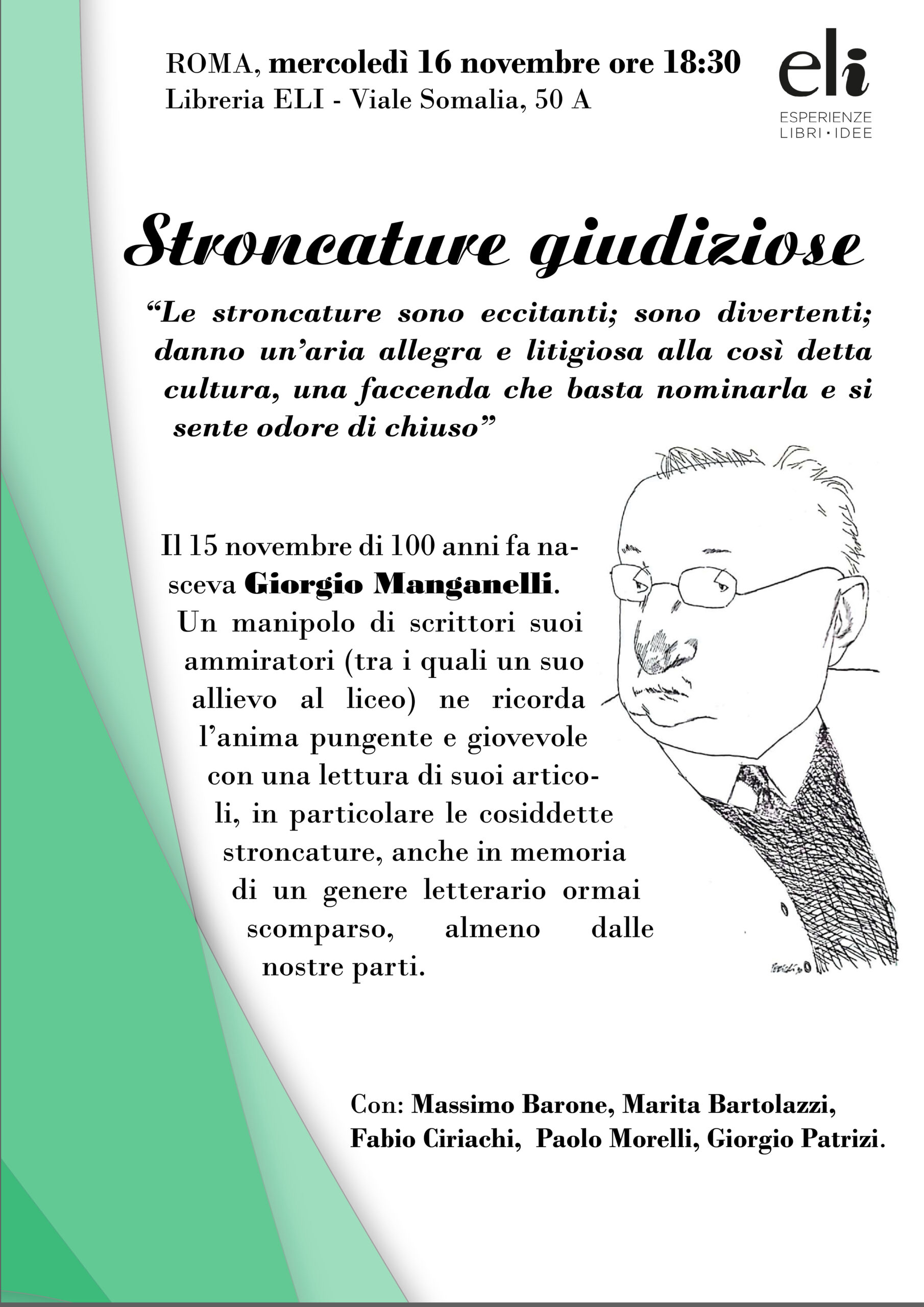

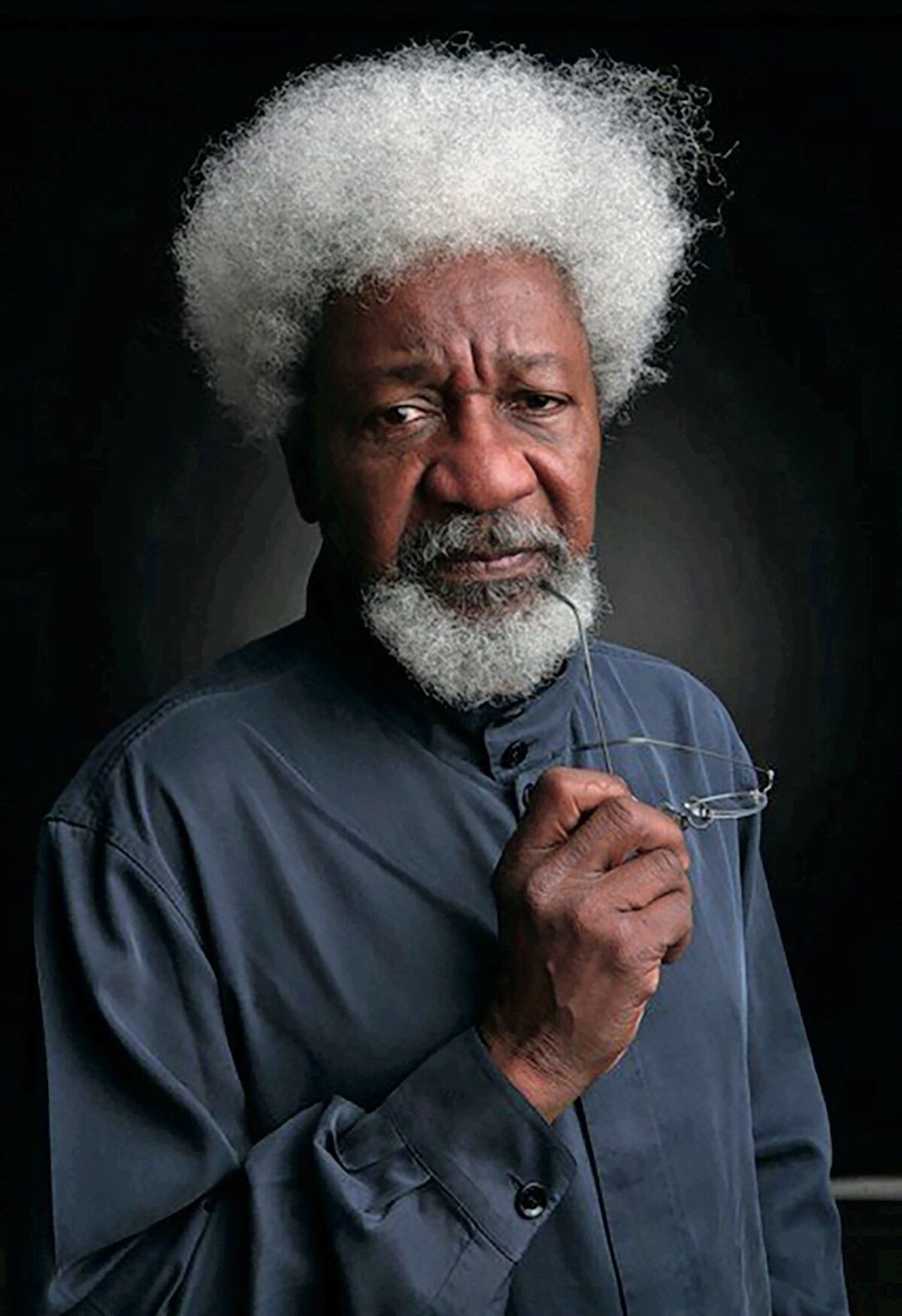


 Dopo lo Strega Europeo, lo Strega Giovani e lo Strega Ragazze e ragazzi arriva un premio dedicato alla valorizzazione dei poeti troppo spesso trascurati dai media, dai lettori e talvolta anche dalla critica, ma che stanno guadagnando sempre più spazio sui social grazie agli instapoet e ad altri fenomeni.
Dopo lo Strega Europeo, lo Strega Giovani e lo Strega Ragazze e ragazzi arriva un premio dedicato alla valorizzazione dei poeti troppo spesso trascurati dai media, dai lettori e talvolta anche dalla critica, ma che stanno guadagnando sempre più spazio sui social grazie agli instapoet e ad altri fenomeni.
 Lingua, cultura e poesia yiddish, testimoni dell’ebraismo in Europa
Lingua, cultura e poesia yiddish, testimoni dell’ebraismo in Europa Dall’XII al XVIII secolo la letteratura in quella lingua comprendeva soprattutto commentari religiosi e pochi testi di narrativa.
Dall’XII al XVIII secolo la letteratura in quella lingua comprendeva soprattutto commentari religiosi e pochi testi di narrativa. Anche il pittore Marc Chagall (Lëzna, 1887 – Saint-Paul-de-Vence, 1985) scrisse poesie in yiddish, mentre l’artista Jacob Vassover (Łódź, 1926 – Tel Aviv, 2008) ebbe il merito di rappresentare in una notevole serie di dipinti a olio (di cui un nucleo consistente e significativo è conservato presso il Thesaurus Memoriae della Cittadella della musica concentrazionaria di Barletta) la vita negli shtetl, sia per osservazione diretta, negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, sia a rappresentazione dell’immaginario tratto dai romanzi e dai racconti di Sholem Aleichem.
Anche il pittore Marc Chagall (Lëzna, 1887 – Saint-Paul-de-Vence, 1985) scrisse poesie in yiddish, mentre l’artista Jacob Vassover (Łódź, 1926 – Tel Aviv, 2008) ebbe il merito di rappresentare in una notevole serie di dipinti a olio (di cui un nucleo consistente e significativo è conservato presso il Thesaurus Memoriae della Cittadella della musica concentrazionaria di Barletta) la vita negli shtetl, sia per osservazione diretta, negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, sia a rappresentazione dell’immaginario tratto dai romanzi e dai racconti di Sholem Aleichem.
