
Edoardo Callegari, foto di proprietà dell’autore
AL CARRO DE LA LUCE
La nudità che appare è una rivelazione; sia così …
Non la parte scoperta di ciò che nell’apparizione non appare, sigillo non apparentis apparitio, ma il vetro dell’aria sospesa divenuto un elemento, qualcosa di lavato con l’apparenza dell’aria.
VERSO GLI OLIVI, A UN COSI’ CALMO ALTROVE
Laniakea
A mio padre
In Omero
le parole per descrivere l’uomo
sono le stesse usate per definire
la luce. E in questo c’è una luce
fermata dall’emulsione di tutto
lo spazio presente e che verrà.
Ed è nella contemplazione estiva,
senza i preparativi necessari
del clima, prima del contemplabile
autunnale più presto pacificato.
Penso al tuo autunno che cade all’unisono
ritraendosi alla luce
per contemplare se stesso
mentre un vacuum ha inizio
dove l’anima cristallina
suddivide la luce nelle idee
di miseria che occupano l’anima,
e un Giordano vivente entra per nutrire
la speranza dove tutto è invito,
qualsiasi fosse la direzione
del ritorno presa dai risanati;
dove un albero della vita cresce
grande quanto un Paradiso Incommensurabile,
tutto divenuto reale nel punto
in cui è mantenuta una promessa;
in un tempo dove l’origine
del tempo sta nelle configurazioni
della incompletezza di una descrizione.
E chiedere più di questo:
che l’aria in serbo per la mattina
non disincarni la sua stessa summa
di cristallo. I nostri giorni avranno
nascite come un addio fedele
è addio alla bianchezza dalla dominanza
del bianco, antecedenti l’una all’altra,
e una tale reticenza
éclaire d’insignifiance
sarà la sola presenza del nostro
mero essere donato
e una risposta, satura di donazione.
Nel senso del solco
Nel senso del solco, ad altezza
del seme, incielata,
è nella parola fatta luce
di nessun excelsior che il predicato
verginale di luce all’aperto,
liberando un cielo, satura il mondo
di una donazione, una casa aperta.
E tu dormi nella mia notte, nata
dal tuo mare sussurrando a occidente,
come un arcipelago
per me di vita nuova.
Tu scolpita di stella
forte, avrai dove posare il capo?
La luce è il luogo in cui l’acqua
La luce
è il luogo in cui l’acqua, nel respiro fresco
delle pietre, può immergere se stessa
solo apparendo.
Lucem
demonstrat umbra. Sia così.
Ma anche l’ombra è mattutina.
E questo ancora può coglierci
sotto un cielo: tenendo il calice
che sta per riempirsi, qualcuno
portando il vischio alla tavola
apparecchiata, farne affluente.
E olio di nozze, che unisce il libro
al cuore d’olivo della casa.
Leggerezza di carità
nel corpo-di-parola
di questa terra, come da un costato.
Acqua benedetta alle mani
e al costato, la giornata intera
a rischiarare l’angelo mentre
ci fa vivere l’abitata,
non la casa. E costellare il libro.
VITANOVAMALASPINA
The Prodigal Pilgrim’s Progress
“Allora rientrò in se stesso e disse:
quanti salariati in casa di mio padre
hanno pane in abbondanza (…)”
(Lc, 15,17)
Ora lascia, Titiro,
che quanto era protetto dal canto
e dava protezione nell’eccellenza
di quiete, diventi un ovunque di esilio,
che compone se stesso come estuario
d’aria, come le scaturenti origini
dell’aria un miserere che colma
la luce ed effonde spogliazione
nella crescita lenta alla brezza
della luce sepolta nei roseti.
Chiedi perché di altri cònsoli saranno
Pascoli di fiori del citiso
e il salice amaro, i giovenchi
che adagiano il fianco candido
sui teneri giacinti,
sotto la freschezza ombreggiante
di un leccio, a ruminare le erbe
pallide, mentre per te è scritto
che hai fatto irrompere tra i fiori, l’Austro
e i cinghiali nelle acque
limpide … Tutto diventi alto mare,
anche nell’eccellenza di erbe morbide
più del sonno. Omnia vel medium fiat
mare, dunque, dove dire
che l’eccellenza dell’onda si rifrange
a riva, significa interromperne
il vero corso. E ora continua,
come se il nome del figlio
della parabola fosse
quello di un efebo in Virgilio
ed il perdono del padre non risuonasse
tanto avanti alle sue parole:
– Devi aver avuto in serbo a lungo
per un racconto estivo, custodita,
una parola che impegnasse, esprimendole,
alla speranza e umiltà, che ora dovremo
riporre da soli e dissigillare;
ora, tornare al centro del proprio clima
senza la parola di festa,
sarà un intorbidire la luce.
Ma in questa nuova solitudine,
il nostro agire più ampio
potrà forse essere la raccolta
nel calice della mente-qoèlet
del desiderio di un infermo,
ad essere quella poca deviazione,
quel clinamen di miseria
che è fermento povero d’un distillato
di compassione, perché un buon nome
è preferibile all’unguento profumato.
– Getta il tuo pane sulle acque,
perché con il tempo lo ritroverai.
Quando servirà che la speranza
e l’umiltà ti dicano
se tu sia stato fedele anche solo
per il puro tentativo
di comprendere ciò di cui sei erede
e che una quieta serenità
a cui ripensi, possa ancora appartenere
ai confini – come ogni figlio appartiene
alla pura grazia dopo la remissione
di una marea di fertilità –
i tuoi predicati della fedeltà,
nitore di qualcosa a te interiore
più che te stesso, saranno
come una dimostrazione della grazia:
come una forza femminile irradiata,
materna o di sorelle, è una sorrisa
parola di luce inaccessibile
verso cui scendere in acqua grave
e colma; chiama tutto ciò, ora sappiamo
entrambi, un’attesa necessaria
come l’in fieri di libertà
spirituale a questa tua stessa età,
a questa pienezza. Non ci sono
più parole se nessuna assenza
fonda l’attesa che esse articolano,
avendo l’apparenza della pietà,
ma rinnegando ciò che ne fa la forza:
espìa per esse una delectio
dal libro della vita. Chiameremo
tutto questo vera fedeltà.
Chiedere di espiare
da quanto è scritto affinché
un padre non abbia il torto di un giudizio
sul popolo e sulla casa.
Chiameremo tutto questo
vera fedeltà. Con la più femminile
delle mani paterne
prendere alla forza dell’angelo
il calice di parole tuffate
dentro al frantoio nel cui fondo
la parola della spremitura
è anche la parola della vera
luminosità dell’olio
e il suo cercare un senso tra occhi afflitti
e solcati, il suo ricordarsi
della vita sparsa che Dio, chinandosi
su di noi, cerca e ricorda,
è già la relazione stessa del senso
e questo canto estivo,
così che le tue api posino
oltre i tassi: “Bruciante non entrare
nella notte per detergere
la materia notturna
con un battesimo di desiderio
che scriva bianco su bianco la fedeltà”.
Una distanza di gru, aironi
cinerini, egrette, nel fulgore
di un ricordo dalla terra prenatale.
Chi riceve? Chi dona? Continua a leggere



 IL LIBRO
IL LIBRO
 PREMESSA
PREMESSA

 ESTRATTO DA “IL GOLEM, L’INTERRUZIONE” di June Scialpi (Fallone Editore, 2022)
ESTRATTO DA “IL GOLEM, L’INTERRUZIONE” di June Scialpi (Fallone Editore, 2022)


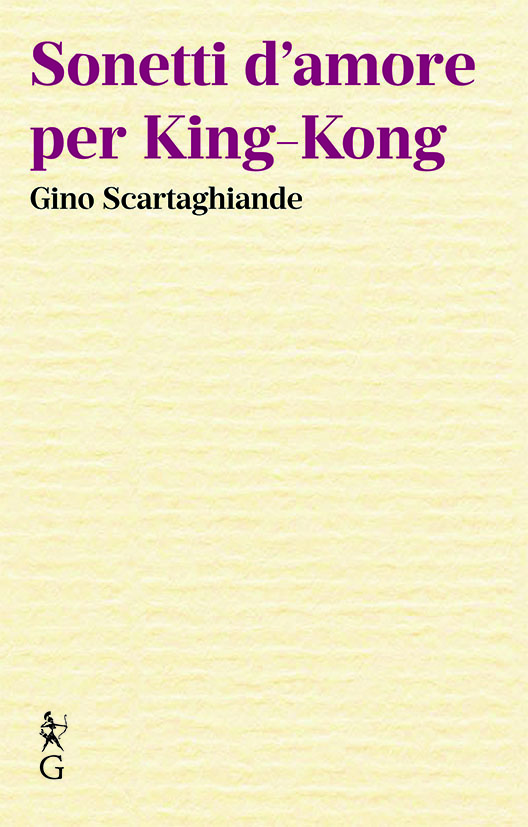

 Il libro è costruito così intorno a un tema originale, mentre viene in qualche modo evitato, ma con grazia, il confronto diretto con le grandi soglie della tradizione poetica occidentale, vale a dire Amore e Morte: eppure non si potrebbe dire che, in qualche modo, i testi di questa raccolta non abbiano a che fare anche con esse. È l’approccio di una penna sensibile sia sul piano umano sia sul piano letterario, che non vuole banalmente ripetere alcuni motivi, ma, se possibile, aggiungere qualcosa agli stessi.
Il libro è costruito così intorno a un tema originale, mentre viene in qualche modo evitato, ma con grazia, il confronto diretto con le grandi soglie della tradizione poetica occidentale, vale a dire Amore e Morte: eppure non si potrebbe dire che, in qualche modo, i testi di questa raccolta non abbiano a che fare anche con esse. È l’approccio di una penna sensibile sia sul piano umano sia sul piano letterario, che non vuole banalmente ripetere alcuni motivi, ma, se possibile, aggiungere qualcosa agli stessi. 








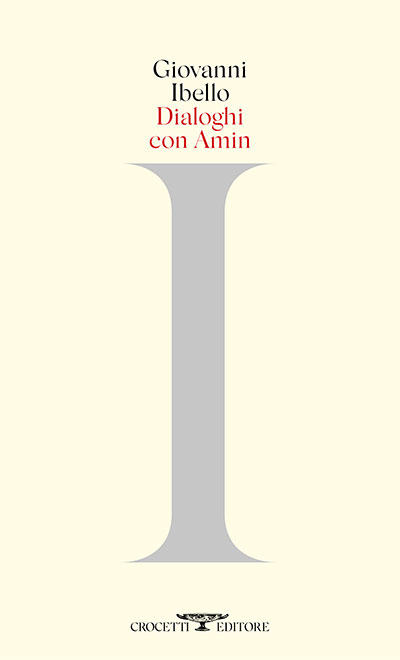 Dialoghi con Amin è un grande e originale poema notturno ed è un poema dell’imminenza. Qualcosa di terribile sta per accadere, ci viene detto e ripetuto. “Amin, è quasi giorno” e noi sentiamo che questo “quasi” è una soglia magica e questo “giorno” muterà la nostra vita, come nelle aubades della poesia provenzale, quando il giungere dell’alba separava gli amanti e li consegnava alla loro solitudine. Qualcosa di immenso sta dunque per compiersi. Ma non sappiamo ancora di cosa si tratta, non riconosciamo il volto del Mutamento. Sappiamo che non è un semplice amore, una semplice morte o una semplice rinascita. Questo ci viene detto più volte. “Credimi, noi non stiamo per rinascere”. E non si tratta nemmeno di un paradiso o di un inferno. No. L’imminenza continua a nascondere i suoi piani e ci lascia all’oscuro, come in una moderna Apocalisse, per citare un’opera cara a Giovanni Ibello. Rimane quest’estrema vigilia nel cuore della notte, rimane “la lesione tellurica del buio”, come scrive il poeta. “Di quello che sognavi veramente / non resta che un silenzio siderale / una lenta recessione delle stelle”. Rimane qualcosa che non ha tratti umani. “Ogni cosa si annuncia mentre si sfigura”.
Dialoghi con Amin è un grande e originale poema notturno ed è un poema dell’imminenza. Qualcosa di terribile sta per accadere, ci viene detto e ripetuto. “Amin, è quasi giorno” e noi sentiamo che questo “quasi” è una soglia magica e questo “giorno” muterà la nostra vita, come nelle aubades della poesia provenzale, quando il giungere dell’alba separava gli amanti e li consegnava alla loro solitudine. Qualcosa di immenso sta dunque per compiersi. Ma non sappiamo ancora di cosa si tratta, non riconosciamo il volto del Mutamento. Sappiamo che non è un semplice amore, una semplice morte o una semplice rinascita. Questo ci viene detto più volte. “Credimi, noi non stiamo per rinascere”. E non si tratta nemmeno di un paradiso o di un inferno. No. L’imminenza continua a nascondere i suoi piani e ci lascia all’oscuro, come in una moderna Apocalisse, per citare un’opera cara a Giovanni Ibello. Rimane quest’estrema vigilia nel cuore della notte, rimane “la lesione tellurica del buio”, come scrive il poeta. “Di quello che sognavi veramente / non resta che un silenzio siderale / una lenta recessione delle stelle”. Rimane qualcosa che non ha tratti umani. “Ogni cosa si annuncia mentre si sfigura”.
 Salvatore Ritrovato è poeta e critico. Dopo l’ultima raccolta (L’angolo ospitale, La Vita Felice 2013), ha pubblicato diverse plaquette (l’ultima L’anima o niente, Il Vicolo 2020), e saggi sulla poesia (La differenza della poesia, Puntoacapo 2017; La poesia e la Via. Saggi sulla letteratura e la salvezza, Fara Editore 2020).
Salvatore Ritrovato è poeta e critico. Dopo l’ultima raccolta (L’angolo ospitale, La Vita Felice 2013), ha pubblicato diverse plaquette (l’ultima L’anima o niente, Il Vicolo 2020), e saggi sulla poesia (La differenza della poesia, Puntoacapo 2017; La poesia e la Via. Saggi sulla letteratura e la salvezza, Fara Editore 2020). 


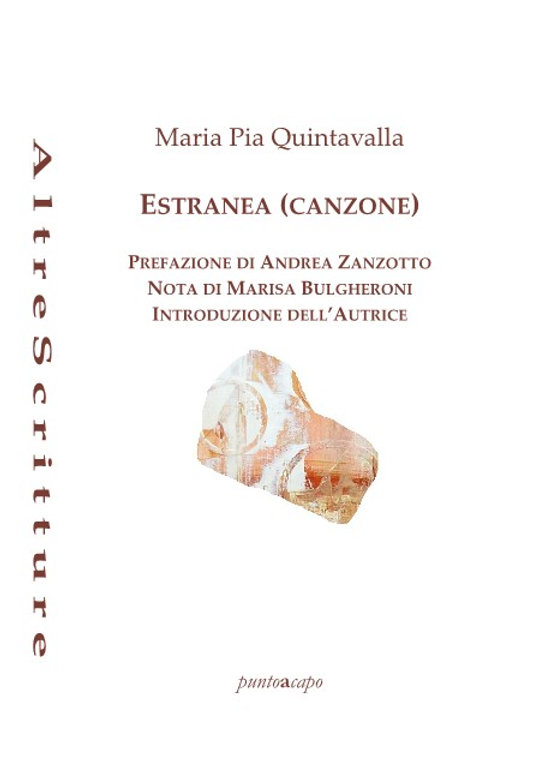




 Dalla prefazione
Dalla prefazione
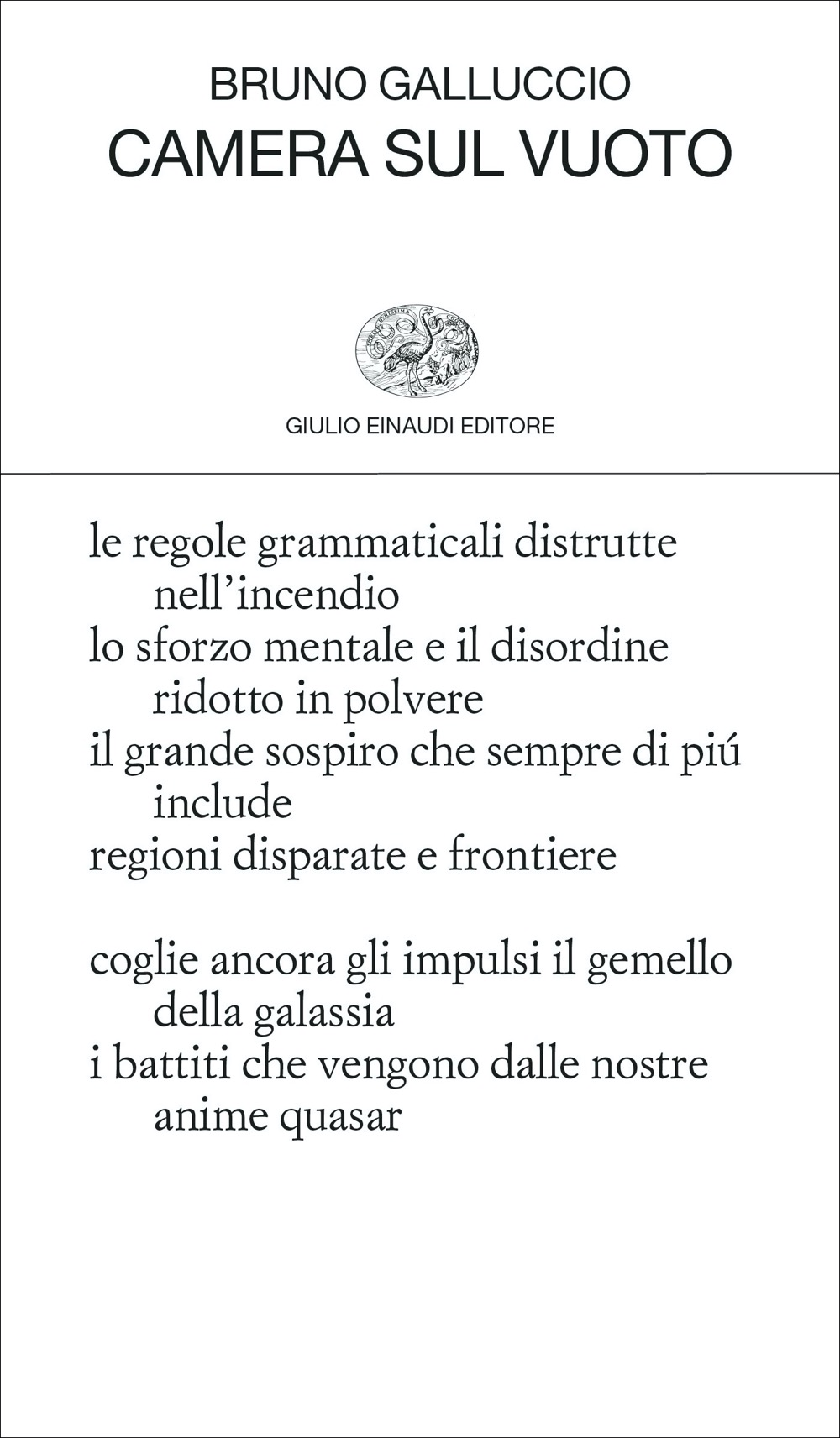





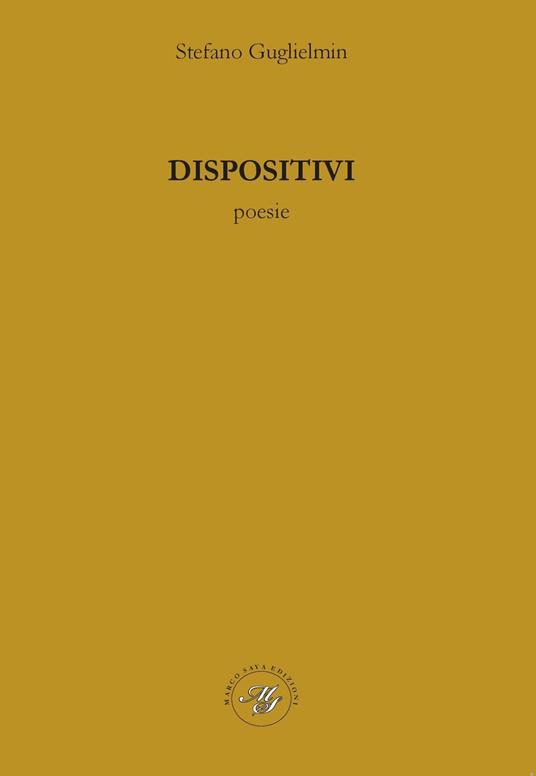 Proteggersi dall’osceno
Proteggersi dall’osceno



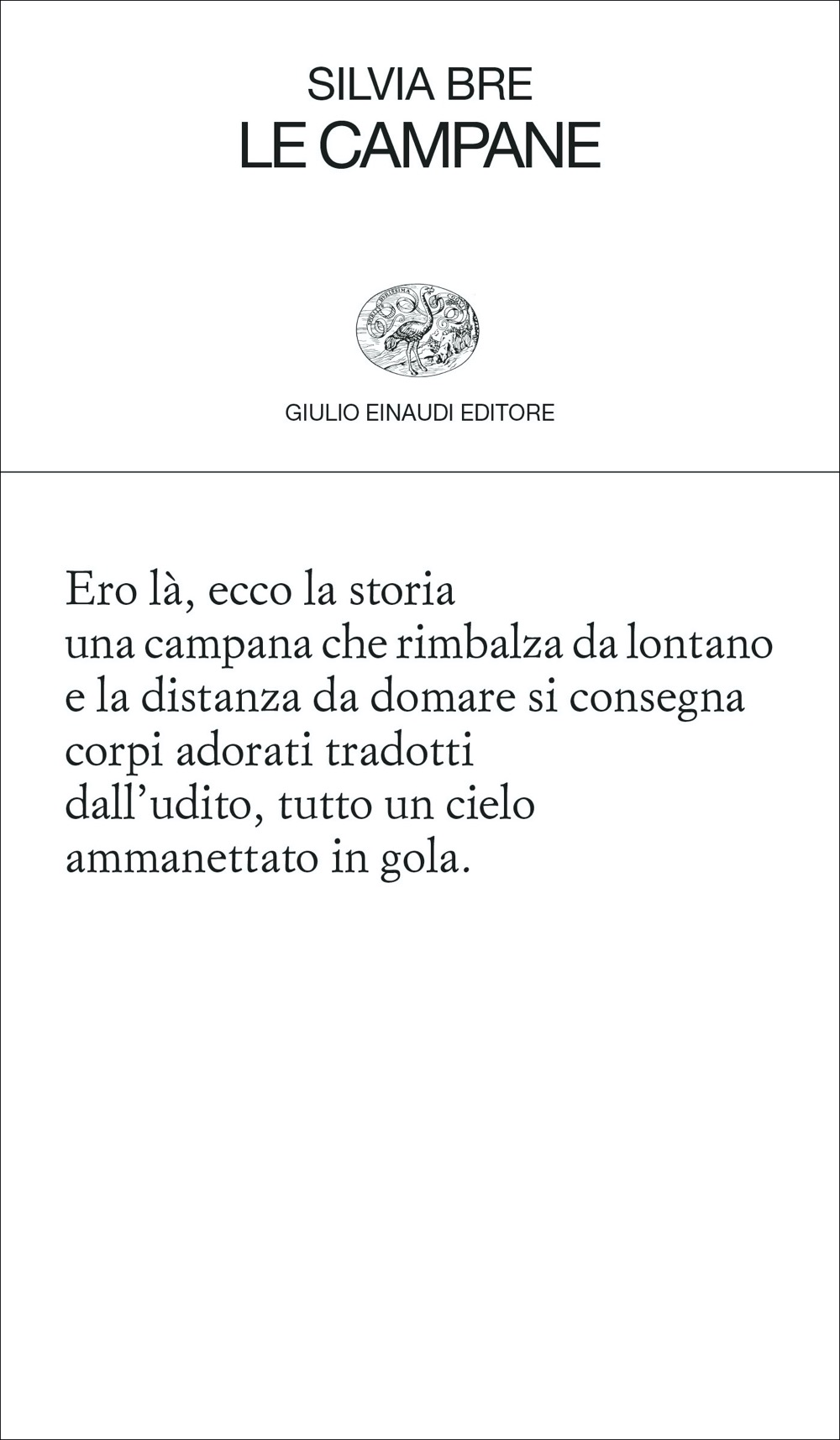

 Finiscono qui i legami tra The Hill We Climb e la Bibbia? Certo che no. Se strizziamo i versi, notiamo che gocciolano di sintagmi, parole-tenda, elementi morfologici i cui detergenti e additivi sono Vecchio e Nuovo Testamento. Ecco una rapida carrellata: «Nasce il giorno» (nell’originale «When day comes») corrisponde a Giovanni 14,20 «When that day comes», secondo la Bibbia di Re Giacomo fruibile in USA; nella formula idiomatica «il ventre della bestia» allignano Giona 2,1 «Giona restò nel ventre del pesce» e Apocalisse 13,1 «vidi salire dal mare una bestia»; l’«unione perfetta» richiama 1Corinzi 1,10 «siate in perfetta unione di pensiero e di intenti»; «alziamo i nostri sguardi non / su ciò che si frappone tra noi» è parallelo a 2Corinzi 4,18 «perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili»; in «un’ora di così grande terrore» riecheggia Luca 22,53 «ma questa è l’ora vostra e il potere delle tenebre». Si va avanti a lungo smerigliando la Genesi, Geremia, la Lettera ai Romani. Ma facciamo soltanto due esempi che riguardano la chiusa.
Finiscono qui i legami tra The Hill We Climb e la Bibbia? Certo che no. Se strizziamo i versi, notiamo che gocciolano di sintagmi, parole-tenda, elementi morfologici i cui detergenti e additivi sono Vecchio e Nuovo Testamento. Ecco una rapida carrellata: «Nasce il giorno» (nell’originale «When day comes») corrisponde a Giovanni 14,20 «When that day comes», secondo la Bibbia di Re Giacomo fruibile in USA; nella formula idiomatica «il ventre della bestia» allignano Giona 2,1 «Giona restò nel ventre del pesce» e Apocalisse 13,1 «vidi salire dal mare una bestia»; l’«unione perfetta» richiama 1Corinzi 1,10 «siate in perfetta unione di pensiero e di intenti»; «alziamo i nostri sguardi non / su ciò che si frappone tra noi» è parallelo a 2Corinzi 4,18 «perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili»; in «un’ora di così grande terrore» riecheggia Luca 22,53 «ma questa è l’ora vostra e il potere delle tenebre». Si va avanti a lungo smerigliando la Genesi, Geremia, la Lettera ai Romani. Ma facciamo soltanto due esempi che riguardano la chiusa. 






