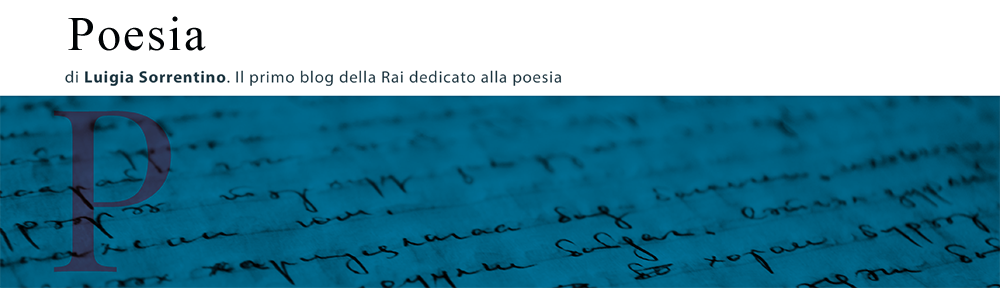Marco Bini, foto di proprietà dell’autore
New Jersey di Marco Bini – Note a margine
di Federico Carrera
«Il vero simbolo della provincia è essere incapace di narrare la propria storia». Il New Jersey di Marco Bini (Interno Poesia, 2020) si apre con queste parole, intense ma fulminanti, del fotografo Luigi Ghirri. Dico fulminanti proprio perché, poste in esergo a questa raccolta di poesia, sembrano guadagnare un nuovo significato, ancora più autentico – se possibile – dell’originario. Sono parole messe al posto giusto. E Marco Bini lo sa. Perché nella sua poesia non è dato l’evento casuale, incastrato fuori posto: tutto è ben dosato, a partire dalla costruzione di versi piani, mimesi di un discorso disteso, capace di far convivere affondi narrativi con picchi del più alto lirismo, il tutto in un tono da quotidianità dimessa, ma non degradata. Fino ad arrivare a una struttura solida, che rende il dipanarsi dei testi di poesia quasi un percorso ben guidato all’interno di una storia che lentamente è in grado di avvolgere il lettore, come fosse una narrazione. Ma è invece una poesia capace di rivelare, in pillole, una saggezza autentica e profonda, che ricorda quella di alcuni poeti antichi, come Orazio.
Gli oggetti, nella provincia che è teatro di questo New Jersey, assumono sempre un significato emblematico. Così i cartelli stradali diventano «costole» che «spalancano al cuore spazio per pulsare», l’«ossigeno» dell’ora del tramonto è «notte» che sparisce velocemente, «la torre dell’Unipol» di Bologna è «Rothko, Gramsci, Montale tutti assieme», e via dicendo. Ma gli oggetti sono emblemi che possono solo apparentemente mediare un rapporto di profonda incomunicabilità tra l’io e le cose del mondo. In effetti, il tema che domina la raccolta – e sul quale la raccolta stessa si fonda – sembra essere quello della distanza. Una distanza che può venire proiettata geograficamente, temporalmente o anche astrattamente. È lo iato che s’instaura inevitabilmente tra gli oggetti e l’io, che ne marca i confini, ne sottolinea le differenze. È il senso di vuoto che permea l’umano e lo rende in qualche modo diverso, forse completo. Ecco che appare limpido il senso delle parole di Ghirri: la provincia è lo stato esistenziale in cui si trova l’uomo, in rapporto di costante vicinanza-e-lontananza dalle cose. E il New Jersey diventa, in questo gioco di metafore, uno stato esistenziale prima ancora che uno Stato geografico e fisico: è la provincia per antonomasia, il luogo dal quale si osservano accadere le cose ‘che contano’, da cui si può ammirare una fucina di luce e di vita come quella di una altrettanto esistenziale Manhattan («il centro dove agglomerarsi / nel nucleo vulcanico dove fabbricano la luce»).
 Il libro è costruito così intorno a un tema originale, mentre viene in qualche modo evitato, ma con grazia, il confronto diretto con le grandi soglie della tradizione poetica occidentale, vale a dire Amore e Morte: eppure non si potrebbe dire che, in qualche modo, i testi di questa raccolta non abbiano a che fare anche con esse. È l’approccio di una penna sensibile sia sul piano umano sia sul piano letterario, che non vuole banalmente ripetere alcuni motivi, ma, se possibile, aggiungere qualcosa agli stessi. Continua a leggere
Il libro è costruito così intorno a un tema originale, mentre viene in qualche modo evitato, ma con grazia, il confronto diretto con le grandi soglie della tradizione poetica occidentale, vale a dire Amore e Morte: eppure non si potrebbe dire che, in qualche modo, i testi di questa raccolta non abbiano a che fare anche con esse. È l’approccio di una penna sensibile sia sul piano umano sia sul piano letterario, che non vuole banalmente ripetere alcuni motivi, ma, se possibile, aggiungere qualcosa agli stessi. Continua a leggere