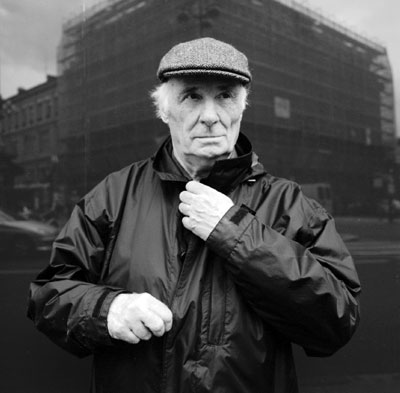
Jacques Roubaud (foto d’archivio)
Questo libro di Jacques Roubaud nasce da un lavorìo comune in cui entrambi i traduttori, Domenico Brancale e Tommaso Santi hanno preso in carico ogni verso prestando la propria voce a ciò che può comportare una traduzione: accettare la resa di fronte al ritmo, alla musica, alle rime della lingua originale. Fedeltà e tradimento quando si traduce sono due vie di uno stesso volto. Il volto della parola. Nella fedeltà si tradisce la propria lingua rimanendo fedeli alla lingua altrui, nel tradi- mento si tradisce la lingua altrui rimanendo fedeli alla propria. Sempre si rinuncia a qualcosa. Sempre si libera una voce. Tradurre “Quelque chose noir” è stato soprattutto questo: fare i conti con una terza lingua, il francese di Jacques Roubaud. Parlare per conto di Roubaud con la propria voce significa accettare la sfida dell’oscurità. Ogni poesia è tale. Ogni parola ha conosciuto il tempo in cui è rimasta muta per parlare. Ci sono stati momenti in cui ricorrere ad altre voci è stata l’unica via di fuga dai punti ciechi della traduzione. Per questo desideriamo ringraziare Bruno di Biase, Hervè Bordas, Adriano Marchetti, Anna Ruchat e Sarah Veronesi.
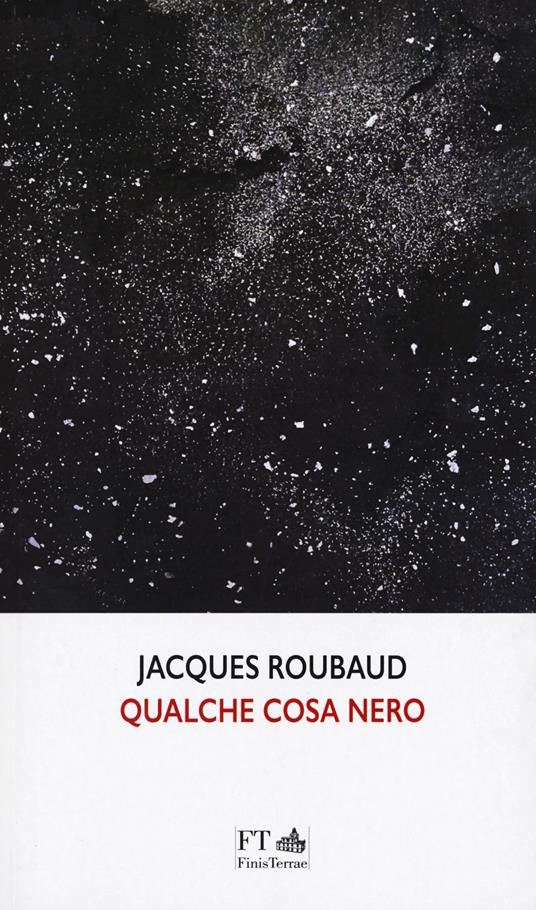
IL LIBRO
Un uomo ha perduto la sua donna ed esprime, riga dopo riga, il dolore della sua assenza, il dolore più difficile da scrivere. L’uomo è il poeta Jacques Roubaud, la donna è la fotografa Alix Cléo Roubaud. Qualche cosa nero, pubblicato nel 1986, è il libro del lutto della poesia.
Il poeta rivela l’entità del suo dolore, gli effetti della morte e dell’assenza sulla vita e sul linguaggio: essi appaiono proprio come il negativo – inverso della luce, bianco e nero che si scambiano – rivela l’immagine. Dietro ogni verso del poeta ci sono le mani, il ventre, il corpo della donna amata. Alla fine, dopo «il punto vacillante del dubitare di tutto», dopo «l’inframondo», ciò che appare, è «Niente», titolo dell’ultima sezione.
Dire la morte dell’essere amato è convincere il silenzio a testimoniare perché, come dice Roubaud «la poesia è memoria della lingua». Questo libro è il dialogo postumo in cui «l’inchiostro e l’immagine si ritrovano solidali e alleati», è il tentativo, privo di consolazione, di ritornare nel presente, il tempo del «tu», l’unico tempo possibile in cui poter realizzare l’«io». Esperienza di vertigine, di paura, di bellezza, Qualche cosa nero si può leggere soltanto tremando.
ESTRATTI
Je voulais détourner son regard à jamais
Je voulais détourner son regard à jamais. je voulais être seul au monde à ne pas avoir vu du tout. cette main aurait pu ne pas être là, après tout: mais moi non plus, et avec moi disparaître le monde. ce cadeau. l’image de ta mort.
Elle avait aimé la vie passionnément de loin. sans l’im- pression d’y être ni d’en faire partie. malheureuse, elle photographiait des pelouses tranquilles et du bonheur fa- milial. extase paradisiaque, elle photographiait la mort et sa nostalgie.
Pour une fois adéquation exacte de la mort même à la mort rêvée, la mort vécue, la mort même même. Identique à elle même même.
Gouffre pur de l’amour.
S’endormir comme tout le monde. ce que je veux.
Je t’aime jusque là.
Évidemment ce n’était pas un cadeau ordinaire. celui de me livrer, à cinq heures du matin, un vendredi, l’image de ta mort.
Pas une photographie.
La mort même même. identique à elle même même.
°
Volevo allontanare per sempre il suo sguardo
Volevo allontanare per sempre il suo sguardo. volevo essere l’unico al mondo a non aver visto nulla. quella mano avrebbe potuto non esserci, dopotutto: e anche io, e con la mia scomparsa il mondo. questo regalo. l’immagine della tua morte.
Da lontano appassionatamente lei aveva amato la vita. senza l’impressione di esserci o di farne parte. infelice, fotografava prati tranquilli e felicità familiare. Estasi paradisiaca, fotografava la morte e la sua nostalgia.
Per una volta l’adeguamento perfetto della morte stessa alla morte immaginata, la morte vissuta, proprio la morte stessa. Identica proprio a se stessa.
Puro abisso dell’amore.
Addormentarsi come fanno tutti. quel che voglio.
Ti amo fino a quel punto.
Ovviamente non era un regalo qualsiasi. quello di lasciarmi, alle cinque del mattino, un venerdì, l’immagine della tua morte.
Non una fotografia.
Proprio la morte stessa. identica proprio a se stessa.
***
Mort
Ta mort parle vrai. ta mort parlera toujours vrai. ce que parle ta mort est vrai parcequ’elle parle. certains ont pensé que la mort parlait vrai parceque la mort est vraie. d’autres que la mort ne pouvait parler vrai parceque le vrai n’a pas affaire avec la mort. mais en réalité la mort parle vrai dès qu’elle parle.
Et on en vient à découvrir que la mort ne parle pas virtuellement, étant ce qui arrive, effective au regard de l’être. ce qui est le cas.
Ni une limite ni l’impossible, dérobée dans le geste de l’appropriation répétitive, puisque je ne peux aucunement dire : c’est là.
Ta mort, de ton propre aveu, ne dit rien? elle montre. quoi? qu’elle ne dit rien. mais aussi qu’en montrant elle ne peut pas non plus, du même coup, s’abolir.
« Ma mort te servira d’élucidation de la manière sui- vante : tu pourras la reconnaître comme dépourvue de sens, quand tu l’auras gravie, telle une marche, pour at- teindre au-delà d’elle (jetant, pour ainsi dire, l’échelle). » je ne crois pas comprendre cela.
Ta mort m’a été montrée. Voici : rien et son envers : rien.
Ni ce qui arrive ni ce qui n’arrive pas. tout le reste de- meurant égal.
Dans ce miroir, circulaire, virtuel et fermé. le langage n’a pas de pouvoir.
Quand ta mort sera finie. et elle finira parcequ’elle parle. quand ta mort sera finie. et elle finira. comme toute mort. comme tout.
Quand ta mort sera finie. je serai mort.
°
Morte
La tua morte dice il vero. la tua morte dirà sempre il vero. ciò che dice la tua morte è vero perché dice. certi han- no pensato che la morte dicesse il vero perché la morte è vera. altri che la morte non potesse dire il vero perché il vero non ha a che vedere con la morte. ma in realtà la morte dice il vero appena parla.
E si arriva a scoprire che la morte non dice virtualmente, essendo ciò che succede, effettiva nei confronti dell’es- sere. come in questo caso.
Né un limite né l’impossibile, sottratta nel gesto dell’appropriazione ripetitiva, dato che non posso in nessun modo dire: è qui.
La tua morte, per tua stessa ammissione, non dice niente? mostra. cosa? che non dice niente. ma anche che, mostrando, non può nemmeno, al contempo, annullarsi.
«La mia morte ti servirà da chiarimento in questo modo: potrai riconoscerla come priva di senso, quando l’avrai risalita, come un gradino, per andare oltre (e per così dire, buttare via la scala).» non credo di capire.
La tua morte mi è stata mostrata. Ecco: niente e il suo contrario: niente.
Né ciò che succede né ciò che non succede. mentre tutto il resto rimane uguale.
In questo specchio, circolare, virtuale e chiuso. il linguaggio non ha potere.
Quando la tua morte sarà finita. e finirà perché dice. quando la tua morte sarà finita. e finirà. come ogni morte. come tutto.
Quando la tua morte sarà finita. sarò morto. Continua a leggere
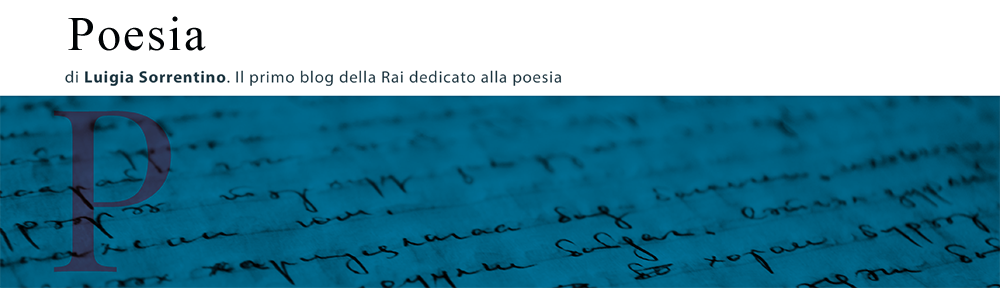


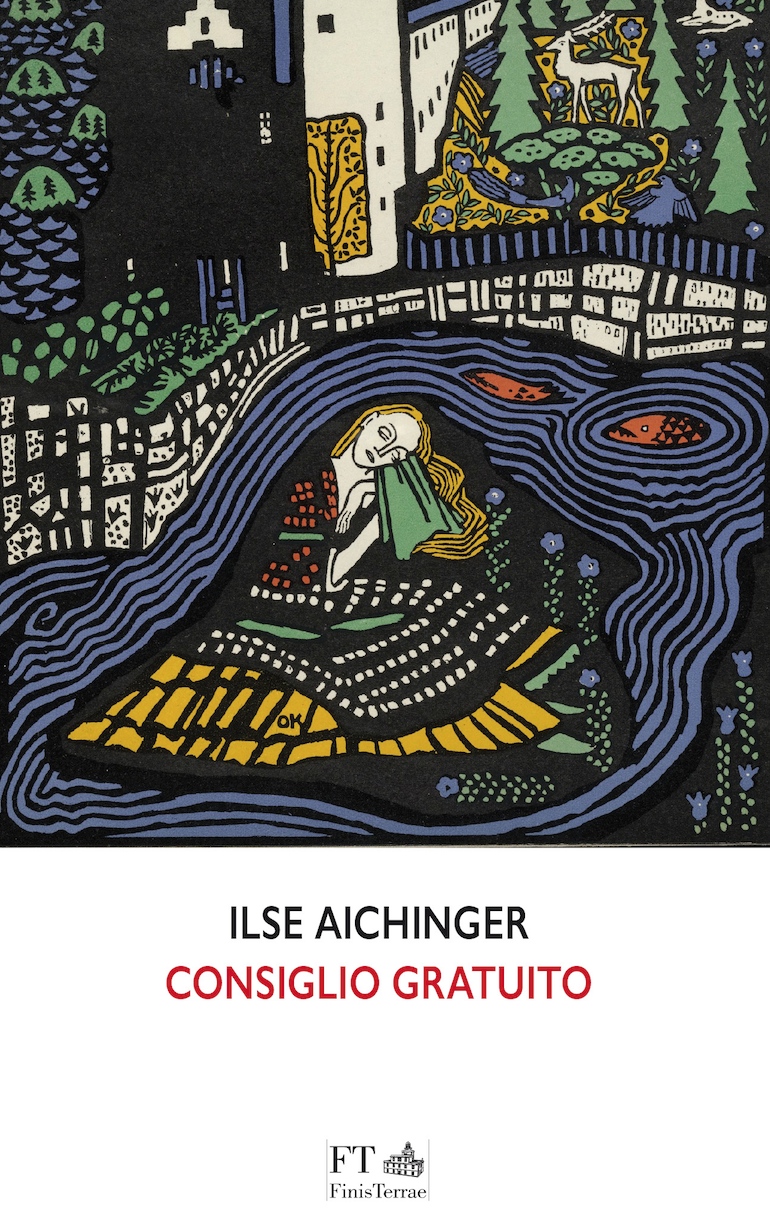

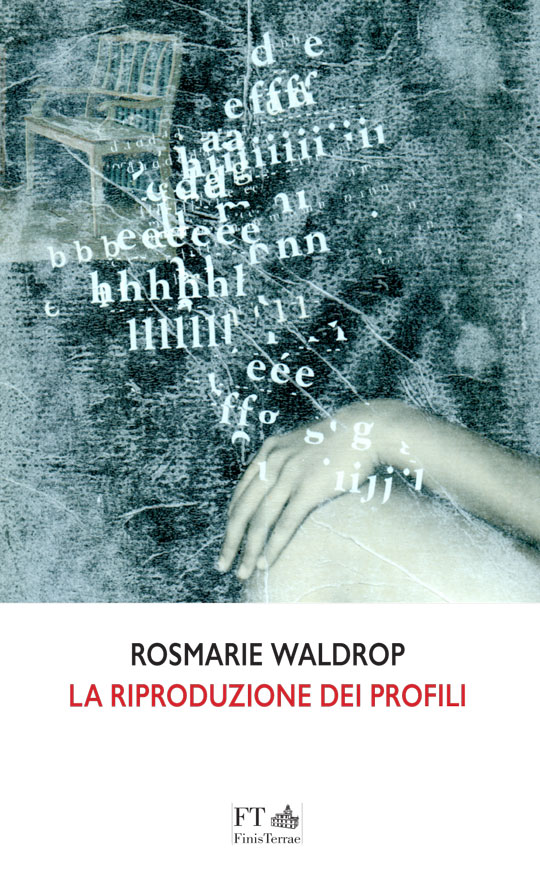
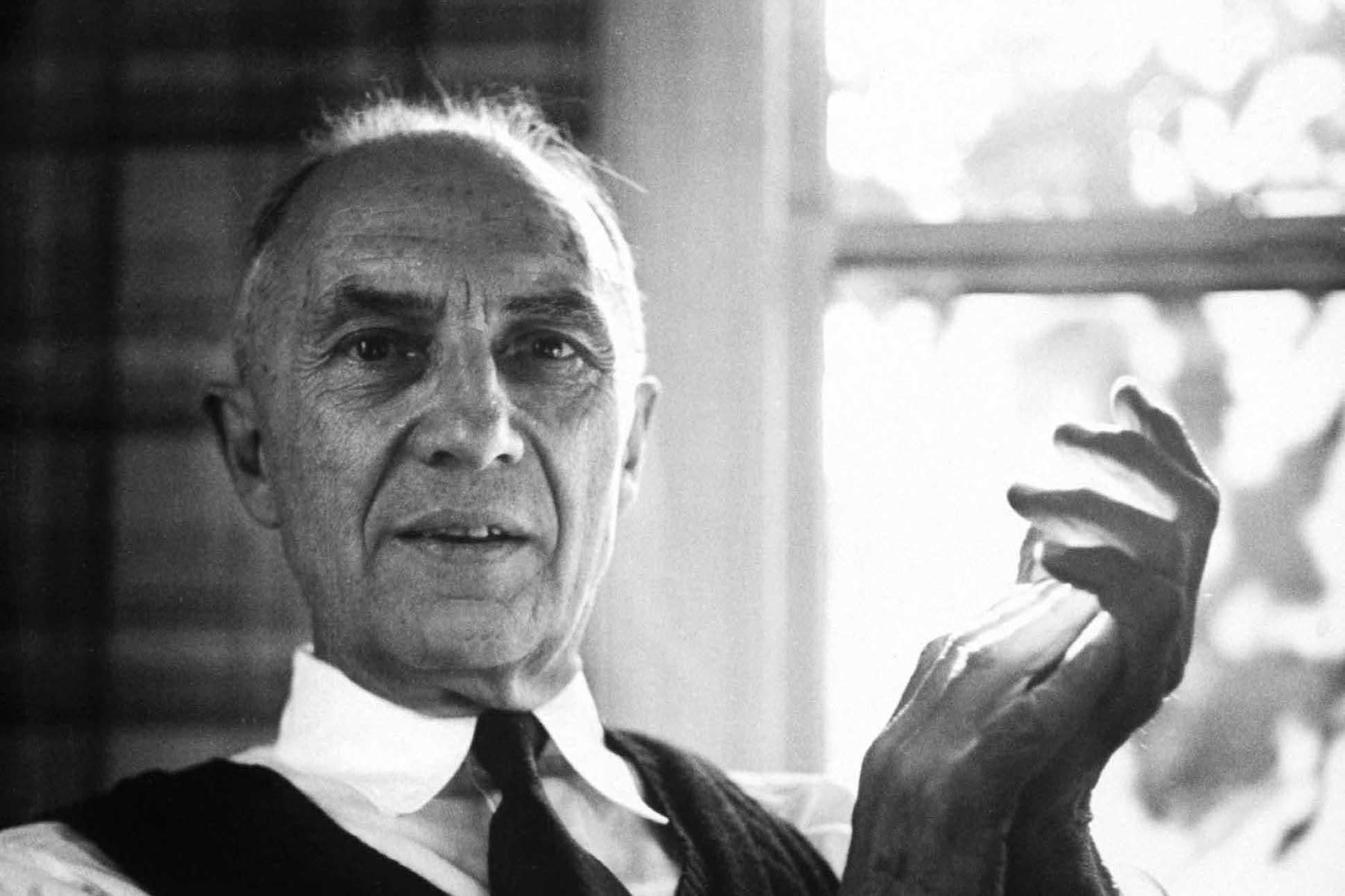

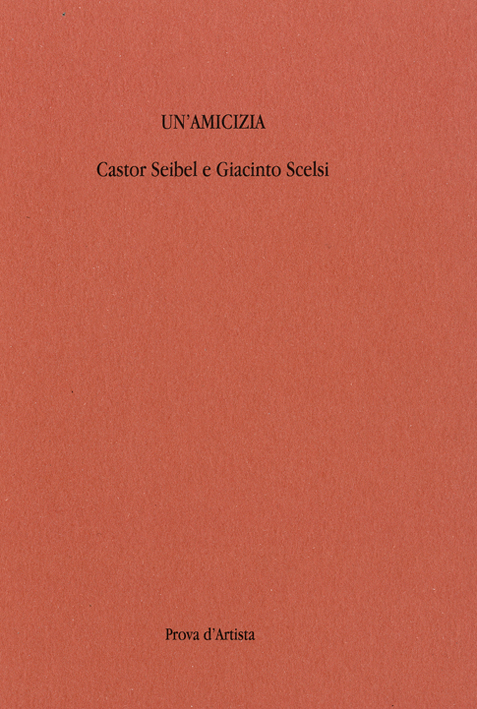



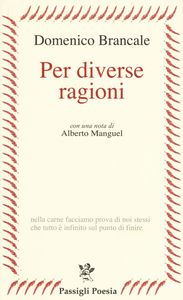 Dalla nota di Alberto Manguel
Dalla nota di Alberto Manguel![L'Italia a pezzi[1]](https://www.luigiasorrentino.it/wp-content/uploads/2014/10/LItalia-a-pezzi1-201x300.jpg)