
Giovanna Sicari, Credits ph. Dino Ignani
NOTA DI LETTURA DI MONICA ACITO
Non tutte le donne amate dai poeti si nascondono tra le righe.
Alcune di loro sono fatte solo di inchiostro, altre tremano insieme alla carta.
Altre ancora riposano, dolcemente, tra un verso e l’altro, in attesa che una mano le sfiori per richiamarle alla vita.
Giovanna Sicari non è stata semplicemente la donna di Milo De Angelis, uno dei poeti viventi più importanti della nostra tradizione letteraria: questa veste non le si addice e sta stretta al suo ricordo, che è vivo e selvaggio, come certi frutti di mare che si trovano solo nella sua Puglia.
Giovanna Sicari non è stata mai un attributo o un complemento d’arredo; non è mai stata solo una semplice musa, ma è stata Calliope in persona.
Nata a Taranto nel 1954, in un sud arcaico che profumava del sale dello Ionio, Giovanna Sicari si trasferisce a Roma da piccola, nel quartiere Monteverde.
Il fondale marino della Puglia, prematuramente abbandonato, scorrerà continuamente sotto la pelle della poetessa, pronto a sgorgare, rompere argini e creare crepe nella parola.
Il litorale ionico, salutato a otto anni, rimarrà rannicchiato per sempre in uno stadio prenatale della sua memoria, dove si annidano soltanto i ricordi rimossi e l’acqua del battesimo.
Il mare e l’abisso del sud ritornano nei versi di Sicari con una prepotenza quasi rabbiosa, che ricorda la fusione pànica di alcune liriche di “Alcyone” (1903) di D’Annunzio, in particolare “Meriggio”.
D’Annunzio compie una metamorfosi con il paesaggio marino, dissolvendosi nel suo “mare etrusco” e disperdendo nell’acqua, i suoi connotati
E sento che il mio vólto
s’indora dell’oro
meridiano,
e che la mia bionda
barba riluce
come la paglia marina;
(Gabriele D’Annunzio, Meriggio, Alcyone, 1903)
Allo stesso, modo, Sicari, lascia che il mare e il mito della sua infanzia le modellino i fianchi; compie un vero e proprio matrimonio con i luoghi che hanno segnato la sua storia.
Sicari è poetessa e sposa:
Non toccarmi con forza
nel lago del sogno della di lui promessa terra desolata
sono promessa sposa nel fondale marino di un bordello:
immancabile è la vertigine,
lo stile appreso è il giusto spavento.
(Giovanna Sicari, “Poesie 1984-2003”, a cura di R. Deidier, Roma, Empirìa, 2006)
Sicari, però, compie un passaggio in più: riesce a trasportare i luoghi marini della sua prima infanzia nel quartiere di Monteverde a Roma, che diventa l’altare ufficiale della sua storia personale, il cerchio da cui partire, per poi girare in tondo e morire.
Monteverde, Monteverde, Monteverde: Sicari ripeteva il nome del suo quartiere come se fosse stata una formula sciamanica o un rito apotropaico.
Mugolava, si passava Monteverde tra la lingua e il palato, nello stesso modo in cui Cesare Pavese sussurrava, tra i denti, le poesie dedicate alle sue campagne delle Langhe piemontesi.
Proprio così lei pronunciava il nome del suo quartiere, come un “talismano contro infelicità e timore”.
A Roma si iscrive a Lettere, vive l’epoca della contestazione giovanile militante e impara la natura “politica” della parola poetica. Continua a leggere→

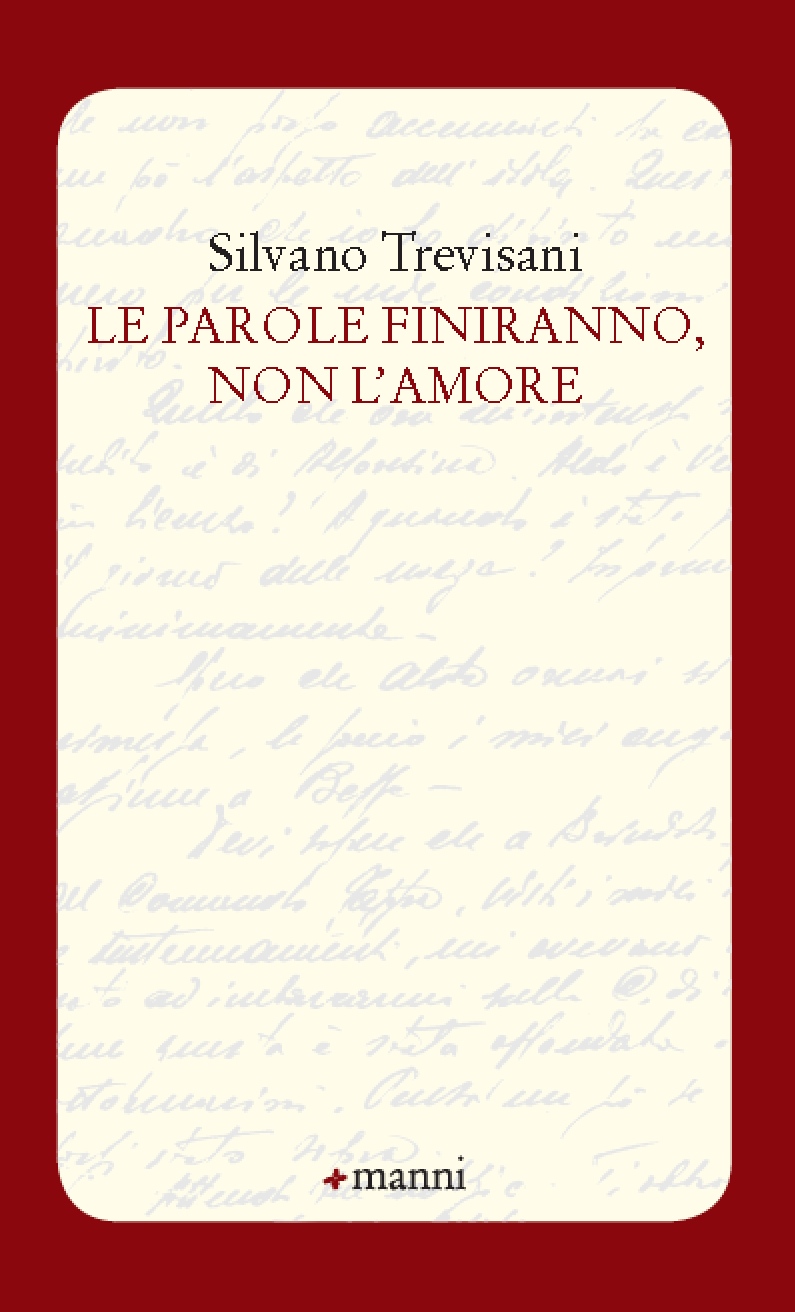
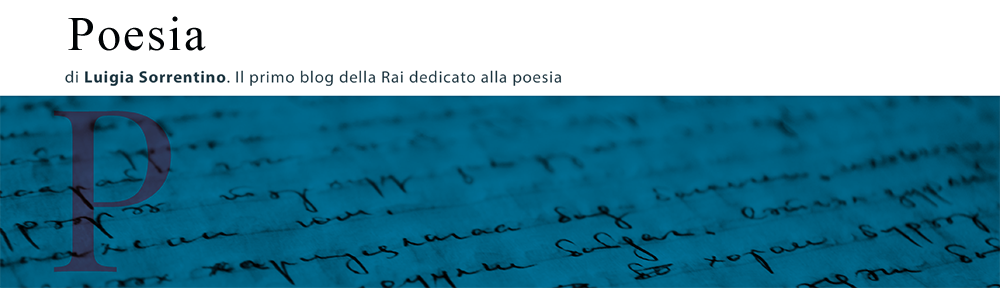

 La notte romana getta nell’acqua della madre dopo le madri
La notte romana getta nell’acqua della madre dopo le madri





