 Martedi 8 giugno ore 21:00 alla Casa della Poesia di Milano (Palazzina Liberty, Largo Marinai d’Italia 1) “Parola di poeta, Giovanni Raboni”, a cura di Maurizio Cucchi.
Martedi 8 giugno ore 21:00 alla Casa della Poesia di Milano (Palazzina Liberty, Largo Marinai d’Italia 1) “Parola di poeta, Giovanni Raboni”, a cura di Maurizio Cucchi.
Una serata dedicata alla figura del poeta e intellettuale milanese.
Interventi di: Maurizio Cucchi, Giancarlo Majorino, Patrizia Valduga, Cesare Viviani.
Letture di: Fabrizio Bernini, Amos Mattio, Mary Barbara Tolusso.
AUTORITRATTO
di Giovanni Raboni
Quando io sono nato, i miei genitori abitavano in via San Gregorio. Era una casa né vecchia né nuova, credo che risalisse – come tante altre case in quella zona di Milano – agli anni intorno alla prima guerra mondiale. Una volta, da quelle parti, c’era la stazione ferroviaria; credo che dalle finestre di casa mia si vedessero i binari. Ma nel 1932, quando io sono nato, i binari non si vedevano più, non c’erano più: e dalla finestra della stanza dove dormivo con mio fratello più grande si guardava su un terreno vago che ricordava la periferia anche se, in realtà, non eravamo in periferia. Questo terreno vago si animava – soprattutto di pomeriggio, e soprattutto di sabato pomeriggio – di giochi di ragazzi. Giocavano al pallone, alla guerra, agli indiani. Forse dovrei dire: giocavamo; mi sembra molto probabile di aver partecipato a quei giochi, ma non ne ho nessun ricordo preciso. Quello che ricordo, invece, è di aver guardato altri ragazzi giocare. Erano giochi deliziosi. Quella finestra è, sicuramente, uno dei luoghi, o meglio delle situazioni, che mi hanno spinto a voler essere un poeta, a voler scrivere delle poesie. Per molto tempo ho pensato che una poesia dovesse essere come quella finestra. Mi sembrava che una poesia fosse un vetro attraverso il quale si potevano vedere molte cose – forse, tutte le cose; però un vetro, e il fatto che il vetro fosse trasparente non era più importante del fatto che il vetro stesse in mezzo, che mi isolasse, mi difendesse. I giochi erano al di là del vetro, mentre io ero al di qua. Credo che non riuscirò mai a far capire la straordinaria delizia di questa situazione. Quello che è certo, comunque, è che quando ho cominciato a scrivere poesie la mia più grande aspirazione era di ritrovare quel tipo di delizia o, se si vuole, di privilegio. Di ogni poesia avrei voluto fare un osservatorio difesissimo e trasparente, un osservatorio per guardare la vita – cioè, forse, per non viverla. Naturalmente, la storia di quella che io considero adesso la mia poesia comincia dopo; comincia, immagino, proprio con la negazione, con la rinuncia a tutto questo: la finestra, l’osservatorio, la trasparenza. Ma la faccenda non dev’essere ancora del tutto risolta, almeno nel mio inconscio, se ancora pochi anni fa mi è capitato di scrivere questa poesia dopo averla, credo, almeno in parte, veramente sognata.
Come cieco, con ansia, contro
il temporale e la grandine, una
dopo l’altra chiudevo
sette finestre.
Inportava che non sapessi quali.
Solo all’alba, tremando,
con l’orrenda minuzia di chi si sveglia o muore,
capisco che ho strisciato
dentro il solito buio,
via San Gregorio primo piano.
Al di qua dei miei figli,
di poter dare o prendere parola.
La vera storia della mia poesia comincia con la rinuncia al sogno di felice autoemarginazione che ha dominato la mia adolescenza e che appartiene, forse, agli inizi di ogni poeta. È inutile precisare che questa rinuncia ha coinciso, per me, con l’ingresso nell’età adulta. Piuttosto vorrei cercare, e non solo per civetteria o per nostalgia, di legare anche questa fase diversa e più matura della mia poesia e della mia vita al luogo dove sono nato – alla mia città e, dentro la mia città, alla mia casa. Nel 1821, quando morto, il grande poeta milanese Carlo Porta è stato sepolto nel cimitero di San Gregorio. E io vorrei ricordare di sfuggita che proprio con Porta comincia, nella poesia italiana, quella tradizione lombarda che passa attraverso Manzoni e arriva fino a Tessa, a Sereni, a Rebora, che credo sia qualcosa di sostanzialmente diverso da quella che la storiografia dei Novecento intende come “linea lombarda” – che non ho mai capito bene cosa sia.
Poi, sul conto di via San Gregorio, c’è stata un’altra scoperta: la scoperta che, per un tratto, la via dove vivevo coincideva con il perimetro del Lazzaretto – il Lazzaretto della grande peste di Milano, quella di cui parla Manzoni nei Promessi Sposi e nella Storia della colonna infame. Un pezzo del muro di cinta del Lazzaretto è ancora visibile. Sono convinto che questa seconda scoperta sia stata, per me, ancora più importante della prima. Grazie al Lazzaretto, al fatto di essere nato, per così dire, ai suoi margini, credo di essermi reso conto in un modo concreto, fisico – un modo che nessun libro, nessuna lettura mi avrebbe consentito – che la mia città non era solo quella che vedevo, case, strade, piazze, gente viva, ma era anche piena di storia, cioè di case, strade, piazze che non c’erano più e di gente che non era più viva, di gente morta. Mi sono reso conto, insomma, che la mia città visibile era piena di storia invisibile, e che questa storia era, a sua volta, piena di dolore, di minacce, di paura. Da quel momento, credo, è entrato nella mia poesia il tema della peste: peste metaforica, si capisce: peste come contagio e condanna, come circolarità e anonimato dell’ingiustizia. (“L’approdo letterario”, XXII, n. 77-78 n.s., giugno 1977)
Manzoni deve esserci, non può non esserci, nelle mie poesie – esserci, è chiaro, come un tenue, degradato riflesso, o solo come un rimorso. Se non ci fosse, vorrebbe dire che non ci sono neanch’io, che le mie poesie sono, letteralmente, di qualcun altro. Ma al di là di questa fede o, se si vuole, di questa petizione di principio, suppongo che sia possibile rintracciare qualche indizio, qualche elemento più oggettivo. I temi dell’ingiustizia, della persecuzione, del processo iniquo, dell’innocenza ingiustamente perseguitata e punita; l’immagine, esplicita o implicita, della città come teatro della peste, come contenitore di ogni possibile contagio fisico e morale; il gusto di nominare luoghi, circostanze e documenti con scrupolosità impassibile e segreta passione; l’attenuazione, la reticenza e l’ironia usate per rendere pronunciabili l’indignazione, lo sgomento e la pietà: tutte queste cose (…) vengono, non ho dubbi, da Manzoni, sono le prove, le stigmate della mia passione manzoniana, della mia manzonità (o, parafrasando Gianfranco Contini: le spie d’attività, nel mio sentire e scrivere, della “funzione Manzoni”). Senza contare, per un eccesso di evidenza, gli omaggi letterali, le citazioni: gli untori di “Una città come questa” per esempio. (Raboni-Manzoni, Il ventaglio, 1985)
Una città come questa
non è per viverci, in fondo: piuttosto
si cammina vicino a certi muri,
si passa in certi vicoli (non lontani
dal luogo del supplizio) e parlando
con la voce nel naso
avidi, frettolosi si domanda: non è qui
che buttavano loro cartocci gli untori?
Le mie poesie più remote (…) risalgono all’infanzia, all’adolescenza. Sono poesie scritte intorno agli anni Cinquanta, quando avevo 18 anni, che raffigurano episodi della Passione di Cristo. Intorno al 1950, quando l’adolescenza stava diventando maturità sono successe per me delle cose fondamentali. Alla Scala c’è stata una stagione di concerti stupenda in cui si sono ascoltati tutti i capolavori della musica sacra, da Vespro della Beata Vergine fino al Requiem tedesco di Brahms. Esperienza per me assolutamente fondamentale. Poi si respirava nel campo letterario, e nel campo della poesia in particolare, quella voglia di rottura, di uscire dal lirismo degli anni Trenta su cui mi ero formato. Si sentiva l’esigenza di una poesia più discorsiva, più narrativa, più dentro la realtà. E in quel periodo, oltre alla straordinaria esperienza della musica sacra, oltre alle prime esperienze di appassionato di pittura e di scultura – per cui l’aver visto per la prima volta il portale di San Zeno a Verona o i bassorilievi di Chartres rientra in questo apprendistato – c’è stata soprattutto la lettura di grandi poeti anglosassoni, soprattutto Eliot, che in tutta la sua opera dimostrava la possibilità e l’esigenza di fare poesia parlando di sé e del proprio tempo, ma attraverso il correlativo oggettivo, qualcosa oggettivamente già esistente o già raccontato. Tutte queste cose mi hanno messo sulla strada del Vangelo come fonte di ispirazione, come possibilità di ri-racconto e di ri-espressione. Poi ho scritto altre poesie in cui c’è il ripercorrere la narrazione evangelica spiazzandola, inserendo degli elementi di contemporaneità, facendone anche uno specchio dell’oggi. Era uno stratagemma, un modo di parlare di me, finalmente, e del mio tempo e di quello che vedevo intorno a me senza tuttavia ancora espormi a un’esplorazione diretta della realtà, cioè, appunto, valendomi di un potente correlativo oggettivo che tanto era già servito nella storia dell’umanità in pittura, in scultura, in musica. Ecco, questa iniziazione al coraggio di parlare con la mia voce e non più prendendo in prestito le voci dei poeti che ammiravo e che amavo, credo mi sia venuta da questa idea di ripercorrere il racconto evangelico con quella distanza, quella lontananza, quelle diverse angolazioni, quella tendenza a prendere di sbieco, a inquadrare diversamente e anche, a poco a poco, a tagliare fuori il personaggio principale e puntare sui personaggi di contorno come avevo imparato dai grandi modelli del passato.
E’ stato poi importantissimo il fatto di scoprire la città come metafora, diciamo, come metafora della vita, come contatto con tutto quello che l’esistenza offre di problematico, di inquietante, di esaltante. E sono diventato a quel punto, dopo esser stato, nei primi anni di scrittura poetica, un… un ri-raccontatore di storie già raccontate, sono diventato un poeta di storie urbane, di racconti legati alla città, ai suoi problemi, ai suoi drammi, alle sue inquietudini. È il periodo che probabilmente ha segnato definitivamente la mia personalità di scrittore e di poeta. (Lo stratagemma della Passione, in Le parole del sacro. L’esperienza religiosa nella letteratura italiana, Atti del convegno, S. Salvatore Monferrato, 8-9 maggio 2003)
Cinema di pomeriggio
Quasi sempre a quest’ora
arriva gente un po’ speciale (però
di buonissimo aspetto). Chi si siede
ma poi continua a cambiar posto,
chi sta in piedi, sul fondo della sala, e fiuta,
fiuta rari passaggi, la bambina
mezzo scema, la dama ch’entra sola,
la ragazza sciancata… Li guardo per sapere
che storia è la loro, chi li caccia. Quando
viene la luce penso come il cuore
gli si deve contorcere cercando
d’esser salvo più in là, di sprofondare
nel buio che torna tra un minuto.
Ecco, un esempio di… di poesia urbana, insomma di poesia in cui l’inquietudine della vita di una grande città, le sue stranezze, i suoi aspetti anche sordidi, a colte, le sue figure di emarginati, di infelici, di spostati eccetera, prende, direi, prende il primo piano, ecco. È di nuovo, se si vuole, un modo di raccontare se stessi attraverso altro, attraverso quello che c’è intorno a noi. Ancora in quegli anni – siamo alla fine degli anni ’50, primi anni ’60 – ancora stento a parlare di me in prima persona, ancora quello che mi interessa è certificare il mio rapporto con la realtà: come prima attraverso la sublime metafora del racconto evangelico, così adesso attraverso le figure, attraverso la realtà della città riscoperta, della città amata, anche, perché, come dicevo prima, effettivamente è stato un innamoramento per me quello della città: un innamoramento che dura ancora adesso, a distanza di tanti anni, anche se la città è cambiata, anche se è molto meno vera (almeno mi sembra) di quanto fosse allora, molto meno ricca di umanità e anche di drammi. Però appunto è ancora il luogo in cui non riesco a non vivere.(Pantheon. Le ragioni della vita, intervista a G. Raboni, RAI Nettuno SAT 1, 4 gennaio 2004)
Se passo per via Andegari penso che lì abitavano i miei nonni che non ho mai conosciuto, tutti morti prima che nascessi. Questo fatto di non aver mai vissuto con i vecchi scombussola un po’, non si hanno istruzioni per la vecchiaia. E sono già nonno. (“la Repubblica”, 3-4 febbraio 1991)
I morti e i veri
Nella casa umida, il poco
ch’è asciutto sembra più asciutto ancora:
nelle stanze da letto al primo piano
il pavimento d’assi quasi bianche
non lucidate con la cera e
un po’ distanti; sotto, nella sala
del bigliardo, l’avorio dei birilli
messi in croce… (Prima o dopo ci torno
a vedere la casa degli amici
dove a momenti ti nasceva un figlio
– è nato due giorni dopo – e s’aspettava,
di sera, che il temporale portasse
un po’ di fresco anche a Milano. Smorti
lungo i muri, con facce da lenoni
o da tartufi, oscuri
antenati lombardi
controllavano il conto delle uova
e dei formaggi: usando astuzia, e quantità
di penne d’oca. Si rideva di loro
con ribrezzo. Ma in fondo, che sia giusto
così? Meglio dei nostri veri, gente
distratta, malinconica
per vizi più sottili, chi può dire
che non sia quello il tipo d’antenati
che nostro figlio fingerà d’avere, ridendo
di loro, voltandogli le spalle
come nessuno è mai riuscito a fare!)
Milano continua a essere lo scenario della mia vita e dunque della mia immaginazione, della mia sensibilità, del mio modo di reagire a ciò che accade nella realtà e nella mia mente. Ma rispetto ai tempi de Le case della vetra penso che questo scenario si sia molto interiorizzato, che abbia perso, se così si può dire, gran parte della sua “letteralità” e, dunque, della sua pronunciabilità immediata; e questo, credo, perché – come succede a tutti, forse, quando si invecchia – da alcuni anni tendo a guardare molto di più dentro di me e molto meno fuori di me, ossia, in altri termini, perché la Milano che più mi riguarda e mi emoziona la ritrovo, ormai, soprattutto nella memoria. (Milano, la città e la memoria, 2001)
La poesia La guerra è assolutamente autobiografica, è un ricordo di mio padre, dello straordinario spirito di sacrificio con cui, lui che non poteva abbandonare la città, viaggiava continuamente ogni sera e ogni mattina fra la città e la campagna dove eravamo rifugiati, pur di non interrompere la vita in comune. Questo spirito di sacrificio, di dedizione, che mi commuove sempre, è messo a confronto con le mie personali inadempienze nei confronti dei miei figli. In generale la mia vita entra nella poesia, e ci è entrata in maniera crescente: quando ero molto giovane da una parte avevo meno vita da mettere nella poesia, dall’altra avevo più paure a mettercela. Questo spiega il sistema di correlativi oggettivi di cui è impastata la prima fase della mia poesia. Poi la mia vita è entrata o come ricordo, ripensamento del passato, o in presa diretta come registrazione di emozioni. Adesso torno invece un po’ a rispecchiarmi, forse a nascondermi, dentro storie già codificate”. (Conversazioni d’autore. Dialoghi fra scrittori e studenti di un liceo, a cura di G. Prosperi, prefazione di G. Armellini, Bologna, Pendragon, 2003):
La guerra
Ho gli anni di mio padre – ho le sue mani,
quasi: le dita specialmente, le unghie,
curve e un po’ spesse, lunate (ma le mie
senza il marrone della nicotina)
quando, gualcito e impeccabile, viaggiava
su mitragliati treni e corriere
portando a noi tranquilli villeggianti
fuori tiro e stagione
nella sua bella borsa leggera
le strane provviste di quegli anni, formaggio fuso, marmellata
senza zucchero, pane senza lievito,
immagini della città oscura, della città sbranata
così dolci, ricordo, al nostro cuore.
Guardavamo ai suoi anni con spavento.
Dal sotto in su, dal basso della mia
secondogenitura, per le sue coronarie
mormoravo ogni tanto una preghiera.
Adesso, dopo tanto
che lui è entrato nel niente e gli divento
giorno dopo giorno fratello, fra non molto
fratello più grande, più sapiente, vorrei tanto sapere
se anche i miei figki, qualche volta, pregano per me.
Ma subito, contraddicendomi, mi dico
che no, che ci mancherebbe altro, che nessuno
meno di me ha viaggiato fra me e loro,
che quello che gli ho dato, che mangiare
era? non c’era cibo nel mio andarmene
come un ladro e tornare a mani vuote…
Una povera guerra, piana e vile,
mi dico, la mia, così povera
d’ostinazione, d’obbedienza. E prego
che lascino perdere, che non per me
gli venga voglia di pregare.
Credo che questo sentimento di inadempienza, che a un certo punto si è focalizzato sul rapporto con i figli, fosse in qualche modo preesistente. In effetti anche prima di essermi allontanato da loro avevo il sentimento, del tutto irrazionale, di aver mancato qualche appuntamento importante, con i miei genitori ad esempio, con cui pure ho avuto un rapporto molto buono. Forse il fatto che mio padre e mia madre siano scomparsi così rapidamente ha fatto sì che inconsciamente io mi sentissi un po’ in colpa, come se non fossi stato in grado di trattenerli. Poi questo senso di inadempienza si è concretizzato più ragionevolmente sui miei figli, nei confronti dei quali sono stato veramente manchevole. Però credo che qualcosa, sia pure irrazionalmente, si fosse formato prima”. (Intervista in “Poesia”, XVI, n. 168, gennaio 2003):
Parti di requiem (…) è dedicato alla memoria di mia madre e si chiude con una poesia che si riconnette anch’essa, in qualche modo, al dilemma fra responsabilità e irresponsabilità della poesia di fronte alla vita (e alla morte, naturalmente). (“L’approdo letteraio”, cit.)
Amen
Quando sei morta stavamo
in una casa vecchia.L’ascensore non c’era. C’era spazio
da vendere per pianerottoli e scale.
Dunque non t’è toccato di passare
di spalla in spalla per angoli e fessure,
d’essere calcolata a spanne, raddrizzata
nel senso degli stipiti. Sparire
era più lento e facile quando tu sei sparita.
Parecchie volte, dopo, mi è sembrata
una bella fortuna.
Eppure, se ci pensi, in poche cose
c’è meno dignità che nella morte,
meno bellezza. Scendi a pianterreno
come ti pare, porta o tubo, infìlati
dove capita, scatola di scarpe
o cassa d’imballaggio, orizzontale
o verticale, sola o in compagnia,
liberaci dall’estetica e così sia.
Questa poesia scritta pensando, ripensando alla morte di mia madre è in qualche modo conclusiva di una serie di testi diciamo di carattere familiare: sulla storia della mia famiglia, sulla scomparsa dei miei genitori. È anche una poesia in cui in qualche modo tento di uscire da questo viluppo di emozioni e di ricordi, come se sentissi il bisogno di avvicinarmi di più alla vita non riflessa, alla vita “in diretta”, si direbbe oggi, o in prima persona. (Pantheon. Le ragioni della vita, cit.)
Pensavo
polvere, non cenere; non
arso, pensavo, né centrifugato;
polvere: e diventarlo
a poco a poco, a poco a poco sperdere
il duro delle ossa. E che la terra
non fosse poca né tanta,
né pesante né lieve a cancellare
lo scempio della fossa.
E che la terra fosse consacrata…
E che la terra fosse consacrata
e condivisa, lotto
numerato e introvabile
d’uno dei fiochi immensi cimiteri
che da nord, da nord-ovest
assediano Milano, che ci salvano,
barricate di croci,
d’angeli mutilati, dall’orrore
di marcire in privato, in un giardino.
Uno dei pochi pilastri della mia fede – ammesso che di fede si possa parlare – è l’idea della comunione dei vivi con i morti, che non vuol dire che io pensi che c’è un oltrevita nel quale si incontrino i morti. Penso che i morti ci siano, cioè penso che si continui a vivere anche con le persone che non ci sono più, che continuino a fare parte della nostra vita… Attraverso la memoria, attraverso la continuità dei pensieri e delle emozioni. Se li coinvolgevano quando erano vivi, perché non dovrebbero coinvolgerli poi quando sono morti? Noi non cambiamo perché una persona non la vediamo più, rimaniamo noi stessi. Quindi, non ci sono dubbi. Non ho dubbi su questo… o, comunque, voglio non averne”. (Intervista a Giovanni Raboni, Firenze, 29 maggio 2003)
La commemorazione dei defunti
Con i tuoi, lo sappiamo, un modus
vivendi l’hai trovato. Non era né facile
né difficile, quasi non c’era scelta. ma quei tizi di cui
non ti frega niente, carbonizzati
nella carcassa di un caccia sbocconcellati dall’uomoleone falciati
dal tifo sull’altipiano, che
salvezza c’è per te in loro? che sugo
per loro nel tuo strizzar gli occhi e indugiare
a fitte sul giornale?
Siano rimessi, dico (i morti) nel nostro impasto quotidiano, piega il giornale,
lascia che lontano i vivi seppelliscano i vivi.
Pensare all’anima – non per salvarla: per goderne.
È impossibile guardare il tempo senza vedere la morte, così come è impossibile guardare il mare aperto senza vedere l’orizzonte. Uno, per non vederla, dovrebbe passare tutta la vita di profilo come l’ one-eyed jack, il povero fante monocolo delle carte da gioco. E il bello è che anche la morte, come l’orizzonte, è sempre alla stessa distanza.
Ho sempre pensato che l’ultimità (so che questa parola non esiste, ma per il momento non sono disposto a rinunciarvi o a sostituirla) sia la più preziosa, la più inebriante delle dolcezze. Ma come calcolarla senza spavento? Un condannato a morte potrebbe essere per una notte il più felice degli uomini se la felicità non gli fosse nascosta o per dir meglio ostruita dall’immaginaria traumaticità e “oscenità” della morte. Insomma, è probabile che il dono dell’indeterminatezza – la facoltà che a ogni uomo è concessa, ma che non molti possono o sanno sfruttare sino all’ultimo, di vedere la morte sempre alla stessa distanza – non sia indispensabile soltanto per vivere senza tormento, ma anche per avvicinarsi con gioia alla morte. Si può assaporare la fine solo a patto di percepirla come un bene esiguo ma non contato, uno spazio breve e ultimo ma infinito.
Sono quello che eravate, sarò
quello che siete, sussurro a chi spia
i miei passi da un letto di corsia
d’un padiglione di Niguarda o
del vecchio policlinico di via
Sforza, mi sopravalutate, ho
un rene solo, presto perderò
l’ultima battaglia con la miopia
e il cuore, eh, il cuore…No, perdono, care
anime, perdono! non posso fare
l’unto della Morte qui, non si deve
insegnare a morire a chi già tanto
muore e così poco spera, soltanto
un’altra primavera, un’altra neve.
Solo adesso comincio forse a intravedere il significato di un’immagine che da molti anni inesplicatamente nutro e mi nutre, quella di mio padre che dopo il primo attacco cardiaco (il secondo, pochi mesi dopo, lo avrebbe ucciso) se ne sta a letto, di buonissimo umore, ben appoggiato a due cuscini, e legge, legge ininterrottamente, legge o rilegge tutti i romanzi possibili… Rivedo le pile di libri sul comodino, l’azzurro dei vecchi Einaudi, il verde della “Romantica”, il giallo dei Classiques Garnier… E ricordo la mia sorpresa, il mio superstizioso sgomento: perché leggere tanto, perché impadronirsi di tante storie, di tante verità se gli restava così poco tempo per “usarle”, per metterle a profitto? Forse, pensavo, legge soltanto per “passare il tempo”… Ma no: finito un libro, diceva sorridendo che era contento, che ne era “valsa la pena”… Ma come? era la mia stessa reazione – ma io avevo vent’anni, e se ero contento d’aver letto un nuovo libro o d’averne capito meglio uno che avevo letto troppo presto, con troppa foga e innocenza, era perché ogni volta mi sentivo un po’ più forte, più ricco, perché sentivo di avere qualcosa in più da smerciare, da investire, da far fruttare nel corso del mio vergine e inesauribile futuro, a profitto del mio orgoglio e a edificazione del genere umano: tempus edificandi… Beh, adesso comincio a capire – forse, più semplicemente, comincio a essere mio padre. Quest’anno lui avrebbe cento anni, l’anno prossimo io avrò la sua età, l’età di quando è morto. Se mi sono trascinato dietro, di casa in casa, tanti libri era, comincio a rendermene conto, per metterli un giorno o l’altro in pila – gli azzurri, i verdi, i gialli – sul comodino. A proposito, dovrei avere un comodino accanto al letto. Dovrei avere un letto, un vero letto – un letto con una spalliera di noce a cui appoggiare due cuscini. Non assaporo ancora, ma già immagino la gioia di accumulare silenziosamente dentro di me beni infruttiferi e intrasmissibili e sento che potrebbe essere la più pura, la più sottile, la più perfetta delle gioie. (“Legenda”, aprile 1992)
Ombra ferita, anima che vieni
zoppicando, strisciando dal tuo fioco
asilo a cercare nei sogni il poco
che rosicchio per te all’andirivieni
dei risvegli e degli incubi, agli osceni
cortei delle sciarade, così poco
che qualche volta quando arrivi il fuoco
è già spento, divelte le imposte, pieni
di insulsi intrusi o infidi replicanti
l’immensità della cucina, il banco
di scuola, il letto, dammi tempo, non
svanire, il tempo di chiudere i tanti
conti vergognosi in sospeso con
loro prima di stendermi al tuo fianco.
Comunque è un tema, questo dei rapporti familiari, dei ricordi familiari, che poi è continuato, anche andando avanti, anche fino alle ultime cose. Però in qualche modo sentivo il bisogno di uscirne, di affrontare forse un modo più autobiografico di frequentare e di usare la poesia. E probabilmente quello che doveva succedere era che entrasse, con forza, con violenza, nella mia ispirazione e nella mia pratica poetica il tema dell’amore. Alle poesie di pietà familiare, diciamo così è subentrata poi negli anni successivi una poesia di racconto amoroso, di autobiografia amorosa.
“Canzonette mortali”. Sono poesie d’amore, e a questo punto direi che il privato, e il racconto di me, è entrato addirittura in modo spudorato nella mia poesia. Non sono, queste, le prime poesie d’amore, sono in un certo senso le ultime, cioè quelle dell’ultimo amore, quello che continua a essere nella mia vita. Però sono in qualche modo la conclusione di un avvicinamento alla confessione diretta, diciamo così; e probabilmente occorreva proprio questo rapporto traumatico che si ha con l’oggetto del proprio amore, con la persona amata, per farmi uscire così allo scoperto. Da questo punto in poi in un certo senso anche le mie poesie di argomento non amoroso, le mie poesie di argomento… riflessivo, meditativo, o addirittura civile sono decisamente poesie in prima persona. Ho in qualche modo rotto il diaframma del correlativo oggettivo; sono diventato uno che parla di sé, sono diventato un poeta in prima persona. Io non credo che questo sia un progresso; credo che la poesia possa essere altrettanto sincera, altrettanto autentica, altrettanto rivelatrice anche se si mantiene, appunto, al coperto, se mantiene la finzione o… il gioco di sponda con la realtà oggettiva. A me è successo questo; ed è abbastanza probabile che sia qualcosa che riguarda anche proprio le età di una persona, cioè che ci sia qualcosa di… addirittura di biologico, no? in questo andare da un rapporto privilegiato con la realtà esterna, con la realtà oggettiva, con le immagini del mondo, diciamo così, verso una… verso la meditazione sempre più interiore, sempre più in prima persona. Alla fine si rimane soli di fronte alla solitudine, alla morte, questo è il destino credo di tutti noi; e quindi che anche la poesia segua in qualche modo questo tracciato – dalla vita alla morte, dal collettivo al drammaticamente individuale – credo sia abbastanza nella natura, nella natura delle cose”. (Pantheon. Le ragioni della vita, intervista a G. Raboni, RAI Nettuno SAT 1, 4 gennaio 2004)
Canzonette mortali
Io che ho sempre adorato le spoglie del futuro
e solo del futuro, di nient’altro
ho qualche volta nostalgia
ricordo adesso con spavento
quando alle mie carezze smetterai di bagnarti,
quando dal mio piacere
sarai divisa e forse per bellezza
d’essere tanto amata o per dolcezza
d’avermi amato
farai finta lo stesso di godere.
Le volte che è con furia
che nel tuo ventre cerco la mia gioia
è perché, amore, so che più di tanto
non avrà tempo il tempo
di scorrere equamente per noi due
e che solo in un sogno o dalla corsa
del tempo buttandomi giù prima
posso fare che un giorno tu non voglia
da un altro amore credere l’amore.
Un giorno o l’altro ti lascio, un giorno
dopo l’altro ti lascio, anima mia.
Per gelosia di vecchio, per paura
di perderti – o perché
avrò smesso di vivere, soltanto.
Però sto fermo, intanto,
come sta fermo un ramo
su cui sta fermo un passero, m’incanto…
Non questa volta, non ancora.
Quando ci scivoliamo dalle braccia
è solo per cercare un altro abbraccio,
quello del sonno, della calma – e c’è
come fosse per sempre
da pensare al riposo della spalla,
da aver riguardo per I tuoi capelli.
Meglio che tu non sappia
con che preghiere m’addormento, quali,
parole borbottando
nel quarto muto della gola
per non farmi squartare un’altra volta
dall’avido sonno indovino.
Il cuore che non dorme
dice al cuore che dorme: Abbi paura.
Ma io non sono il mio cuore, non ascolto
né do la sorte, so bene che mancarti,
non perderti, era l’ultima sventura.
Ti muovi nel sonno. Non girarti,
non vedermi vicino e senza luce!
Occhio per occhio, parola per parola,
sto ripassando la parte della vita.
Penso se avrò il coraggio
di tacere, sorridere, guardarti
che mi guardi morire.
Solo questo domando: esserti sempre,
per quanto tu mi sei cara, leggero.
Ti giri nel sonno, in un sogno, a poca luce.
Non ho grandi letture, scientifiche, ma mi ha sempre colpito, in quelle poche cose che ho letto di fisica, l’idea che l’irreversibilità del tempo non possa essere dimostrata. Viviamo rispettando questa realtà, però la fisica non è in grado di dimostrare che il tempo sia irreversibile. E questo mi ha sempre molto colpito: un po’ terrorizzato, un po’ consolato. Siamo sempre in bilico. Non è detto che non si possa tornare indietro, a visitare il passato. Credo di averlo anche scritto da qualche parte, in una poesia di A tanto caro sangue, Scongiuri vespertini, dove si parla di tornare a visitare sepolcri e lazzaretti. Questa idea, che ho trovato anche in libri di fisici famosi, che si può anche viaggiare nel tempo, non con le macchine del tempo, ma in qualche luogo del possibile… Questa è forse la volta in cui sono riuscito a dirla meglio”. (C. Di Franza, intervista a Giovanni Raboni ,Venezia-Napoli, 2002-2003)
Dopo la vita, cosa? ma altra vita,
si capisce, insperata, fioca, uguale,
tremito che non si arresta, ferita
che non si chiude eppure non fa male
– non più, non tanto. Lentamente come
risucchiati all’indietro da un’immensa
moviola ogni cosa riavrà il suo nome,
ogni cibo apparirà sulla mensa
dov’era, sbiadito, senza profumo…
Bella scoperta. E’ un pezzo che la mente
sa che dove c’è arrosto non c’è fumo
e viceversa, che fra tutto e niente
c’è un pietoso armistizio. Solo il cuore
resiste, s’ostina, povero untore.
Ho cominciato a riflettere sulla morte… direi prima addirittura sul racconto evangelico, sulla morte di Cristo, poi sulla morte dei miei, sulla morte che ha colpito molto presto la mia vita con la scomparsa prima di mio padre e poi di mia madre. E quindi era in un certo senso la morte degli altri, era la morte come scomparsa di persone care, di riferimenti indispensabili. Poi col tempo, credo naturalmente, è diventata la riflessione sulla mia morte, su che cosa significa, su che cosa significherà; e direi che è diventata però, almeno credo, sempre più serena, la mia riflessione, nel senso che insieme all’idea della morte come… come traguardo che si avvicina, come esperienza che si fa sempre più prossima, si è fatta sempre più forte in me l’idea della comunione dei vivi e dei morti, per dirla in modo sintetico. Cioè non faccio più molta distinzione tra vivi e morti, non soltanto nelle persone della famiglia ma nelle persone care, negli amici che a un certo punto scompaiono. Io non li sento, devo dir la verità, più lontani di quando erano vivi, e quindi mi si è, appunto, fatta sempre più essenziale, sempre più cara l’idea che esiste non so se un aldilà o un aldiquà o un dentro-di-noi in cui i morti continuano a vivere con noi. Questo è diventato uno dei temi proprio anche espliciti del mio ragionamento e della mia poesia”. (Pantheon. Le ragioni della vita, intervista a G. Raboni, RAI Nettuno SAT 1, 4 gennaio 2004)
Ho sempre pensato che la vita non sia qualcosa da cui si entra e si esce, qualcosa che si attraversa come uno spazio finito, ma come qualcosa in cui si sta indefinitamente. Questo non implica, secondo me, per forza di cose, un’idea di trascendenza: semplicemente la vita è questa cosa, la cosa in cui si sta, in cui non si può non continuare a stare anche quando teoricamente la vita finisce. Questa è la mia – se volete – la mia fede. Non so se sia una fede nel senso plausibile della parola. È il mio modo di stare dentro questa realtà che secondo me non può chiamarsi in altro modo che la vita. Una volta in una poesia ho scritto che “cerco” a volte “di immaginare la felicità dei morti” e penso che anche per i morti la felicità sia la vita. (Rai, estate 2003)
Tanto difficile da immaginare,
davvero, il paradiso? Ma se basta
chiudere gli occhi per vederlo, sta
lì dietro, dietro le palpebre, pare
che aspetti noi, noi e nessun altro, festa
mattutina, gloria crepuscolare
sulla città invulnerata, sul mare
di prima della diaspora – e si desta
allora, non la senti? una lontana
voce, lontana e più vicina come
se non l’orecchio ne vibrasse ma
un altro labirinto, una membrana
segreta, tesa nel buio a metà
fra il niente e il cuore, fra il silenzio e il nome…
L’importante è essere ben convinti che la poesia non è né uno stato d’animo a priori né una condizione di privilegio né una realtà a parte né una realtà migliore. È un linguaggio: un linguaggio diverso da quello che usiamo per comunicare nella vita quotidiana e di gran lunga più ricco, più completo, più compiutamente umano; un linguaggio al tempo stesso accuratamente premeditato e profondamente involontario capace di connettere fra loro le cose che si vedono e quelle che non si vedono, di mettere in relazione ciò che sappiamo con ciò che non sappiamo.
Svegliami, ti prego, succede ancora
d’implorare in un sogno a questa tenera
età, aiutami, fa’ che non sia vera
l’oscena materia del buio. Sfiora
allora davvero una mano il mio
corpo assiderato e di colpo so
d’averti chiamata e che non saprò
più niente
in “Almanacco dello Specchio”, Mondadori 2006



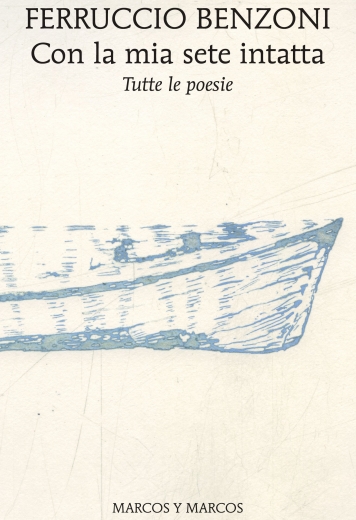


 Meglio star zitti? raccoglie centosettanta stroncature firmate da Giovanni Raboni in quarant’anni di attività critica: interventi talvolta garbati, più spesso sarcastici e addirittura spietati, tesi a mettere in discussione il valore e il significato di prodotti artistici (romanzi, poesie, film, spettacoli teatrali) e di fenomeni di costume. Ne fanno le spese nomi blasonati: Woody Allen, Italo Calvino, Umberto Eco, Federico Fellini, Dario Fo, Giorgio Gaber, Ernest Hemingway, Milan Kundera, Pier Paolo Pasolini e tanti altri.
Meglio star zitti? raccoglie centosettanta stroncature firmate da Giovanni Raboni in quarant’anni di attività critica: interventi talvolta garbati, più spesso sarcastici e addirittura spietati, tesi a mettere in discussione il valore e il significato di prodotti artistici (romanzi, poesie, film, spettacoli teatrali) e di fenomeni di costume. Ne fanno le spese nomi blasonati: Woody Allen, Italo Calvino, Umberto Eco, Federico Fellini, Dario Fo, Giorgio Gaber, Ernest Hemingway, Milan Kundera, Pier Paolo Pasolini e tanti altri. FARSI VERSO
FARSI VERSO
 ESTRATTI
ESTRATTI La solitudine dei reietti
La solitudine dei reietti


 di Eleonora Rimolo
di Eleonora Rimolo






 di Guido Monti
di Guido Monti

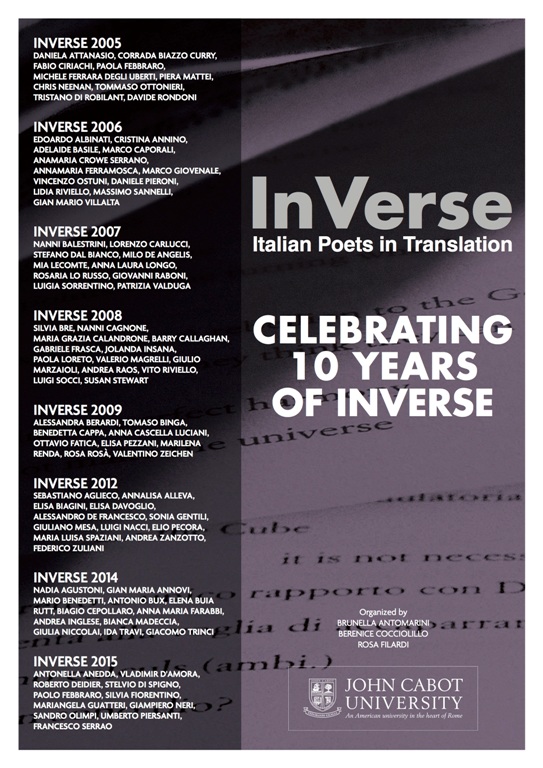
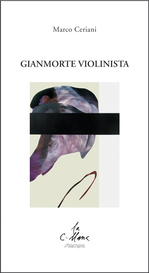
 Testi e interventi sulla figura di Giovanni Raboni (Collana Stampa 2009, 2014) a cura di Valeria Poggi, euro 15,00.
Testi e interventi sulla figura di Giovanni Raboni (Collana Stampa 2009, 2014) a cura di Valeria Poggi, euro 15,00.


