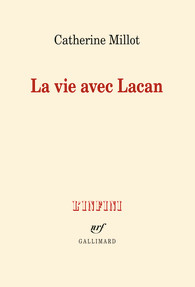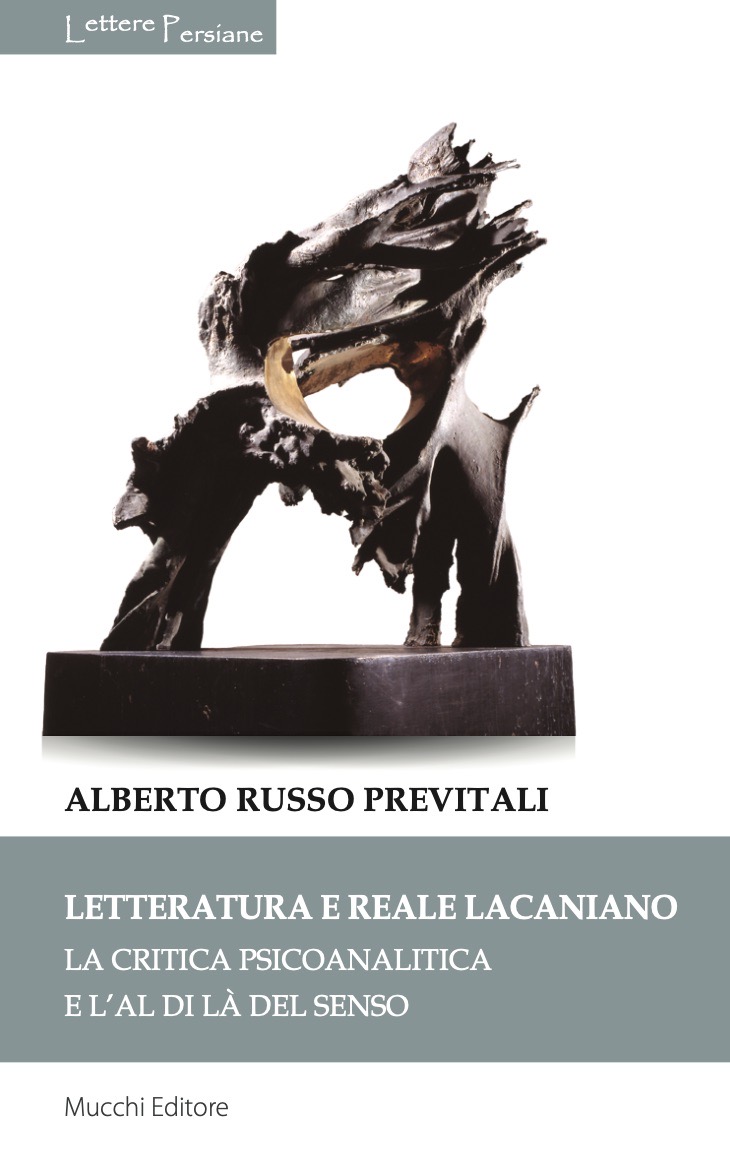 PREMESSA
PREMESSA
Il volume raccoglie una serie di studi scritti e pubblicati nell’arco di un quindicennio, in tempi e luoghi diversi, ma accomunati da un unico intento: scrivere saggi di critica psicoanalitica attraverso l’apertura e il confronto con il registro lacaniano del reale. È un progetto di ricerca nato nel periodo della mia formazione universitaria, a contatto diretto con alcuni maestri della critica psicoanalitica (come Giovanni Bottiroli, Massimo Recalcati, Stefano Agosti, Michèle Aquien) e poi perseguito nel decennio successivo.
L’autore su cui questo progetto è stato portato avanti in modo più approfondito è certamente Andrea Zanzotto. Il saggio Zanzotto/Lacan. L’impossibile e il dire rappresenta l’approdo più coerente e organico del mio tentativo di seguire questa prospettiva interpretativa . Ma in concomitanza e in relazione con questa indagine centrale, ho continuato a sviluppare il progetto di una critica psicoanalitica attenta al reale con studi su opere di altri autori, appartenenti alla letteratura italiana o francese del Novecento (fanno eccezione Cuore di tenebra di Joseph Conrad e Les Complaintes di Jules Laforgue, pubblicate nel 1885).
Queste esplorazioni, pur nella loro singolarità e varietà, sono venute a comporre nel corso degli anni un insieme che, oggi, nelle sue articolazioni, si presenta come un tentativo di penetrare nel rapporto inesauribile tra la letteratura e il reale. È dunque una costellazione di dieci saggi critici (in cui ancora brillano due astri zanzottiani) che è proposta unitariamente nel presente volume sotto il titolo Esplorazioni e incontri.
Ogni saggio è un’esplorazione testuale che mira a un incontro con il reale come impossibile a dire, come muro, buco, spigolo duro di verità su un aspetto essenziale e inaggirabile della realtà umana: desiderio, amore, morte, linguaggio, generazione, memoria, oblio, eredità, potenza, ideale, utopia etc. Ogni esplorazione si vuole singolare e alla ricerca dell’incontro con l’unicità dell’opera, mentre comuni sono le prospettive teoriche e gli strumenti concettuali della psicoanalisi che permettono di mettersi sul cammino del reale (di concepire la sua inconcepibilità, di parlare della sua impossibilità di essere detto interamente). Queste prospettive e questi concetti sono presentati nella prima parte del volume, insieme ai fondamenti e ai problemi teorici a cui sono legati.
Il titolo Linee di osservazione vuole mettere in evidenza la portata teorica di questi primi capitoli (attraverso il greco theōrêin: osservare, contemplare), mostrando però al tempo stesso la consapevolezza che essi non propongono una teoria articolata sul problema “letteratura e reale”, di cui i saggi della seconda parte sarebbero l’applicazione e la dimostrazione in sede di analisi. Non sarebbe onesto presentare il volume sotto il binomio scientifico “teoria e analisi”, per diversi motivi. Innanzitutto, occorre menzionare la limitatezza concettuale di questi primi capitoli, redatti a posteriori con la finalità primaria di illustrare gli strumenti e le coordinate teoriche che hanno permesso l’elaborazione e la scrittura dei saggi sulle opere.
La prima parte non può dunque essere considerata una teoria sul rapporto tra la letteratura e il reale, poiché, per essere tale, essa avrebbe dovuto accogliere lo sviluppo di molti altri problemi e aspetti essenziali che qui non vengono affrontati.
L’affinamento e l’allargamento dei legami potenziali di induzione e dimostrazione tra saggi critici sulle opere e saggi teorici, che avrebbero potuto condurre a una trattazione teorica estesa, non sono stati perseguiti per diverse ragioni. Tra queste, vi è anche, certamente, una risposta metodologica che riguarda la specificità stessa dell’oggetto di studio: il reale considerato nell’ambito della letteratura sembra in effetti sfuggire alla possibilità di una trattazione teorica portata a un sufficiente grado di formalizzazione. Come si dirà più approfonditamente nella prima sezione, si tratta di un’incompatibilità che riguarda in primo luogo la linguistica e la semiotica (e in parte anche l’estetica), e che, nel caso dei saggi qui raccolti, ha determinato, come effetto di struttura, una scrittura impegnata ad esporsi in massimo grado al reale delle opere a partire dalle teorie esistenti (si fa riferimento, nello specifico, alle teorie dei maestri citati, alle quali si aggiungono quelle di classici come Barthes, Starobinski, Kristeva, Meschonnic, Lavagetto). Queste teorie sono assunte come basi e come riserve concettuali della scrittura critica, come strumenti raffinati per portare quest’ultima alla produzione di un sapere a partire dal reale, in una dinamica che obbliga però le teorie stesse a confrontarsi con la dimensione affettiva, con i vuoti e con il non-senso che attraversano il linguaggio e il soggetto come essere parlante.
Queste argomentazioni richiamano ancora una volta, da una diversa angolatura, la formula di Barthes e Starobinski secondo la quale “il critico è uno scrittore” . Nella prospettiva di una critica orientata dal reale, il critico è uno scrittore perché è chiamato a percorrere e ricostruire le strutture del testo per incontrarvi dei nuclei di resistenza non verbalizzabili, di fronte ai quali la sua parola non può porsi su un grado di padronanza e formalizzazione diverso rispetto a quello della parola dello scrittore o del poeta (o di chiunque altro). Il critico è allora chiamato, pur restando nel proprio genere di scrittura e all’ascolto della risonanza strutturale e stilistica dell’opera, a esporre a sua volta la sua parola sul vuoto e sul non-senso.
Occorre però ricordare la ragione profonda che fa del critico uno scrittore: egli è scrittore in quanto lettore al più alto grado. Il critico è colui che prova a portare l’atto della lettura al suo punto più alto in termini di conoscenza ed esaustività, e ciò sia dal punto di vista della struttura che da quello soggettivo della capacità interpretativa e dello stile personale. In questo senso, il critico è colui che vuole onorare, attraverso la produzione di un sapere testuale, l’opera che lo ha attratto, sconvolto, interrogato, impegnato, appassionato. L’opera che ha amato. E questa lettura, che costruisce relazioni, che intesse osservazioni e dettagli convergenti, che fa esistere ed espandere le possibilità di senso del testo, non può che diventare scrittura complessa, su cui grava al tempo stesso il peso del rigore e dell’inesprimibile. Questo sapere testuale, che si vuole il più possibile trasmissibile e formalizzato dal punto di vista concettuale, non può, in una critica che prenda sul serio il reale, essere separato dall’individualità del critico. È il reale del testo che rende possibile la nota osservazione di Proust: «ogni lettore, quando legge, è soltanto il lettore di se stesso» (chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même) . Come fa notare Philippe Forest, ciò significa che anche «il lettore può avere accesso all’esperienza del reale», poiché la vera letteratura giunge «all’universale senza rinunciare mai al particolare» . Ma non può essere altrimenti: il lettore incontra questo universale posto sotto il nome del reale sempre nella propria singolarità. La lettura dell’opera portata al grado di scrittura e indirizzata a un altro lettore, interlocutore vivente, vicino o lontano, è dunque sempre un’interrogazione sulla propria identità, un confronto con il proprio reale attraverso la risposta alla voce pulsante del testo, al dialogo con la parola dell’autore sublimatosi nelle trame dei significanti.
Ogni lettura analitica di un’opera è dunque anche la testimonianza mediata e trasfigurata discorsivamente di un periodo della storia personale del critico, ovvero di un individuo alle prese con le vicissitudini del proprio desiderio e del proprio confronto con la morte; un periodo trascorso in un luogo e penetrato dal libro di quei giorni, libro che sdoppia la vita, la riflette e la espande, la intensifica nella comprensione affettiva, rendendola più viva e più degna.
Alberto Russo Previtali, Letteratura e reale lacaniano. La critica psicoanalitica e l’al di là del senso, Mucchi, Modena, 2023.

Alberto Russo Previtali
DAL RISVOLTO DI COPERTINA
Come nel capolavoro di Montesquieu che in qualche misura inaugura l’età dell’Illuminismo, la critica è una “lettera persiana”, un messaggio che viene da un altrove rispetto alla pratica della letteratura e alla rete delle convenzioni sociali del presente, illuminando entrambe grazie a un felice straniamento. Il compito della critica, arte tutt’altro che inutile in un tempo complesso come questo, non deve necessariamente esser quello di aggiungere complessità a complessità, bensì di spezzare, come voleva Kafka, la crosta del mare ghiacciato dentro di noi: renderlo nuovamente liquido, mobile, vitale. E rovinare le sacre verità, come insegnò tra gli altri proprio Montesquieu, può essere anche una faccenda divertente.
è una scienza di salvataggio, in primo luogo salvataggio della letteratura stessa, oppressa dai troppi libri e dal nessun senso di molti di essi. Per far questo occorrono nuovi occhi, nuove scritture, nuovi ardimenti.
Come dire, la critica letteraria nella sua forma meno paludata e accademica, meno rispettosa dei canoni e delle tradizioni consolidate, più innovativa e in sintonia con il presente. Di facile lettura e aperta a nuove contaminazioni e tangenze con la sociologia, l’arte, la filosofia, la storia…
La nostra tradizionale passione per la critica letteraria, arricchita di interpretazioni e nuove visioni.
Il pensiero di Jacques Lacan ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della critica letteraria psicoanalitica nel Novecento e all’inizio del nuovo millennio. Continua a leggere
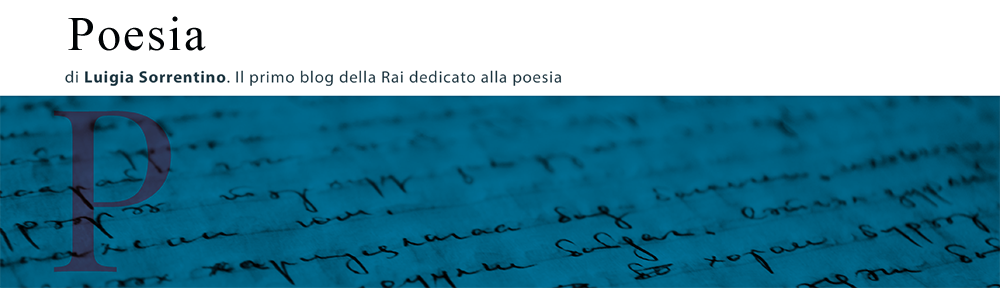
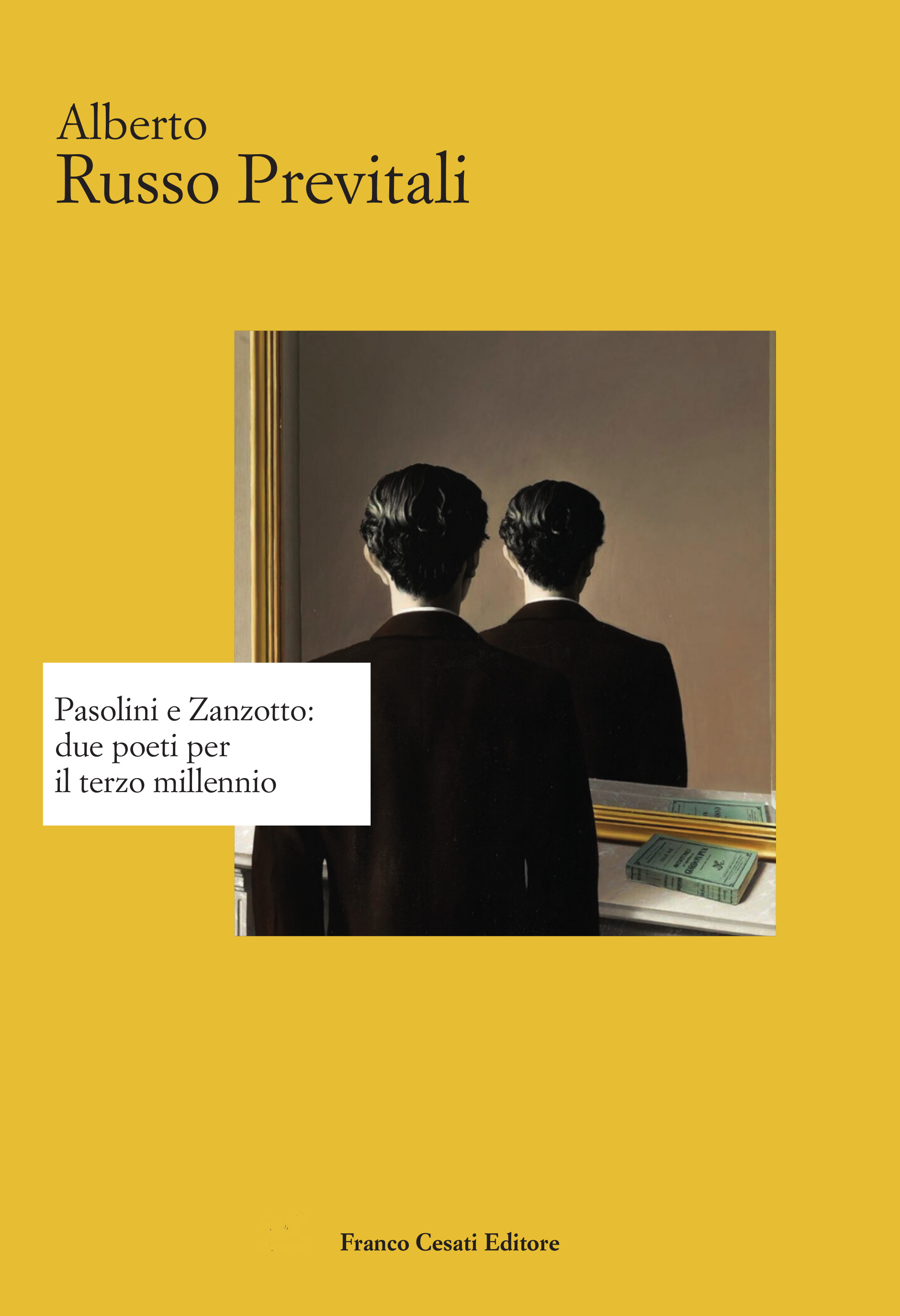


 Occorre certo avere una piccola idea del percorso poetico di Zanzotto (sin dagli esordi, o almeno a partire da Dietro il paesaggio del 1951, fino a Conglomerati del 2009 e passando da La Beltà del 1968), ed è anche necessario avere abbastanza chiari alcuni dei concetti di Jacques Lacan per seguire l’analisi di Russo Previtali. Tuttavia, l’autore riesce a palesare in modo accessibile, citazioni all’appoggio, le modalità con cui i concetti in area psicanalitica si fanno presenti nell’operato poetico, lungo tutta la produzione di Andrea Zanzotto, sia nelle poesie che nelle prose (saggi e narrazioni).
Occorre certo avere una piccola idea del percorso poetico di Zanzotto (sin dagli esordi, o almeno a partire da Dietro il paesaggio del 1951, fino a Conglomerati del 2009 e passando da La Beltà del 1968), ed è anche necessario avere abbastanza chiari alcuni dei concetti di Jacques Lacan per seguire l’analisi di Russo Previtali. Tuttavia, l’autore riesce a palesare in modo accessibile, citazioni all’appoggio, le modalità con cui i concetti in area psicanalitica si fanno presenti nell’operato poetico, lungo tutta la produzione di Andrea Zanzotto, sia nelle poesie che nelle prose (saggi e narrazioni).