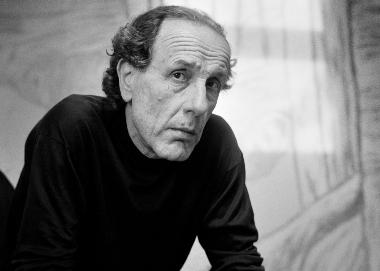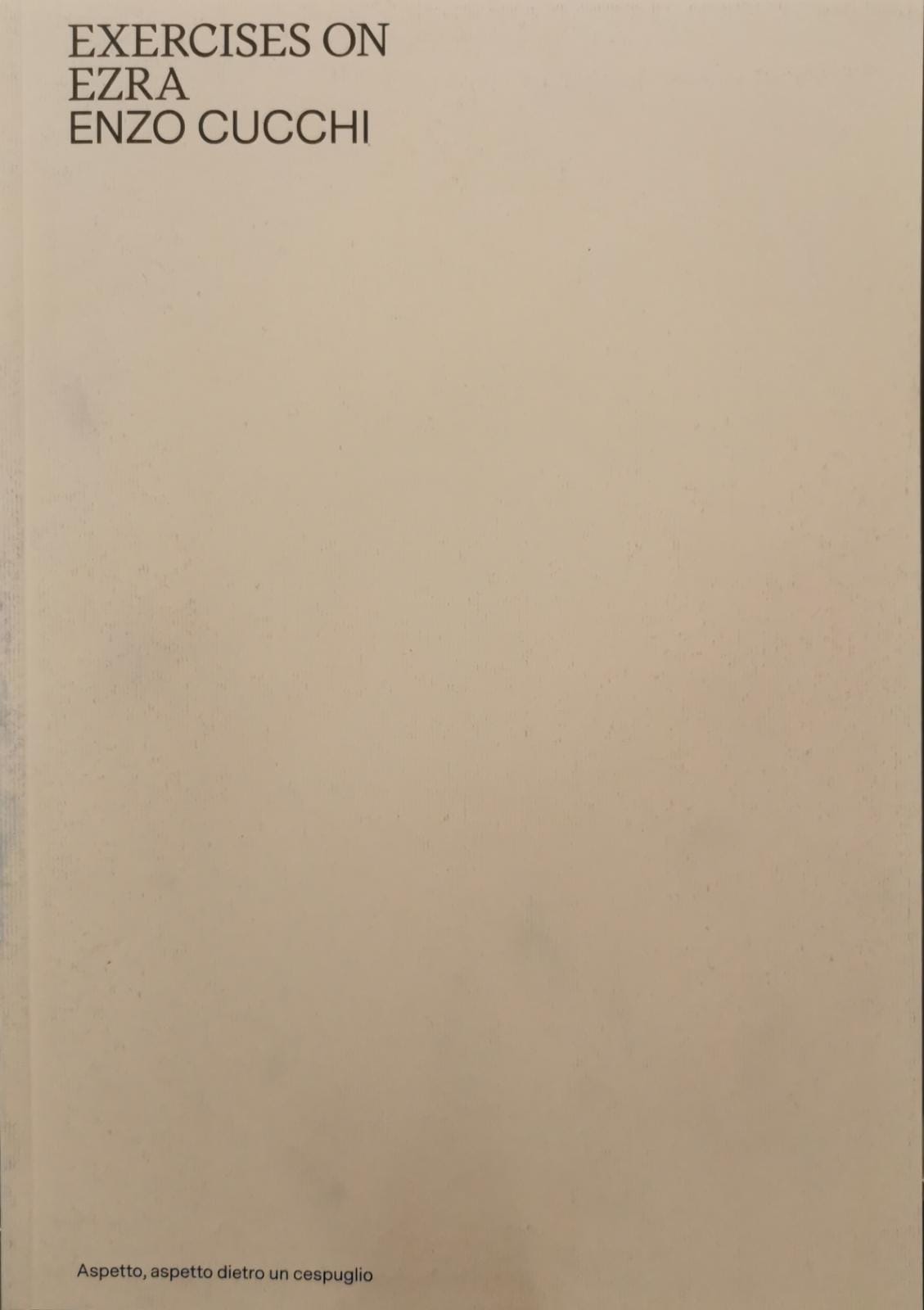Vi proponiamo in esclusiva, il discorso tenuto da Alberto Fraccacreta, il 24 giugno 2021 a Pistoia nell’ambito della manifestazione del Premio a lui conferito. Assegnista di ricerca in Letteratura italiana contemporanea presso l’Università degli Studi di Urbino, Alberto Fraccacreta poeta e saggista, scrive per Succedeoggi e per numerose testate giornalistiche nazionali. E’ fra i collaboratori del blog Rai Poesia, di Luigia Sorrentino.
La letteratura come gioia
Non è gioia se non nel dolore.
Eugenio Montale, Quaderno genovese
La letteratura come gioia. Mi rendo conto che è un titolo poco convincente. Ad alcuni potrebbe suonare persino retorico. È quindi consigliabile, se non necessario, il gioco delle etimologie per accattivare l’uditorio e per rivestire il nesso di almeno una parvenza d’interesse. Dunque. La radice etimologica di gioia proviene dal gaudium latino che è connesso all’idea di piacere, gaudere, e più addietro al jocum, al gioco — appunto — che produce allegrezza. (Ovviamente non si sta parlando della voluptas degli epicureisti e del giovane Marsilio Ficino.) Se però lasciamo le escoriazioni linguistiche greco-latine e ci rifacciamo per un attimo al verbo sanscrito ‘yuj’ — significa ‘unire’ o ‘legare’ —, la gioia diviene un sentimento che tiene ‘uniti’. Chi o che cosa?, verrebbe da chiedersi. E inoltre: la gioia è davvero un sentimento? Il gioco, anzi il jocum delle etimologie finisce qui. Con questi interrogativi sospesi. C’è da rimanerne delusi.
Be’, innanzitutto, bisogna domandarsi che ha a che fare la gioia, il tener uniti (chi, che cosa?) con Leone Piccioni a cui questo premio è dedicato. Prima di continuare con gli sproloqui pseudointerpretativi, desiderio ringraziare gli organizzatori, in particolare Paolo Fabrizio Iacuzzi, Gloria Piccioni e Nicola Fano per la loro fiducia e la gioia che davvero ci tiene uniti da anni con il webmagazine Succedeoggi. Dicevo che significa la parola ‘gioia’ per Leone Piccioni? Molte cose. Il volume che inaugura la casa editrice Succedeoggi Libri, Leone Piccioni. Una vita per la letteratura, curato da Gloria e da Silvia Zoppi Garampi,testimonia attraverso le voci di importanti studiosi, poeti e artisti l’humanitas di Piccioni: non soltanto la sua preparazione critica, il suo valente contributo alle humanae litterae, ma anche la sua amicizia, il suo essere solidale nei confronti del prossimo. D’altra parte, è ormai divenuto celebre il dittico aggettivale che lo accompagna: Leone Piccioni «maestro e amico». Desidero adesso insistere su un particolare della sua attività critica che bene aiuta a esprimere come la parola ‘gioia’ possa essere una risorsa per la letteratura odierna. Vorrei precisare, se non è chiaro, che il titolo di questa brevissima conferenza si rifà esplicitamente a un intervento ben più decisivo e gravido di conseguenze a opera di Carlo Bo: Letteratura come vita, pubblicato nel ’38 sulla rivista «Il Frontespizio», considerato un po’ il manifesto dell’ermetismo e anche la cifra peculiare dell’intero lavoro ermeneutico di Bo (il quale ha comunque più di un debito con il francese Du Bos, curiosa la vicinanza anche nominalistica tra i due).
Letteratura come vita è ben più attraente di letteratura come gioia, ammettiamolo. Però forse la letteratura come gioia possiede un’accezione più particolaristica e insieme universale. «Gioia, bella scintilla divina», diceva Schiller nella sua famosa ode che Beethoven riprese in quella magnifica esplosione di musica oggi divenuta l’inno dell’Europa ‘unita’. (L’Europa ha bisogno di gioia, ammettiamo anche questo. E di unione.) È necessario trovare l’angolazione corretta da cui scorgere questo sostantivo, gioia, nella sua giusta luce. Le parole, come sappiamo, invecchiano e vengono usurate dal tempo, dalle ideologie. C’è bisogno di una purificazione. Dal rinnovamento del linguaggio spesso può sorgere un rinnovamento, se non una palingenesi, delle idee.
Partiamo con Piccioni. Rileggendo Una perpetua poesia maggiore, il lungo saggio di Leone che apre Vita d’un uomo di Giuseppe Ungaretti nell’edizione «Oscar Moderni» (Mondadori 2016), mi viene in mente un’espressione, o meglio una categoria interpretativa e concettuale, che Marco Sonzogni nel Meridiano dedicato a Seamus Heaney (Poesie, Mondadori 2016) ha utilizzato per entrare nel merito della raccolta Seeing Things: la «santificazione della poesia». Vediamo uno squarcio del testo di Piccioni, in cui si parla del Dolore ungarettiano:
A un effetto addirittura di canto aperto, solenne, corale porta nel Dolore il tema della guerra. Il poemetto Roma occupata ha andamento di composizione sinfonica, ha i suoi tempi musicali, il suo coronamento. Ed il canto del dolore cocente, ancora è diffuso nel paesaggio: «Fa, nel librato paesaggio, ch’io possa / Risillabare le parole ingenue». Ed è la «pietra», son qui «segni», «quasi divine forme» entro cui si svolge, in contemporaneità di tempo, con l’ispirazione del poeta, la vicenda che non si può fare a meno di cantare, fino alla preghiera, alla preghiera più alta, finalmente liberatrice.
Piccioni continua la sua lettura della silloge citando forse i versi più importanti di tutta l’opera di Ungaretti, tratti da Mio fiume anche tu:
Cristo, pensoso palpito,
Astro incarnato nell’umane tenebre,
Fratello che t’immoli
Perennemente per riedificare
Umanamente l’uomo,
Santo, Santo che soffri,
Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli,
Santo, Santo che soffri
Per liberare dalla morte i morti
E sorreggere noi infelici vivi,
D’un pianto solo mio non piango più,
Ecco, Ti chiamo, Santo
Santo, Santo che soffri.
Giustamente Piccioni ha messo in rilievo il saliente passaggio dalla poesia alla «preghiera liberatrice»: ciò significa che lo spazio poetico si è santificato, è divenuto il luogo di perfetta adesione grazie a cui il poeta, nonostante il dolore, può riconoscere la ‘riedificazione’ dell’uomo. Ma ecco, anche, che la santificazione della poesia è diventata poesia della santità: «D’un pianto mio non piango più». La tragedia personale acquista un respiro cosmico: non è più ripiegamento su di sé, è misericordia, pietas e agape,solidarietà con la sofferenza altrui. E cos’è la poesia, infatti, se non umana solidarietà? Si è ‘uniti’ nel dolore. Se gioia significa unire, si può allora gioire nel dolore. Lo ha già anticipato Dostoevskij quando nei Fratelli Karamazov fa dire allo staretzZosima: «Conoscerai un grande dolore e nel dolore sarai felice. Eccoti il mio insegnamento: nel dolore cerca la felicità». Questo è un po’ il Leitmotiv di tutto il romanzo. C’è una differenza tra talesentimento e la gioia di scrivere della Szymborska o la solarità di Camus? Certo. Perché innanzitutto questo — e rispondiamo a uno dei primi quesiti posti — non è propriamente un sentimento, ma una ‘posizione’, un habitus esistenziale. Di nuovo Carlo Bo in Meditazione su Claudel, un saggio apparso nel ’37 sulla rivista «Letteratura», suggerisce che per comprendere le opere dello scrittore francese bisogna giocoforza assumere la sua personale prospettiva che definisce appunto la «posizione Claudel», un essere di fronte al mondo permeato totalmente dall’azione della grazia. Lì c’è la joie di un personaggio fondamentale nell’opera di Claudel, Doña Prouhèze, Donna Prodezza, la quale sostiene a chiare lettere che «là dove vi è più gioia, vi è più verità» (cito dalla traduzione di Simonetta Valenti della Scarpetta di raso, Le Château 2011).
Prima di rivelare che cos’è questa gioia indicata da Claudel, invidiata da Bo (che ammette di essere invece ancora nella posizione di Don Rodrigue, amato da Prouhèze), vorrei parlarvibrevemente di un racconto di Flannery O’Connor, Brava gente di campagna, che ho letto nella traduzione di Gaja Cenciarelli, presente nella raccolta Un brav’uomo è difficile da trovare recentemente riedita da minimum fax. Guardacaso la protagonista si chiama Joy ma si è autoribattezzata Hulga, è una filosofa raziocinante che non crede in nulla. È sedotta da un «sempliciotto», il classico «ragazzo di campagna», il quale dopo averla invitata a un appuntamento galante per i boschi ha l’ardire di sottrarle la gamba di legno (quella naturale era stata «maciullata da uno sparo durante un incidente di caccia») ed esporla come un trofeo. È un racconto abbastanza truce, contornato di un’ironia tragica. Un racconto davvero «brutale e sarcastico», etichetta che la O’Connor nelle lettere alla fantomatica «A.» ci rivela detestare. Sotto il profilo simbolico però — commenta la stessa Flannery, facendo una radiografia del testo nella raccolta di saggi Un ragionevole uso dell’irragionevole (minimum fax, 2012) — la gamba corrisponde all’«anima legnosa» della donna e in realtà il briccone, togliendole la protesi esistenziale che frena la sua adesione, le dona seppure per un attimo l’amore, la libera dalle ossessioni e dai lacci interiori che fino a quel momento le avevano impedito di vivere. Joy aveva perso la gioia e la grazia ha agito attraverso quel furfante per aprirle il cuore. La O’Connor non ci dice più nulla, il racconto finisce nel peggiore dei modi, ma è probabile che da allora Joy abbia abbandonato Hulga e sia ritornata Joy. La gioia riacquistata nel dolore.
Letture di questo tipo rientrano, a mio giudizio, in una dimensione interpretativa che potremmo chiamare ‘pneumocritica’, mutuando il prefisso pneumo- dalla speculazione teorica della filosofa Elvira Lops, autrice di un trattato di pneumanalisi antropologica, Credevo di essere qui, invece non c’ero (Aracne, 2020). Qual è la dimensione ‘pneumica’ del soggetto? Sicuramente non è la dimensione psicologica! Quindi, ci allontaniamo subito dalla psicocritica di Mauron e dal tentativo — ad esempio, del grande Giacomo Debenedetti — di leggere la letteratura alla luce della psicanalisi freudiana. La pneumocritica è un po’ una lettura ‘integrale’ del testo letterario, che tiene conto degli aspetti biografici, psicologici, esistenziali e simbolici, e prova a fissare il messaggio dello scrittore nelle regioni di frontiera tra l’io e il tu, tra lo scrivente e il destinatario, tra il soggetto e l’alterità.
Badiamo al sodo e facciamo un esempio concreto di pneumocritica. Prendiamo due versi da Iride di Eugenio Montale, forse i due versi che riescono a esemplificare meglio l’intera raccolta, La bufera e altro: «Ma se ritorni non sei tu, è mutata / la tua storia terrena». Interpretiamoli in termini biografici: il tu è Iride (o Clizia), cioè Irma Brandeis, donna amata dal poeta, americana studiosa di Dante, tornata a Firenze nell’estate del ’38 dopo qualche anno di assenza. In termini letterari: il ruolo di paladina dei valori umanistici e di «inconsapevole Cristofora» è traghettato in altre ispiratrici femminili (la Volpe) che ne prendono il carico e continuano la sua opera: dantescamente la sua femminilità ritorna in altre. In termini psicologici: il poeta vede Irma cambiata, ora è una «messaggera accigliata», il suo ritorno non ha più soltanto una valenza personale (era giunta a Firenze per ‘salvare’ Montale dalla disperazione di quegli anni) ma addirittura politico-metafisica (con il viaggio a Lussinpiccolo e a Parigi per organizzare le operazioni di salvataggio di molti ebrei in pericolo), e quindi cosmica, universale. L’interpretazione pneumocritica ricomprende tutti questi significati, aggiungendo un quid che ha a che fare con il tragitto esistenziale dell’autore: la potenza soteriologica del visiting angel non sostiene l’impalcatura religiosa, la domanda di salvezza che il poeta richiede. Dotato di un io carente, depotenziato, egli ha creduto di ottenere uno scampo storico e metafisico in una kafkiana «religione privata» (De Caro), ma tanto Clizia-Iride quanto le sue «metamorfosi tenebrose» (Cambon) conducono soltanto a conclusioni provvisorie, che apriranno alla nuova indagine sul dio dei filosofi di Satura. Inoltre, essendo la pneumocritica orientata a descrivere il contenuto ontologico delle relazioni, i confini interiori/esteriori dell’io e del tu, si può dire che le ‘tenaglie’ dell’io si allentano per l’insufficienza espressiva e la donna inizia veramente ad apparire come tu. Per la prima volta il soggetto lirico sembra essere di fronte a un tu, a un confronto con esso: è l’alba del tu nella poesia.
E ora arriviamo a Claudel. È pressoché impossibile riassumere l’antefatto della Scarpetta di raso, quello che è considerato il capolavoro claudeliano, un’opera teatrale sterminata che consta di oltre sessanta personaggi, pubblicata tra il ’28 e il ’29 e rappresentata solo molti anni dopo (con grandi difficoltà, peraltro). Il cuore della pièce è nell’amore impossibile, per varie vicissitudini irrealizzabile in vita tra Prouhèze e Rodrigue. Nell’unico incontro che hanno nel dramma, la famigerata scena tredicesima della terza giornata, si svela quello che è il testamento di Claudel, tutto il significato esistenziale della sua opera. Il suo messaggio, per utilizzare una terminologia jakobsoniana. Ripeto: causa vicissitudini varie l’amore tra Prouhèze e Rodrigue, benché uniti nell’anima (attenzione: ‘uniti’) da sempre, non potrà essere realizzato in vita. Il loro vero incontro è rimandato dopo la morte, in Dio, nell’eterno. Ed ecco la sostanza di questo scambio altissimo (per i significati letterari, filosofici e teologici) di battute:
Doña Prouhèze. — […] Io, io, Rodrigue, io sono la tua gioia! Io, io, io, Rodrigue, io sono la tua gioia!
Il Vice-Re. — Parola non affatto di gioia, ma di delusione.
Doña Prouhèze. — Perché far finta di non credermi quando credi a me disperatamente, povero infelice!
Dalla parte in cui vi è più gioia, è lì che vi è più verità.
Il Vice-Re. — A che cosa mi serve questa gioia se tu non puoi donarmela?
Doña Prouhèze. — Apri ed essa entrerà. Come fare per donarti la gioia se tu non le apri quella sola porta attraverso la quale posso entrare?
Non si possiede affatto la gioia, è la gioia che ti possiede. Non le si pongono condizioni.
Quando avrai fatto ordine e luce in te, quando ti sarai reso capace di essere compreso, è allora che essa ti comprenderà.
Il Vice-Re. — Quando sarà, Prouhèze?
Doña Prouhèze. — Quando tu le avrai fatto posto, quando avrai ritirato te stesso per farle posto, a questa cara gioia!
Quando la chiederai per sé stessa e non per aumentare in te ciò che le fa opposizione.
Perdere Prouhèze per Rodrigue significa perdere tutto, eppure lei lo invita alla gioia. Da questo bellissimo e terribile passaggio si capisce che essa non è un sentimento o, peggio, un’emozione (con tutto il rispetto per le emozioni). È qualcosa di più radicale, potremmo dire con lessico veteroheideggeriano di ‘ontologico’. È un habitus — si è detto —, un modo di approcciarsi al mondo, agli altri, alle cose. Nel succitato Letteratura come vita, Bo scrisse che «[la letteratura] è la vita stessa, e cioè la parte migliore e vera della vita». Se la gioia è la verità («dalla parte in cui vi è più gioia, è lì che vi è più verità»), e la verità è la vita, e la letteratura è vita, la parte più vera della vita, allora per un ragionamento induttivo la letteratura diviene claudelianamente gioia. Una gioia però che ha due parti, due tronchi dello stesso albero: la parte dell’esultanza propria del Magnificat ad esempio (Lc 1, 46-55), e la parte della stabilità, della solidità, secondo quando detto dalla Lettera di Giacomo, che parla di «perfetta letizia» (Gc 1, 2-4): «Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla». Ancora la gioia, la felicità nel dolore.Insomma, la letteratura tiene ‘uniti’. Chi e che cosa? Lo scrittore e il lettore, perché essi partecipano dell’umanità. La letteratura associa, è sociale perché mette insieme, rende una cosa sola. Continua a leggere→