di Alessio Alessandrini
Olimpia, la raccolta di versi di Luigia Sorrentino (Interlinea, 2013 ; Recours au pòeme éditeurs, 2015 traduzione in francese di Angèle Paoli) invita il lettore a inoltrarsi in un viaggio lirico quanto più lontano dalle ricerche poetiche del contemporaneo. Essa, infatti, immerge in una trama lirica dove l’oggettuale e il fenomenico, il materico sembrano latenti se non del tutto negati.
Ci si sente subito avvolti in una dimensione altra, in un paesaggio – quello mediterraneo degli ulivi e del biancore, degli afrori abbacinanti e della macchia oscura – di contrafforti, fitto di misticismo e sacralità.
D’altronde la ricerca poetica della Sorrentino ha come principale obiettivo lo svelamento del divino, e ce lo dichiara subito, fin dall’incipit, come a presentarci un orizzonte preciso e ristretto, in una zoommata precoce che ci introduce ex abrupto entro quello che verrà e che vedremo; lo fa in apertura di raccolta attraverso una brevissima quanto illuminante citazione presa in prestito da Hölderlin e dal suo Iperione:
“Non essere limitato da ciò che è grande,
essere contenuto da ciò che è minimo,
questo è divino“.
Hölderlin è, di fatto, la guida, neanche tanto nascosta, dell’operare della scrittrice. E’ l’ Hölderlin che critica il suo tempo così dissacrato e desolato, dimentico di spiritualità e divino. Ecco perché, pur concordando con quanto dice Milo De Angelis nella prefazione, confermato, poi, in postfazione da Mario Benedetti, questa raccolta è sì “orfica” e “spirituale, senza appigli al quotidiano e al contingente, atemporale e astorica, eppure appare così viva e presente, radicata nella contemporaneità e nell’oggi.
L’Olimpia con le sue macerie che la Sorrentino fa attraversare nei suoi antri e nei suoi giardini, tra muri e porte, tra varchi segreti e atri luminosi, fino all’epica epifania, è sì, certamente e metaforicamente, simbolo dell’esistenza nei suoi intimi e contraddittori passaggi, ma è soprattutto la maschera di una qualunque geografica identità del quotidiano dove assenza, sonno, immobilismo, vaghezza e indistinto, hanno preso il sopravvento su quanto di archetipo, originale, vivo e in movimento è stato dato alla nostra generazione, di quanto di divino essa abbia potuto e saputo sperperare.
Ecco, dunque, il motivo di questo cammino tra macerie e rovine, e chi legge non si attenda l’epica distanza dell’infinito e del sublime, una vastità d’orizzonte irraggiungibile, tutt’al più dovrà familiarizzare con la capacità di questa scrittura – che altro poi non è che “gratificazione” (cfr. pag 20) – di rintracciare il cosmico e il divino nelle minima e nelle ritualia.
L’apertura è quanto di più fenomenico possa esserci nel suo perentorio gioco assertivo: “lei era lì”, una presenza che, però, subito si rivela come mancanza, come impalpabile assenza, priva di volto e fisicità:
“lei era lì
non era più la stessa
il volto sbiancato nell’intangibile
nulla più le apparteneva” (pag. 13)
Nell’incipit ritroviamo sin da subito, poi, alcuni termini topici della raccolta, come, ad esempio: “volto”, oppure l’aggettivo “sbiancato”, (in tutte le varianti del bianco); se ne rintracceranno a bizzeffe in molti passaggi di Olimpia, come sassolini o fili di Arianna, pedine utili a non smarrire il senso del viaggio, a non cedere allo scorno dell’inanità e del platonico.
Olimpia, d’altronde, gioca molto del suo essere nella dimensione del simulacro, del fantasmagorico; questa “lei” – Olimpia stessa, città, vita, donna, anima, poesia? – la si perderà e recupererà in un susseguirsi di apparizioni e scomparse, tra soglie metaforiche, in una fluttuante dimensione spuria, fatta di passaggi e di varchi tra materico e immateriale, tra corporale e incorporeo:
“enormemente udita la soglia
il volto stava sulla parete
appena reclinato
le sue pupille erano bianche“ (pag. 14)
Fin da subito si percorrono i sentieri che giungono alla morte, all’impalpabilità, al buio ma nello stesso tempo la ricerca non si esaurisce come resa, e, nel chiaroscuro della luce e del suo fluttuare, questa insondabile entità femminea, può comparire nella sua totalizzante fisicità:
“nell’oscurità lo sbattere d’ali
la luce copriva, e tutto
stava su di lei e lei era
finalmente comprensibile“ (pag. 15)
È questa la tensione verticale, (siamo sempre più vicini al cielo, così risuona come un refrain un verso in differenti momenti della prima sezione della racconta, cfr. pag. 16, 19), che a volte si profetizza in un’ascesa, in altre si cristallizza in una voce atona, a volte si traumatizza in una delusione, perché non sempre – anzi, molte volte affatto – l’esperienza rivelatrice, l’epifania del divino si concretizza in un dono, piuttosto appare come esperienza di privazione, di negazione:
“il sole alle spalle cancella
i nostri volti (…)
all’ampiezza
offriamo il soffio qui adagiato
la bellezza che ci fu tolta
nella luce inesorabile
dello spegnersi” (pag.25)
E ancora:
“divina nell’occhio del cielo
solenne li sostenne la notte
che tutto precipitò
in questa pietra“ (pag. 27)
La vertigine spesso conduce alla caduta, e il furore conoscitivo finisce per accedere in luoghi dove nullo è chiaro, caso mai è torbido, cupo, impuro:
“- siamo tornati per scomparire
intorbidare il fondo -“ (pag. 29)
Paradossalmente Olimpia, città dalla luce bianca, città esposta e nuda, finisce per rappresentare un non-luogo, cuore di mistero e insondabile. Prigioniera del suo stesso nitore, bianca come una pietra tombale, come una pagina da interpretare, in un soprassenso di luce decade della propria materialità per precipitare, scomparire, dileguarsi. Il passaggio, quindi, l’attraversamento della “soglia” diventa immediatamente un allontanamento, un distacco, un crollo:
” – siamo colui che se ne va
abbiamo le sue gambe
le spalle, l’incedere veloce
la traccia del saluto
siamo colui che sprofonda
a un passo da noi – “ (pag. 30)
I primi due movimenti della raccolta, (ndr: L’antro e L’atrio), si presentano come atti di negazione; nel rifugio dell’antro e in quello dell’atrio, il passo finisce per confondersi e annullarsi, cedere in fallo. Non c’è ancora un gesto di salvezza, se non nel contrappunto tra il dove in cui ci si inoltra e quello in cui si finisce per perdersi. Un orizzonte degli eventi.
Ma anche ne Il giardino, la sezione dello stupore, dove si coglie, finalmente, “la luce improvvisa”, il luogo dove appare più probabile una chiarificazione, una concretizzazione dei corpi, una convivialità, lo svelamento si dimostra come processo che identifica non altro se non la natura effimera di cui siamo fatti, la nostra natura di simulacri:
“accedemmo dal fondo
dalla fessura ci sorprese
la luce improvvisa
che gettò su di noi
propagandosi dai grappoli d’uva
il caldo giallo dei limoni chiuse
in sé il canto delle foglie accese
la terra,
il nome degli alberi
camminavano in fila
simulacri“ (pag.33 )
La terza parte è quella, però, che nonostante tutto si apre alla possibilità: compare il tu montaliano (“ti seguivo nei campi …”; “andasti volgendo ancora”, a titolo esemplificativo), e soprattutto la lirica si traveste di una tiepida e pudica sensualità. Si diceva concretarsi una remota possibilità dell’incontro e dell’incanto, e ciò sembra concedere, finalmente, spazio a uno svelamento, un’epifania; ma è tutto fugace, troppo rapido, frutto quasi di un errore, di una colpa, impone una vergogna, una timida ritrosia, come quando ci sorprende il sole negli occhi e tutto è così acceso, troppo acceso, per poterlo sostenere, per crederlo – davvero – vivo:
“tra le mura dal fondo domestico
nascondesti il tuo giardino
rapido
da un unico sentiero
sotto viti ricolme
a capo chino dovevo seguirti
in un punto di svolta
sotto il cielo improvviso“ (pag. 37)
 Siamo nel regno del varco, nei pressi del passaggio, in terra di confine – altro termine emblematico della raccolta. La soglia si approssima. È questo il fulcro del poetare di Luigia Sorrentino. Qui si dichiara dove si è inoltrato il suo sentiero e a quale scopo, a quale rischio: scoprire la mèta d’ombra per comprendere il lato divino dell’esistenza.
Siamo nel regno del varco, nei pressi del passaggio, in terra di confine – altro termine emblematico della raccolta. La soglia si approssima. È questo il fulcro del poetare di Luigia Sorrentino. Qui si dichiara dove si è inoltrato il suo sentiero e a quale scopo, a quale rischio: scoprire la mèta d’ombra per comprendere il lato divino dell’esistenza.
Poesia del chiaroscuro, si dirà. Ma in questo passaggio ogni sostegno materiale crolla e più ci si avanza e ci si avvicina al passaggio, più si sente il passo sprofondare. Come se il segno del divino avvenga sempre per annegamento, battesimo, dunque; alla fine del percorso non può che apparire il lago, simbolico luogo della ritualità e della sacralità:
“Quello che di lì a poco sarebbe accaduto lo avremmo ricordato come un transito, un passaggio senza peso, privi di qualsiasi sostegno materiale. Poche volte quella vicinanza impropria e traboccante si sarebbe accostata a noi: «Siamo scesi qui per vedere l’ombra e il traguardo dell’ombra». L’umana sorte chiamava e aggiungeva, esponendosi e ritirandosi.” (pag.39)
Come fu per Dante, anche in Luigia l’approssimarsi al divino annulla completamente le dimensioni della realtà, il tempo deve cedere i suoi confini matematici e ciò che attende il lettore non può essere che sogno. L’inoltrarsi nel mondo dell’onirico, però, sembra congeniale al passo poetico della scrittrice perché queste pagine centrali, ad avviso di chi scrive, toccano i vertici della sua liricità con testi che colpiscono per la loro bellezza e forza evocatrice.
L’accesso nell’ultra-terreno è avvenuto attraverso un crollo: “lo spazio fu questo sprofondare / in un tempo in cui furono solo / il saccheggio e la voce ” (pag. 43); le forme sono perdute, il corpo è sospeso in un vuoto, così in un iperbolico e crescente gioco di sensazioni, si compie l’atto quasi violento dell’apparizione, una penetrazione orgiastica e cosmica, dalla mostruosa forza generatrice:
“e quando il dio le entrò dentro
più forte adunò tutti i fiumi
nel suo volgersi e rivolgersi
vestita di nebbia l’essenza eterna
incontrò il nostro apparire“ (pag. 46)
La poesia si erotizza e il gesto della creazione è un gesto palingenetico, cosmogonico; eppure nella sua crudezza e feroce bellezza, questo “miraggio sventrato”, (pag. 48), viene superbamente narrato dalla poetessa napoletana.
Ma, ancora una volta, al vertice dello svelamento viene prospettato un crollo, una decadenza. Non a caso il tutto avviene in insistente ritrovarsi di macerie e rovine; ossessiva è la domanda “è quella la porta?” come a chiedere invano una scappatoia, un passaggio salvifico, come a manifestare un dissenso di fronte a questo rovinoso paesaggio che si sarebbe voluto tanto differente.
Il ricorso agli inserti in corsivo, nella sua dorma anaforica, è sicuramente elemento topico della raccolta, essi rappresentano degli appigli materici nella loro paradossale inconsistenza (ossessioni? voci guida? fantasmi?) che permettono alla poesia di Luigia Sorrentino di evitare, nel frangente, lo scorno – sempre in agguato – di una vaghezza troppo eterea e di un misticismo troppo enfatico. C’è, dunque, una ricerca (ndr: è quella la porta?) e c’è un corpo vissuto (ndr: qui visse la donna). La sacralità è in questo avanzare verso il varco, e proprio la scomparsa coincide con essa, la verità con l’offesa, e il tornare indietro somiglia a una trappola dove, tra sprofondi e macerie, si liofilizza quel che è stato, o meglio quel che si sperava fosse stato. A questo punto l’esperienza ha perduto i suoi connotati di umanità e la prospettiva riduttiva di uno spazio-tempo calcolabili, si è trasformata in una totalizzante inanità:
“il volto suo era sbiancato
da una malattia che opera in sé
un costante stringere
scendeva dalle palpebre socchiuse
irradiava luce
non vi era più nulla attorno a lei
oltre la soglia l’umano era deposto
per questa via unica vennero
custodendo tutte queste cose
nel loro cuore
forgiando la purezza ai bianchi
polsi“ (pag.51)
Finalmente si è concretizzato l’incontro epifanico, eppure alla domanda antichissima si è prospettata una risposta altrettanto antica nella sua negazione, è l’ombra della morte a fare capolino (ndr: l’urna), balugina severa dietro al contatto con la divinità, e il gesto della creazione è pur sempre il frutto sanguinoso di una ferita, un buco nero che dematerializza, smemora. Si prenda, ad esempio, la prosa che chiude la prima parte del libro, vertice di potenza evocatrice e di carica erotica, con la metafora, sontuosa nella sua sottigliezza, che paragona l’atto conoscitivo e generatore, all’esplosione cosmica:
“Chiamava da una cavità morbida e sotterranea, vivente nella furia di un amore che atteneva soltanto a lei. Pulsava l’essenza perenne, rigenerandosi da sola, senza interruzione. Al taglio improvviso della carne, ci gettò contro le nostre stesse viscere, i nostri organi, con gli escrementi. Ci tenne lì, in una lunga attesa, ci nascose, mentre lei si espandeva larga, liquida e piena. In sé contenne l’umido spazio della notte.” (pag. 53)
Questi i versi che concludono la prima parte di Olimpia, si tratterebbe, pur nell’ennesima contrattura, nella successione di fratture e ferite, di una gestazione felice nel suo sofferto e lento travaglio, se tutto, finalmente, ritornasse pacificato nella congiunzione.
Eppure, nella sua dilatazione massima il movimento lirico di Olimpia si contrae in una seconda parte altrettanto intensa e difficile, non più in ascesa, bensì in una precipitosa caduta. Nel manifestarsi del divino, infatti, si rispecchia il dissolvimento dell’umano, che scoprendo la sua limitata e fallace vanità, vede il vertice aprirsi in un precipizio. Da qui il canto si fa corale, contro-canto oraziano altrettanto sublime quanto tormentato. L’uomo non riesce a sostenere la discendenza divina, pare confessarci nei suoi versi Luigia Sorrentino, o meglio il Dio che si rivela ha un’immagine altra, mutila, impietosamente mostruosa, (ndr: Quando mi voltai mi venne di fronte nel suo biancore una divinità decapitata. – Il confine, pag. 63), e all’uomo non resta che fare i conti con la propria limitatezza e sconfitta:
“abbiamo perso tutto
caduti in un eterno
frammento
la prima luce su noi
infuocata ha bruciato tutto
la prima creatura di umana
bellezza è morta, ignota
a se stessa
i popoli appartengono alla città
che li ama
privi di questo amore ogni stato
scheletrisce e annera
la natura imperfetta non sopporta
il dolore” (pag. 62)
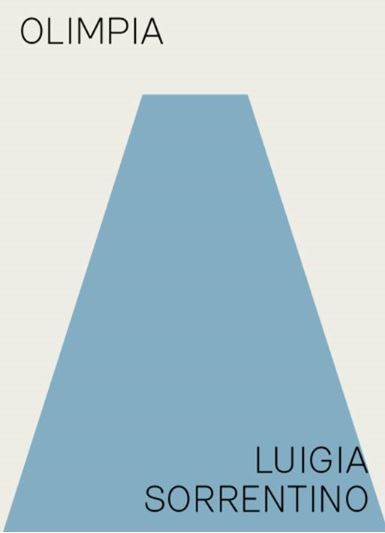 “La notte arcaica”, originaria traccia del nostro essere gettati al mondo, nello stupore stellato del movimento generatore, resta pur sempre una notte, nel suo cupo dissolversi di ombre e indistinto. Tutto, allora, è definitivamente perduto? Pietrificato? Apparentemente, sì, se sostiamo al solo elemento carnale dell’esistente, ma è in questo frangente che fa la sua comparsa l’anima (pag. 65) e il cammino può continuare, pur se in un a ritroso ritorno al punto di partenza.
“La notte arcaica”, originaria traccia del nostro essere gettati al mondo, nello stupore stellato del movimento generatore, resta pur sempre una notte, nel suo cupo dissolversi di ombre e indistinto. Tutto, allora, è definitivamente perduto? Pietrificato? Apparentemente, sì, se sostiamo al solo elemento carnale dell’esistente, ma è in questo frangente che fa la sua comparsa l’anima (pag. 65) e il cammino può continuare, pur se in un a ritroso ritorno al punto di partenza.
Due sembrano rivelarsi gli atteggiamenti possibili come resistenza a questo processo di pietrificazione e annullamento: la permanenza nell’incanto, mirabilmente metaforizzata dalla statua, e il rifugio nel sonno, (ndr: che in napoletano vale anche per sogno), nella veglia onirica che concede un pur effimero movimento nello smarrimento.
Nel primo caso l’immobilismo, la staticità del biancore, del gesso, del marmo, concede, però, la carezza, il soffio del divino, che pur nella sua distanza si concede sotto forme di consolazione spirituale e fluttuante:
“è il morire che vedo
il venir meno, questo
incepparsi improvviso del respiro
mentre si accascia il nostro fare
allora sei tu che stendi la mano,
a soccorrerlo
in un solo gesto apri la notte“ (pag.72)
In questi versi è il gioco sinestetico a sostenere il tutto, a far strumento poetico dominante; vocaboli come: tatto, carezza, dita, tepore, soffio, respiro, si rincorrono in un verseggiare franto e salmodiante che non solo concretizza metricamente il singulto dolente della carne che muore, ma riproduce, anche, il desiderio nascosto del movimento, (chiede l’uomo il movimento, dice un verso a pag. 72), del fluttuare evanescente dell’anima che traspare nello stesso trasmigrare pietrificato del corpo:
“ecco di cosa moriamo
l’animale umano costretto
si ritrae
nella rupe di marmo
della sepoltura, veniamo meno,
stanchi come colonne
spezzate dalla furia
del potente, caro ci fu ingoiare
il rimasuglio della nostra vita“ (pag. 75)
Siamo nel regno che ha fatto grandi poeti come Celan o Bonnefoy, si pensi a certi passaggi di “Movimento e immobilità di Douve”, solo un cenno a presumibili maestri che però permette di sottolineare a quale vertice poetico arrischia la scrittura di Luigia Sorrentino e a quale cura deve soggiacere una qualsiasi lettura della stessa.
Per tornare al testo occorre dire che in una dimensione liquida, dove a poco a poco ogni forma finisce per dissolversi e decadere, lo smantellamento permette però di tornare vivi e puri a una originalità primigenia dimenticata, “ritorniamo arcaici” (cfr: La deformazione, pag. 79), e quindi ci viene quasi inaspettatamente concessa una seconda possibilità, una rinascita.
Il sonno, si diceva, è poi l’alternativa forma di resistenza alla spogliazione dell’umano; ma qui a venir meno non è tanto la carnalità quanto il psichico incarnato nella dimensione spazio-temporale:
“la condizione umana chiude
in sé la forma del tempo
che non vuoi più, allora
ti incammini tastando
muri che non vedi, conosci
la disaffezione
negli occhi scende … “ (pag 83)
“frana il terreno, scende,
nessuno lo fermava …” (pag. 85)
Ancora una volta sembra chiudersi definitivamente e disperatamente in uno scacco la voglia conoscitiva del verseggiare di Luigia Sorrentino; nell’immobilismo e nella cecità, troppo fermi davanti a tanta luce o troppo pieni di essa per aprire gli occhi e avanzare, anche fosse a tentoni, c’è forse un’ultima possibilità di procedere?
“eravamo saliti sul monte
verso la colossale figura del tempio
ridotto in macerie
dopo la terribile lotta tutto era svanito
la morte si era aperta …” (pag. 93)
o non resta che la sola tentazione del silenzio?
“tutto si era placato fra i tronchi
dei lecci
senza steli stavamo sulla spianata
trasportati qui dove si tace di gioia,
tace su tutto chi possiede
quello spirito del futuro
sopra le rovine” (pag. 94),
è questa, dunque, la resa? A questa sconfitta occorre, al fine, sottostare?
Sarebbe fin troppo facile abituarci all’assenza del divino, ci avverte nel suo mirabile finale Luigia Sorrentino, un lusso troppo presuntuoso, o un fare da ignavi. Ecco, allora, che, in un verso atroce nella sua luminosa e ferma perentorietà, il Nostro rivela un’ulteriore possibilità:
“ciò che crediamo perduto possiamo
riaverlo, te l’ho già detto,
spopolato!
non scompare la fonte
tesse il suo divino l’umano …” (pag. 95)
è l’invocazione netta all’azione, al fare, al costruire il divino in ciò che umano; questa invocazione permette la visione del “giovane monte” e la scoperta de “la sua bellezza raccolta in una / sola luce liberata” (pag. 96).
Non occorre irretire di fronte alla colossale grandezza del divino, (sempre e soltanto celebrato nella sua forma minore, parola, infatti, esclusivamente indicata in ogni suo passaggio con la lettera minuscola), alla sua mortale verità; e se il divino non si può fare uomo, (Dio è morto ci hanno detto già da qualche anno …), è invece l’umano che può rintracciare una propria e limitata dimensione divina, una nicchia di gioia nella sua eterna ignoranza. Dalle macerie, infatti, risorge vivida una nuova Olimpia, e nel finale a risuonare non sono le note di un requiem ma “il canto dell’umano a cui nessuno resiste” (pag. 99).
Il canto è allora l’unico strumento che può sconfiggere la deriva nichilista. Il canto della poesia, nella sua manifestazione di azione che si fa, che si costruisce (Poyesis!?). La raccolta di Luigia Sorrentino si conclude con una proposta, come dovrebbe essere per ogni percorso artistico che abbia un senso non solo estetico ma anche etico.
Se c’è un solo modo di conservare la sacralità nel mondo contemporaneo, mondo consacrato alla morte e all’immobilismo, mondo cieco e addormentato in un estatico sortilegio, quello è da ritrovare proprio nel dove risiede l’assenza del bello, per scavarne la bellezza proprio dove esse manca:
” Olimpia, gioia di esseri non esperti di gioia!” (pag. 99)
È, quindi, nell’imperfezione, nella limitatezza, nella ricerca mai conclusa sempre aperta, nel suo stesso farsi conoscenza, la fonte, “la porta“, per una rinnovata umanità, quella che consapevole del proprio confine lo rovescia in orizzonte di eternità.
La raccolta di Luigia Sorrentino, dunque, ha il merito di sondare il terreno del mito, di votarsi all’Epos, proprio in un’epoca, quella attuale, dove deserto e aridità sembrano averlo definitivamente sconfitto. In un canto che si fa universale, (Luigia Sorrentino non teme di ricorrere alla Prima persona plurale), nel suo franto dipanarsi dal pianto all’orazione, sta la forza propulsiva di una poesia che, proprio perché rischia in ogni suo verso la ridondanza, sa imporsi per la nettezza e la capacità propositiva.
Orfica sì, spirituale e metafisica, ma così tanto radicata nella sua voce da non poter essere disattesa, restare inascoltata.

