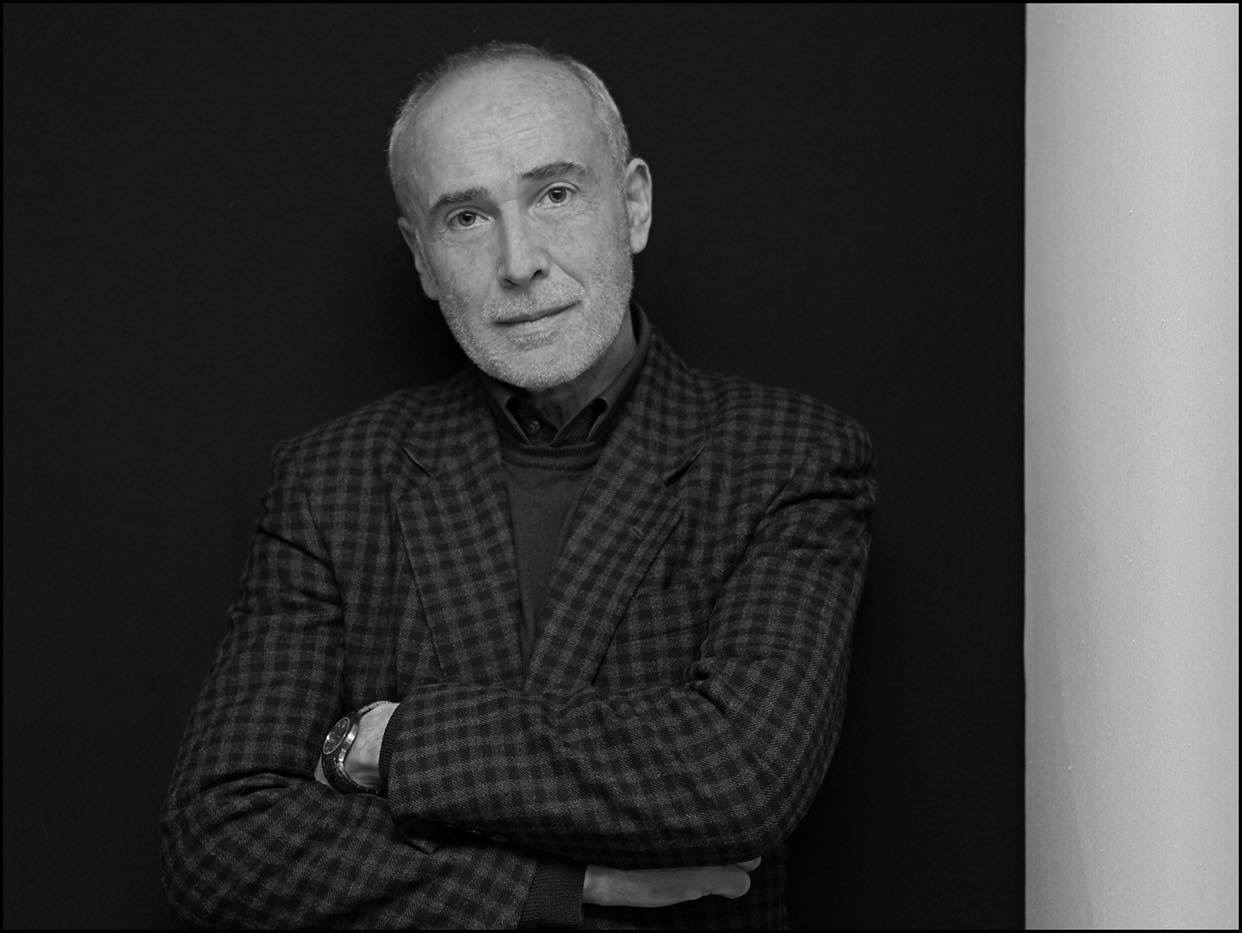
Mario Benedetti, poeta italiano, Foto di Dino Ignani
di Andrea Gibellini
Mi viene chiesto di scrivere sulla poesia di Mario Benedetti e devo rispondere in tutta sincerità che la sua poesia non è mai stata tra le mie predilette. Altri poeti sono stati per me importanti. Se devo fare qualche nome, se il concetto di generazione poetica serve a definire qualcosa, poeti nati negli anni cinquanta in ordine sparso, sicuramente non esaustivo, come Pagnanelli, D’Elia, De Angelis, Ceni, Scarabicchi, Pusterla, Magrelli, Damiani, Anedda, la poesia dialettale di Villalta, come la poesia di cosciente confronto sperimentale e teorico di Giuliano Mesa, sono stati fertili letture. Ognuno ricerca e riscrive una tradizione poetica affine al proprio sentire, non penso così lontana da un percorso che si stava facendo due decenni ― metà e fine anni ottanta, in particolare ―, prima della fine del secolo scorso. Bertolucci, Luzi e Caproni, Fortini, Zanzotto, Giudici, erano in attività, Montale e Sereni da poco scomparsi (Stella variabile, il primo vero spartiacque del dopo Montale, è del 1982).
Facendo una riflessione generale, la poesia di Mario Benedetti sconta il fatto, ma il discorso è davvero più ampio, di non aver affrontato criticamente ― non per mancanza di accanimento e furore verso la poesia come dimostrano le sue dichiarazioni di poetica, ma per una sua esigenza, direi inevitabile, di stare con la creatività della poesia nel contraccolpo di una sorta di egotismo esistenziale ―, di non aver messo in atto, in sintesi, seppure in modo soggettivo, da poeta, l’urto storico tra poetiche, autori, generazioni. La discussione sulla poesia degli altri mettendo in discussione la propria. Il suo non è stato un atteggiamento arbitrario, è stato il compimento di un modo d’essere in relazione con un determinato modello di poesia. Continua a leggere
