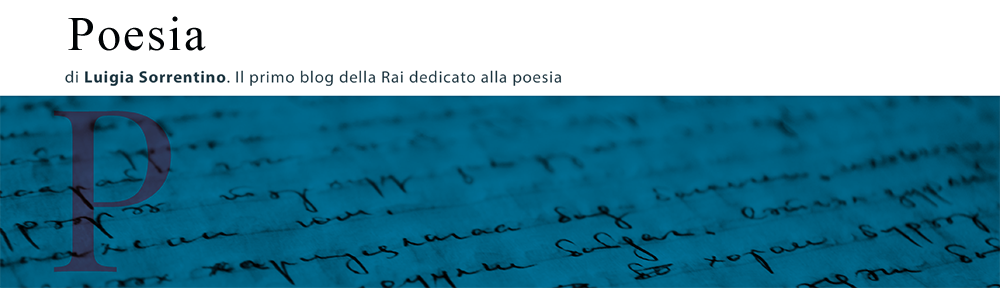Giusi Sorrenti
Necessità come fonte del diritto e libertà sospese?
di Giusi Sorrenti
Negli ordinamenti democratici dell’Occidente contemporaneo è stato necessario, non un tiranno, ma una zoonosi irradiatasi nella provincia cinese del Hubei per soffocare le libertà a colpi di decreti del Presidente del Consiglio, riproducendo nell’immaginario collettivo la figura, già condannata dal recente passato, dell’“uomo solo al comando”. Alcuni, dinanzi alle drastiche limitazioni imposte ai cittadini per scongiurare il dilagare dell’epidemia ed il collasso delle strutture sanitarie, hanno invocato l’estrema reazione della disobbedienza civile. Il richiamo immediato è andato al mito di Antigone, l’eroina più grande d’ogni tempo, che si ribella alle leggi della città per ribadire il suo senso di umanità. Due i valori oggi da difendere: la democrazia (forse cara solo ad alcuni) e la libertà. Cominciamo dalla prima.
La storia costituzionale e i suoi studiosi conoscono molto bene i pericoli che l’emergenza comporta per la democrazia. Il filosofo del diritto Carl Schmitt includeva nel funzionamento dell’ordinamento la previsione dello stato d’eccezione, ipotizzando il sopraggiungere di un momento nel quale si sarebbe reso inevitabilmente necessario abbandonare le procedure democratiche per imboccare un’altra strada. È l’idea dello “stato di necessità” come fonte del diritto. Una clausola simile era stata inclusa nella Costituzione di Weimer adottata in Germania nel 1919 ed è tristemente nota per aver consentito l’avvento al potere di Hitler. L’esperienza insegna a diffidare da queste visioni teoriche o da altre affini, per lo spirito illiberale che le pervade e che si manifesta nel lasciare aperta all’interno dell’edificio giuridico una falla per sfuggire da quelle che sono considerate le pastoie decisionali dei Parlamenti moderni.
Anche riguardo alle modalità di gestione dell’epidemia è serpeggiata la convinzione che si sia fatto ricorso nel nostro Paese a procedure extra-giuridiche, aprendo una fase di “sospensione costituzionale”. Ciò ha sollevato dubbi sulla sua durata e sulla possibilità di ritornare presto o tardi alla piena fisiologia. La perplessità è legittima, anche se sottende al fondo il messaggio che le procedure democratiche siano un lusso per i tempi facili, che non ci si può permettere in quelli difficili, dimenticando che la Costituzione è stata scritta da giuristi che avevano attraversato uno dei momenti più bui della storia del pianeta. Un atteggiamento nel quale si annidano, come ha notato recentemente il Presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano Silvestri, «cesarismo e bonapartismo, ritenuti – a destra e a sinistra – fattori di accelerazione del cambiamento politico e sociale, in contrapposizione all’equilibrio del vecchio Montesquieu, considerato fattore di immobilismo e di conservazione». E non è un caso che, nel momento in cui la politica come sede di canalizzazione (delle varie visioni) dell’interesse generale del popolo implode su scala planetaria nel più grave collasso mai sperimentato, svuotando di sé le sedi della democrazia parlamentare, prendano sempre più piede le forme di una “democrazia dell’acclamazione”, basata sul rapporto diretto dei cittadini con il loro capo, che offrono ai consociati in cambio di quanto si è perduto al massimo un’illusione o un surrogato di sovranità.
La democrazia tuttavia non può subire congelamenti o sospensioni ed è la stessa Costituzione italiana vigente che, pur non prevedendo espressamente un diritto speciale per i tempi eccezionali, come ha ribadito l’attuale Presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia contiene una bussola per orientarsi durante le tempeste. Il suo art. 77 dispone che in casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo adotti sotto la sua responsabilità decreti-legge, consentendo che le norme regolative della vita dei consociati siano dettate dal potere esecutivo invece che dal potere legislativo, ma decadano retroattivamente – come se non fossero mai esistite – se non ottengono in un breve termine l’avallo del Parlamento. Nel nostro caso, le norme regolative dell’emergenza non sono state poste dal Governo con questa procedura, che assicura pur sempre il controllo dei rappresentanti, ma sono state assunte monocraticamente dal vertice dell’Esecutivo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nondimeno, i decreti presidenziali sarebbero riportabili al dettato della Carta fondamentale attraverso una lunga e tortuosa catena normativa. Ripercorriamola in breve: il decreto-legge n. 19/2020 (correggendo l’infelice e troppo generica – una sorta di norma in bianco – formulazione del primo decreto-legge sull’emergenza, il n. 6/2020), richiama il d.lgs. n. 1/2018, che recepisce il Codice di Protezione Civile e che, all’art. 7, consente al Governo di dichiarare lo stato di emergenza, attivando una serie di poteri essenzialmente concentrati nelle mani del Presidente del Consiglio. Di qui i famosi DPCM: un meccanismo decisionale rapidissimo, elastico e facilmente adattabile di giorno in giorno, seguendo come un sensibile sismografo l’evoluzione della pandemia. La compatibilità costituzionale delle disposizioni di Conte troverebbe così sostegno in una sorta di “doppia legittimazione”, secondo cui – grazie al d.-l. n. 19 ed al d.lgs. n. 1/2018 – il ricorso ai decreti presidenziali risulterebbe valido, agganciato ad una concatenazione di rinvii normativi che lo riconduce nell’alveo costituzionale.
La Costituzione è dunque salva e anche nella tempesta la sua guida ha tenuto fermo il timone della nave lungo la rotta.
Resta la perplessità che attraverso un gioco di rinvii si possa dischiudere una sorta di “universo parallelo” in deroga al sistema delle fonti vigente, aggirando la scelta compiuta dalla Costituzione di non esautorare mai del tutto il Parlamento, di cui viene preservato l’intervento in fase di controllo a posteriori delle scelte compiute dall’esecutivo. Una volta smantellate, anche episodicamente, le impegnative forme della deliberazione democratica, si potrebbe essere tentati di adagiarsi definitivamente sulla semplice scappatoia del decisionismo del leader, che sembra più in armonia con un’epoca in cui la complessità della ricomposizione del pluralismo sociale tende ad essere rimossa e la politica ad essere percepita, come ha notato di recente il filosofo Runciman, quale un “fastidio analogico in un’era digitale”. Per il futuro sarebbe bene predisporre le condizioni per restituire all’art. 77 Cost. la sua centralità. Per farlo, occorrerebbe snellire i tempi solitamente richiesti dalla conversione dei decreti-legge che, per sua natura, esigendo (art. 74, co. 4, Cost.) la discussione e l’approvazione con il procedimento ordinario (in aula), ha ritmi di adozione poco consoni alle tempistiche emergenziali. La soluzione che è stata proposta è una modifica dei regolamenti parlamentari che preveda per la legge di conversione l’adozione del procedimento “decentrato”: l’approvazione nella sede ristretta della commissione parlamentare soddisfarebbe al contempo il requisito della celerità e quello del rispetto del necessario distanziamento (data l’esiguità dei componenti delle commissioni rispetto al plenum delle Camere).
Soluzioni tecniche per non archiviare con troppa leggerezza le forme democratiche, e con esse la garanzia che le decisioni siano assunte dai rappresentanti dei cittadini, dunque esistono e la lungimiranza consiglierebbe di adottarle, anche a voler auspicare che la previsione degli scienziati, secondo cui l’attuale pandemia non è affatto l’ultima, si riveli errata.
Oltre che sul funzionamento della macchina statale, l’emergenza ha inciso sui rapporti tra il livello di governo statale e quello regionale. Su questo versante, essa ha messo a nudo molte disfunzioni dell’intreccio di competenze tipico di uno Stato decentrato o autonomista, come il nostro: da una parte si è rischiata la paralisi degli interventi, quando era necessaria l’assunzione di decisioni impopolari, dall’altra la loro sovrapposizione, quando si profilava l’adozione di scelte demagogiche. Il criterio di coordinamento tra i diversi piani di governo in Costituzione esiste: l’amministrazione della macchina sanitaria spetta fondamentalmente alle Regioni, ma sulla base della disciplina uniforme dettata dallo Stato, che può essere concertata con gli enti autonomi.
Anziché pensare ad un incremento del tasso di centralizzazione del potere sarebbe più utile, perciò, riflettere su un anello debole – vero tallone d’Achille – del sistema, venuto alla luce in questa circostanza. L’art. 32 Cost. tutela la salute come diritto individuale e come interesse della collettività ed è proprio in questa seconda accezione di bene comune che la “sanità” compare nell’art. 16 Cost. come uno dei soli due valori la cui protezione può giustificare limiti alla libertà di circolazione dei cittadini. Su queste basi, ci si può chiedere se è compatibile con il quadro costituzionale che i vertici delle strutture ospedaliere siano di nomina politica, posto che devono agire nell’interesse generale della collettività e non nell’interesse parziale di uno o più partiti. Altrimenti, può accadere che scelte dissennate o politicamente compiacenti dei dirigenti sanitari prima producano effetti devastanti, mettendo in pericolo la salute pubblica, e poi, paradossalmente, finiscano per legittimare limitazioni dei diritti fondamentali – prima tra tutti proprio la libertà di circolazione – resesi irrimediabilmente indispensabili per fronteggiare quel pericolo. Il ripensamento dei criteri di nomina si impone anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, secondo cui il metodo dello spoil system applicato alla pubblica amministrazione è ammissibile solo per gli uffici di diretta collaborazione con il Governo e non per gli incarichi gestionali: a vietarlo qui è l’imparzialità dell’azione amministrativa che non tollera, a garanzia dei cittadini su cui va ad incidere, di essere mossa da interessi di parte (art. 97 Cost.).
E veniamo così ai diritti fondamentali, fortemente compressi dal lockdown tanto da instillare in tutti il dilemma se la difesa della vita conti di più della stessa libertà. La salvaguardia costituzionale del diritto alla vita non si spinge fino ad imporre un dovere di vivere (tanto che l’ordinamento non punisce chi tenti il suicidio), ma il discorso sarebbe più problematico se per la libertà di alcuni (o di molti) si mettesse a repentaglio la vita di molti (o di alcuni). Che l’ordinamento protegga il diritto alla vita significa che non lo lascia in balia della disponibilità altrui, in una cinica riedizione del motto mors tua vita mea. La questione si complica tenendo conto di ulteriori variabili: le limitazioni della libertà imposte dal confinamento sociale, secondo gli esperti delle varie branche, producono danni non solo economici, sociali, morali e culturali, ma anche per il benessere fisico dei cittadini che li hanno subiti. Non solo i danni per la vita relazionale ed affettiva, oltre che per la vita culturale, sono elevati se si pensa ai ragazzi privati innanzitutto della scuola (ed anche agli adulti privati di cinema, teatro, spettacoli musicali, etc.), ma si è registrato un più difficile accesso alle cure per i portatori di malattie di diverso tipo, pregiudicando lo stesso bene della salute che in partenza si voleva proteggere. Il punto di equilibrio da ricercare non è allora nell’assolutizzazione della vita o della libertà – che farebbe dell’uno o dell’altro un valore tirannico – ma nella proposta di scelte politiche che individuino la soglia di rischio dei contagi tollerabile, nel senso di sostenibile per il sistema sanitario in concreto esistente, che deve avere la capacità organizzativa di impartire le cure necessarie. Tale soglia di rischio dev’essere poi concretamente tradotta nel grado presumibilmente corrispondente di riattivazione delle attività socio-economico-culturali.
La delicata valutazione va compiuta rifuggendo dalla logica di massima che ci sia un sacrificio ammissibile, un costo da pagare come un obolo per riconciliarsi con la divinità del mercato produttivo, rimettendo in moto l’economia. In un’epoca che, parafrasando Oscar Wilde, “conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla”, può essere utile ribadire che, data la centralità della persona e della dignità nella Weltanschauung dell’ordinamento, la vita umana non ha prezzo. È anche bene ricordare che costituisce un traguardo delle Costituzioni contemporanee il superamento – con l’imputazione ai pubblici poteri del compito di tutela della salute e l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale – della fase precedente in cui lo Stato poteva incidere arbitrariamente sulla vita dei sudditi e addossava esclusivamente al singolo il rischio di morire per malattie.
Alla luce del quadro costituzionale, il senso di pietas, in nome del quale Antigone sfidò il potere ed andò incontro alla condanna, nella realtà di oggi troverebbe corrispondenza nel recupero dei legami solidaristici, interpersonali, intergenerazionali ed interregionali, più che nella esasperazione egoistica delle libertà individuali.