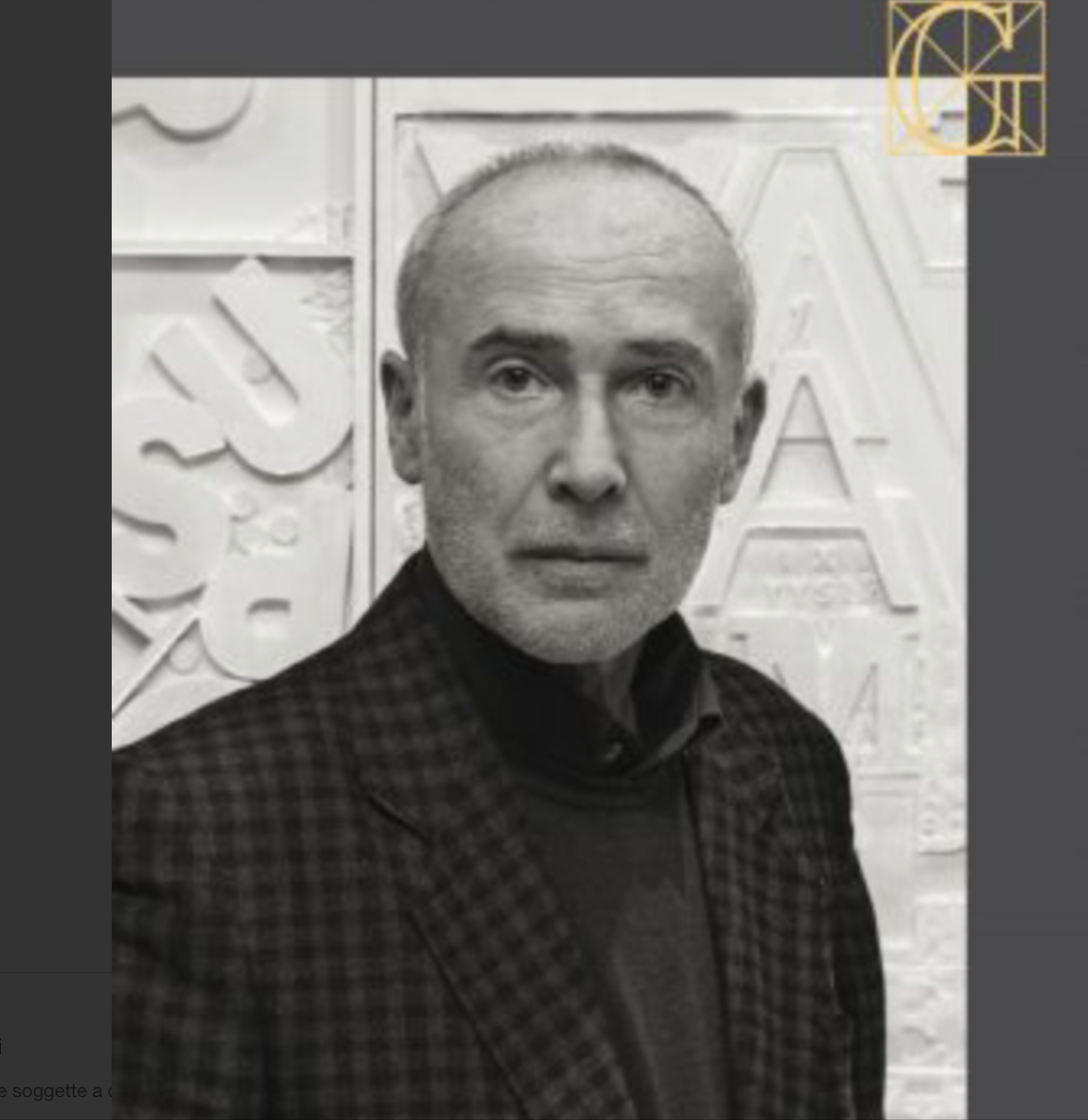 di Lorenzo Chiuchiù
di Lorenzo Chiuchiù
Adamisti – così Nikolaj Stepanovič Gumilëv chiamava gli acmeisti: non solo lo sguardo che coglie il punto culminante di una realtà; non solo l’equilibrio vertiginoso che fa coesistere nell’istante lo slancio ascensionale e la discesa presagita e imminente. L’acmiesmo è anche, dice Gumilëv, lo sguardo nel giorno in cui il mondo fu creato.
La poesia di Mario Benedetti vuol essere questo primo sguardo sul mondo. Le parole più che segni fonici o rimandi sono masse, corpi e sentimenti che compaiono da un silenzio di tenebra che sembra contenere da sempre la loro storia e il loro malcerto destino. Paratassi, anafora, refrain, coordinazione più che subordinazione, elenchi più che progressione: lo sguardo di Benedetti è fedele a un dettato puro, senza condizioni né legami; non esiste rete sintattica perché il mondo è puntuale, disgiunto e ogni sua singola realtà istantaneamente sfolgora o si acceca. In principio la storia non era, ciò che sarà non potrà se non illusoriamente diventarlo. Esiste semmai la fiaba come mito en petit tutto interno a una memoria biografica; esiste una melodia minima, a volte inconsapevole e sempre minacciata: chi è senza retorica è anche senza difese. Esistono i primi piani, gli unici possibili per vedere davvero le cose come res amissa (di qui la distanza di Benedetti dal realismo che conosce solo la res extensa). Si tratta di nominare le cose come sognava Rilke: «dirle così / come mai le cose stesse / intimamente sapevano di essere».
L’opera di Benedetti non è un ritorno all’innocenza dopo i vicoli ciechi delle poetiche del ‘900; il poeta non è mai uscito dal suo primo sguardo sul mondo: il mondo nuovo della distruzione del terremoto del Friuli del 1976, il mondo inaudito di una lingua che si sottrae e come un dialetto agisce sotterraneamente: è allora possibile, a volte, «vedere nuda la vita». È lo sguardo della meraviglia infantile e del terrore terrestre: vedersi senza potersi riconoscere, incerto nominare, crudeltà mista a commozione. Lo sguardo come la gloria è qui sempre umana.
Un bianco dove non si mette niente,
di notte
si vede una pagina di Nerval,
il sangue di Esenin, una baita, la strada nuda di una frontiera,
un bungalow sulla costa.
***
Io posso dire dei lampi, una nuvola rotta.
Io vorrei tanti colori, sognare una festa,
scrivere di noi solo favole.
***
Alla fine, mi domando, come poter dire: alla fine.
Dare a un posto un uomo, degli occhi, un cuore, un respiro.
***
A sapere bene forse potrei dire:
anche per noi una visione intera
con uno specchio sopra, con un cielo.
