 Recensione di Giorgio Meledandri
Recensione di Giorgio Meledandri
Che la poesia debba ripartire dai giovani è fin troppo facile da sostenere oggi, in un momento storico in cui impera la retorica della novità e della gioventù. Ma è chiaro che essere giovani di per sé non garantisce nulla. Una garanzia per il futuro può venire semmai da quegli autori che, nonostante la giovane età, sanno situarsi in un determinato spazio letterario e contribuire a trasformarlo.
Tra questi c’è senza ombra di dubbio Tommaso Di Dio (1982), e lo testimonia il suo recente lavoro Tua e di tutti (LietoColle, 2014), che segue di cinque anni l’esordio avvenuto con l’esile ma potentissima plaquette Favole (Transeuropa, 2009) e che è inoltre il primo titolo di una nuova, interessante collana nata dalla collaborazione tra l’editore e Pordenonelegge. Tua e di tutti appare infatti uno dei tentativi più riusciti, nell’àmbito della poesia italiana degli ultimi anni, di fare i conti con la tradizione lirica moderna e nel contempo di offrire uno sguardo inedito che ampli l’orizzonte presente. L’organizzazione stessa dell’opera, fondandosi su un’intertestualità interna ed esterna e partendo dal presupposto che il testo letterario sia discorso di ri-uso, testimonia l’ambizione (utopistica ma necessaria) di tenere in vita tutta la letteratura e di provare, proprio attraverso la non-ordinarietà della parola poetica, a mettere sotto una luce inconsueta la nostra quotidiana esistenza. L’incipit è in tal senso rivelatore: prendendo le mosse dal frammento 140 Voigt di Alceo («Tutto questo non possiamo noi dimenticare / una volta cominciata questa impresa»), viene introdotta la figura del «giovane ragazzo down» che distribuisce giornali free-press, allegoria della gratuità del ruolo che ciascuno ricopre nel mondo («Ha trovato / il suo compito; la sua fatica, il suo posto / senza prezzo né guadagno. […] / Anche lui, mentre mette in opera il mondo / sorride / in nome di nessuno», p. 15). È facile riconoscere già in questo componimento quel carattere parenetico che contraddistingue l’intero libro nella sua complessa e meditata struttura (sette sezioni, di cui le dispari costituite da una sola poesia): Di Dio ci invita ad agire, a tessere la rete di relazioni e di esperienze che ci rendono degli individui, senza dimenticare le acquisizioni della cultura e della sensibilità umana, così da dare consapevolmente il proprio apporto in una condivisione continua. Accogliere questo invito, assolvere questo compito significa ovviamente esporsi a dei rischi: fallire, per esempio, oppure giungere a un limite e doverlo accettare. Ma è in tale esposizione che risiede la possibilità di lasciare qualcosa a chi verrà dopo, la dolorosa gioia di essere umani, come si evince dal testo a p. 19:
Con gli anni la vita si complica
si confonde si immischia
la certezza non si dà
nelle mani mai. Le persone dilatano
s’allargano rughe pance
gli anni sono ricordi nel parco
la stessa strada
che continui a fare e rifare
e gli alberi. Dentro il ventre di una donna
a godere steso con la faccia sporca
sulla terra; nella montagna
fragile delle paure che dilava
cancella
amici case paesi. E ogni mondo
a cui hai creduto come cosa salda e vera
è già di altri negli altri corpi
come una bufera che non riconosci più; che non riesci
ad amare di più.
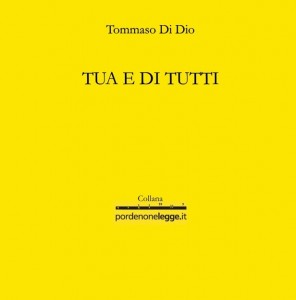 La poesia qui riportata si trova all’inizio della seconda sezione, in cui l’io lirico risponde all’istanza di messa in opera del mondo cercando di annullare lo spazio che si frappone tra sé e gli altri, tra sé e le cose, mediante un’indagine sensoriale, perlopiù tattile; indagine che spinge il soggetto a recuperare una dimensione primordiale della vita umana e dei rapporti: «E penso a quell’arabo / giovane e fermo negli stretti suoi jeans / […] ad aspettare / la grazia da qualche parte come me, la grazia / di qualche animale che come me / abbia fame» (p. 20); «E invece vedi questo / sentirmi nel corpo solo, neutrale; e volere tutto / da questa materia fragile / ottusa insensibile vivacità della pelle / che tocca l’altra pelle» (p. 35). In tale quadro fisico e fisiologico, frutto anche dell’interiorizzazione del lavoro compiuto da Antonio Porta in Partita, il corpo diventa una cosa sola con la terra e con gli elementi: «Quando muti noi. / Quando inconsapevoli; bruti o brulli, come / terra nella terra. Quando sempre più / pozze dentro di noi / bronchi, spasmi. […] / Perché il vero volto è fiamma, che ogni altra / luce cancella» (p. 25); «Ho cara la tua carne; l’ammasso / d’alberi e vento che dentro te / scorre vene» (p. 37). È grazie a queste premesse che l’io riesce ad accomunare le situazioni e le figure tra loro diversissime con cui si relaziona: così, per esempio, la seconda persona singolare può riferirsi a un tu femminile in un contesto privato, ultima eco del tema erotico e sensuale magistralmente svolto in Favole; ma può anche essere qualcuno visto per strada («Piccola donna negra che / ti scaldi contro il vetro / del supermercato sma», p. 26), un personaggio storico-letterario (il centurione Crastino commemorato da Cesare nel De bello civili) o addirittura il protagonista di un «doloroso fatto di cronaca italiana», per parafrasare l’autore nella Nota finale. Il poeta infatti, mettendo sotto la sua lente i legami che vengono continuamente stretti e sciolti dentro la grande comunità degli uomini, non può non soffermarsi sugli episodi in cui lupus est homo homini, non homo; e dunque il gesto con cui l’essere umano priva dell’innocenza sé stesso e tutti i suoi simili si palesa prima nella rievocazione della tragica vicenda di Yara Gambirasio («Girano i giorni / nelle notti; girano le / lacrime. E ora del male / hanno trovato traccia; è una minima / catena organica /sul bordo dei suoi slip. / Ma lei dove è stata dove è / nessuno potrà dirlo mai», p. 28), poi nelle parole idealmente rivolte a Matteo Miotto, alpino ventiquattrenne ucciso da un cecchino nemico nella valle del Gulistan a fine 2010: «Un passo / un grado più in là, nel deserto / dell’Afghanistan un dio senza peso / non aveva / ricordo per te. Di te cosa tiene / il mio paese. Non era neve. / Non era bianco. Quel sapore dell’altro / uomo che hai / sulla bocca» (p. 38).
La poesia qui riportata si trova all’inizio della seconda sezione, in cui l’io lirico risponde all’istanza di messa in opera del mondo cercando di annullare lo spazio che si frappone tra sé e gli altri, tra sé e le cose, mediante un’indagine sensoriale, perlopiù tattile; indagine che spinge il soggetto a recuperare una dimensione primordiale della vita umana e dei rapporti: «E penso a quell’arabo / giovane e fermo negli stretti suoi jeans / […] ad aspettare / la grazia da qualche parte come me, la grazia / di qualche animale che come me / abbia fame» (p. 20); «E invece vedi questo / sentirmi nel corpo solo, neutrale; e volere tutto / da questa materia fragile / ottusa insensibile vivacità della pelle / che tocca l’altra pelle» (p. 35). In tale quadro fisico e fisiologico, frutto anche dell’interiorizzazione del lavoro compiuto da Antonio Porta in Partita, il corpo diventa una cosa sola con la terra e con gli elementi: «Quando muti noi. / Quando inconsapevoli; bruti o brulli, come / terra nella terra. Quando sempre più / pozze dentro di noi / bronchi, spasmi. […] / Perché il vero volto è fiamma, che ogni altra / luce cancella» (p. 25); «Ho cara la tua carne; l’ammasso / d’alberi e vento che dentro te / scorre vene» (p. 37). È grazie a queste premesse che l’io riesce ad accomunare le situazioni e le figure tra loro diversissime con cui si relaziona: così, per esempio, la seconda persona singolare può riferirsi a un tu femminile in un contesto privato, ultima eco del tema erotico e sensuale magistralmente svolto in Favole; ma può anche essere qualcuno visto per strada («Piccola donna negra che / ti scaldi contro il vetro / del supermercato sma», p. 26), un personaggio storico-letterario (il centurione Crastino commemorato da Cesare nel De bello civili) o addirittura il protagonista di un «doloroso fatto di cronaca italiana», per parafrasare l’autore nella Nota finale. Il poeta infatti, mettendo sotto la sua lente i legami che vengono continuamente stretti e sciolti dentro la grande comunità degli uomini, non può non soffermarsi sugli episodi in cui lupus est homo homini, non homo; e dunque il gesto con cui l’essere umano priva dell’innocenza sé stesso e tutti i suoi simili si palesa prima nella rievocazione della tragica vicenda di Yara Gambirasio («Girano i giorni / nelle notti; girano le / lacrime. E ora del male / hanno trovato traccia; è una minima / catena organica /sul bordo dei suoi slip. / Ma lei dove è stata dove è / nessuno potrà dirlo mai», p. 28), poi nelle parole idealmente rivolte a Matteo Miotto, alpino ventiquattrenne ucciso da un cecchino nemico nella valle del Gulistan a fine 2010: «Un passo / un grado più in là, nel deserto / dell’Afghanistan un dio senza peso / non aveva / ricordo per te. Di te cosa tiene / il mio paese. Non era neve. / Non era bianco. Quel sapore dell’altro / uomo che hai / sulla bocca» (p. 38).
Ma nel percorso tracciato dall’opera, fin qui costruito soprattutto filtrando liricamente i dati del reale, c’è un punto di svolta: è il testo a p. 41, l’unico – come abbiamo accennato – della terza sezione:
Quel che ammonirono i libri santi.
Quel che scrissero i poeti. Le epigrafi.
I ruderi. Le pietre le caverne
scavate con le mani in gloria
del sangue di bufali, di elefanti. Tutto questo
essere stati non basta
bisogna ripetere tutto, capitolare.
Bisogna pagare.
 Dopo aver citato nel primo verso l’incipit di un componimento di Clemente Rebora, il cui magistero con assoluta evidenza è stato fondamentale per Di Dio, l’autore ci dice che il vissuto nostro e di chi è venuto prima di noi, incluso quello rintracciabile nelle pagine appena sfogliate, non è sufficiente («Tutto questo / essere stati non basta»): si dimostra necessario presentificare l’esperienza, rinnovare incessantemente la vita («ripetere tutto») senza sottrarla alla precarietà e alle sconfitte di oggi («capitolare», «pagare») – un bisogno che in qualche misura rimanda alla celebre massima pasoliniana «Solo l’amare, solo il conoscere / conta, non l’aver amato, / non l’aver conosciuto». Il compito di riportare tutto al presente – in una continua «ricerca dell’esperienza» (p. 73) intesa come opera di scavo («Sotto la strada c’è un pezzo di terra. / […] La ricerca / la faccia messa dentro, persa dove», ibid.) o come salita, scalata, ascensione («risalire / per le vene le tracce, i depositi, le sacche / l’ordine di tutte le parole / che ci trovano», p. 74) – fa emergere in pieno la distanza che intercorre tra l’evento esperito e l’evento trascritto; si tratta, in altri termini, della frizione tra rappresentazione e realtà, quella realtà in cui la vita si manifesta al tempo stesso come dono e come trauma, ferita o spreco («Ma nell’ambra. / E nella pattumiera. Ai bordi della strada, nella bolla cava / […] la vita / è meno morte che questa / carne sfatta sempre più / dalla gioia; che è / e trema», p. 47), e della quale la parola è segno convenzionale o tuttalpiù espressione simbolica. Non a caso leggiamo: «le parole esplodono / e sono cera pasta biologia, non tengono / decadono. E allora t’alzi; e ricominci. / Insisti fin che dura questo male / scrivere / le cose che passano» (p. 45); «E questa lingua falsa / sembra tenerci, trattenerci / sul piano sicuro delle cose» (p. 47). La poesia, che proprio con il linguaggio (e sul linguaggio) lavora, ci rammenta che ogni nostra conoscenza del mondo è linguistica, indiretta, e perciò «falsa»; ci ricorda, insomma, che noi e le «nostre imprese» siamo imperfetti, fallibili, finiti. Ma da questa presa di coscienza si sviluppa diffusamente la visione comunitaria che informa l’opera in toto e che era stata già espressa dai versi a p. 27, da cui è tratto il titolo: «Sempre lei / balla cade offende, fa di tutto perché mai tu / l’ameresti così come ora l’ami / tua e di tutti, questa / vita reale più ricca e sgualcita / dal niente che non l’abbandona». Ad unirci in quanto esseri umani sono infatti i nostri limiti, il primo dei quali è vivere un’esistenza insidiata «dal niente» e ciononostante «ricca», impossibile da riassumere. All’interno di questa prospettiva collettiva, Di Dio tenta la sua personalissima via: sciogliere il soggettivismo della lirica in una voce comune – sua e di tutti, appunto –, dove l’altro diventa l’Altro con la maiuscola, e cioè un’entità universale; qualcosa che non è più il tu, il diverso da sé, ma tutti i pronomi insieme, ormai indistinguibili («Nessuno / finché vive, potrà dimenticare / cosa chi una per volta per tutte va // mentre nessun pronome resta», p. 52). Lo spazio-ostacolo che nelle prime pagine si interponeva tra gli individui viene quindi definitivamente annullato; così, nel testo che chiude il libro (p. 81), la persona loquens è da identificarsi con chiunque sia venuto al mondo, con ciascuno di noi:
Dopo aver citato nel primo verso l’incipit di un componimento di Clemente Rebora, il cui magistero con assoluta evidenza è stato fondamentale per Di Dio, l’autore ci dice che il vissuto nostro e di chi è venuto prima di noi, incluso quello rintracciabile nelle pagine appena sfogliate, non è sufficiente («Tutto questo / essere stati non basta»): si dimostra necessario presentificare l’esperienza, rinnovare incessantemente la vita («ripetere tutto») senza sottrarla alla precarietà e alle sconfitte di oggi («capitolare», «pagare») – un bisogno che in qualche misura rimanda alla celebre massima pasoliniana «Solo l’amare, solo il conoscere / conta, non l’aver amato, / non l’aver conosciuto». Il compito di riportare tutto al presente – in una continua «ricerca dell’esperienza» (p. 73) intesa come opera di scavo («Sotto la strada c’è un pezzo di terra. / […] La ricerca / la faccia messa dentro, persa dove», ibid.) o come salita, scalata, ascensione («risalire / per le vene le tracce, i depositi, le sacche / l’ordine di tutte le parole / che ci trovano», p. 74) – fa emergere in pieno la distanza che intercorre tra l’evento esperito e l’evento trascritto; si tratta, in altri termini, della frizione tra rappresentazione e realtà, quella realtà in cui la vita si manifesta al tempo stesso come dono e come trauma, ferita o spreco («Ma nell’ambra. / E nella pattumiera. Ai bordi della strada, nella bolla cava / […] la vita / è meno morte che questa / carne sfatta sempre più / dalla gioia; che è / e trema», p. 47), e della quale la parola è segno convenzionale o tuttalpiù espressione simbolica. Non a caso leggiamo: «le parole esplodono / e sono cera pasta biologia, non tengono / decadono. E allora t’alzi; e ricominci. / Insisti fin che dura questo male / scrivere / le cose che passano» (p. 45); «E questa lingua falsa / sembra tenerci, trattenerci / sul piano sicuro delle cose» (p. 47). La poesia, che proprio con il linguaggio (e sul linguaggio) lavora, ci rammenta che ogni nostra conoscenza del mondo è linguistica, indiretta, e perciò «falsa»; ci ricorda, insomma, che noi e le «nostre imprese» siamo imperfetti, fallibili, finiti. Ma da questa presa di coscienza si sviluppa diffusamente la visione comunitaria che informa l’opera in toto e che era stata già espressa dai versi a p. 27, da cui è tratto il titolo: «Sempre lei / balla cade offende, fa di tutto perché mai tu / l’ameresti così come ora l’ami / tua e di tutti, questa / vita reale più ricca e sgualcita / dal niente che non l’abbandona». Ad unirci in quanto esseri umani sono infatti i nostri limiti, il primo dei quali è vivere un’esistenza insidiata «dal niente» e ciononostante «ricca», impossibile da riassumere. All’interno di questa prospettiva collettiva, Di Dio tenta la sua personalissima via: sciogliere il soggettivismo della lirica in una voce comune – sua e di tutti, appunto –, dove l’altro diventa l’Altro con la maiuscola, e cioè un’entità universale; qualcosa che non è più il tu, il diverso da sé, ma tutti i pronomi insieme, ormai indistinguibili («Nessuno / finché vive, potrà dimenticare / cosa chi una per volta per tutte va // mentre nessun pronome resta», p. 52). Lo spazio-ostacolo che nelle prime pagine si interponeva tra gli individui viene quindi definitivamente annullato; così, nel testo che chiude il libro (p. 81), la persona loquens è da identificarsi con chiunque sia venuto al mondo, con ciascuno di noi:
Io non riesco
a ricordare il canto; e questa terra
senza di me, prima di me. Le luci
la voce la strada. Il bacio l’abbraccio
la penetrazione mani urlo
questa festa che comincia e non è data mai
terra senza di me, dopo di me. Ci sono state
grotte, torri, civiltà. Ma bisogna
arretrare ancora; bisogna cercare. Stare
nei muscoli addome contratto a spinta
il passo prima. Nascere non è
generare; oggi bisogna dare
vita alla vita.
 Se poco prima (p. 77) la quête si era conclusa circolarmente con una faccia bianca, simbolo bifronte della consunzione (l’esperienza giunta alla soglia estrema) e del candore (l’esperienza che verrà), adesso – assimilando ancora i versi dei grandi (stavolta quelli di Giorgio Caproni in L’ombra e il canto), come sempre rifunzionalizzati in base alle esigenze di un discorso nuovo – l’autore ci incita a «dare / vita alla vita». Cosa significa questo poliptoto? Significa che il poeta vuole richiamarci al ruolo che ci spetta, esortarci a una ricerca senza fine. La scrittura ci ha mostrato il tempo dell’uomo, il prima e il dopo, e ci ha suggerito la possibilità di una condivisione eterna. Possiamo dire allora che Tommaso Di Dio ha composto Tua e di tutti per permetterci insieme a lui di «bucare la pagina», ovvero – secondo la definizione di Porta – di «uscire dalla letteratura per raggiungere quell’immagine dell’esistenza che in qualche modo intuiamo possibile». Sì, questo libro è stato scritto perché i lettori, nel richiuderlo, potessero vedere con una nitidezza inaudita i piccoli caratteri scomparire e lasciare il posto a quella cosa gigantesca e non riepilogabile che è la vita.
Se poco prima (p. 77) la quête si era conclusa circolarmente con una faccia bianca, simbolo bifronte della consunzione (l’esperienza giunta alla soglia estrema) e del candore (l’esperienza che verrà), adesso – assimilando ancora i versi dei grandi (stavolta quelli di Giorgio Caproni in L’ombra e il canto), come sempre rifunzionalizzati in base alle esigenze di un discorso nuovo – l’autore ci incita a «dare / vita alla vita». Cosa significa questo poliptoto? Significa che il poeta vuole richiamarci al ruolo che ci spetta, esortarci a una ricerca senza fine. La scrittura ci ha mostrato il tempo dell’uomo, il prima e il dopo, e ci ha suggerito la possibilità di una condivisione eterna. Possiamo dire allora che Tommaso Di Dio ha composto Tua e di tutti per permetterci insieme a lui di «bucare la pagina», ovvero – secondo la definizione di Porta – di «uscire dalla letteratura per raggiungere quell’immagine dell’esistenza che in qualche modo intuiamo possibile». Sì, questo libro è stato scritto perché i lettori, nel richiuderlo, potessero vedere con una nitidezza inaudita i piccoli caratteri scomparire e lasciare il posto a quella cosa gigantesca e non riepilogabile che è la vita.
