
Paul Éluard
L’eterna primavera nella poesia di Éluard
di Mario Famularo
Limitare la questione stilistica sulla poesia di Éluard alle istanze e caratteristiche del movimento surrealista, per quanto fondamentali a comprenderne la storia e il percorso letterario, sarebbe un errore: la sua parola nasce da un’altissima compenetrazione di convincimento etico, vicissitudine sentimentale e trasfigurazione di tali elementi verso l’universalità dell’esperienza umana, di ogni uomo e di ogni donna.
Nel corso della sua lunga opera poetica, da Capitale de la douleur a Le temps déborde, fino a Le phénix, le figure femminili sono sempre differenti, nella biografia dell’autore: dalla dolorosa separazione con Gala, avvenuta in giovane età, al lungo sodalizio con Nusch, che terminerà con la sua morte, fino alla rifioritura piena con Dominique, che lo accompagnerà fino agli ultimi giorni della sua vita.
Ma “l’altezza del tono”, riconosciutagli anche da Fortini (che ha tradotto diversi suoi testi, in particolare raccolti in un pregevole lavoro antologico pubblicato da Einaudi) ha proprio tale caratteristica costante, nonostante i temi trattati si estendano alla riflessione civile e storica: quella sentimentale, in senso ampio.
Il perimetro delle singole personalità femminili tende a farsi sottile e a evadere dai margini identificativi e biografici, al punto che i suoi ultimi testi potrebbero benissimo riferirsi a ciascuna di esse, come se ogni donna della vita di Éluard avesse contribuito alla formazione di un’unica immagine femminile, assoluta, in cui ciascuna di esse converge; e a fronte di questo ricco femminino illimitato, le aspirazioni del poeta, anche quando sfiorano le tematiche civili, storiche e morali, tendono a replicare la medesima istanza di universalità anche con il valore umano del soggetto, dell’io lirico, verso la stilizzazione assoluta di un sentimento puro che unisce tutti gli uomini.
È una caratteristica che si evolve nel corso degli anni e delle opere, ma che già in pochi testi si può riconoscere per le caratterizzanti attribuzioni vicine al sacro, in cui l’intreccio con i residui dell’esperienza surrealista si impone in immagini cristalline, nitide, dove la dimensione del sogno si legittima come pura ed autentica interpretazione del reale.
E così la donna è “figlia di una primavera / che non finisce”, che ride dell’insensata violenza degli uomini, ed è “sempre in fiore”, con i “piedi fermi”, “tenera con i forti” e “debole con i teneri” – un’immagine in cui dolcezza e autorevolezza si intrecciano, dove la debolezza delle reciproche solitudini umane si fa possibilità di una forza illimitata che accomuni ognuna di esse: di solitudine in solitudine verso la vita.
E se la debolezza dell’ “uomo nel vuoto”, che si riconosce “sordo cieco muto / sopra un immenso piedistallo di silenzio nero”, in un “assoluto di uno zero ripetuto” sembra già, nel riconoscere la purezza della notte e l’immacolata bellezza del mondo, un’aspirazione sentimentale alla bellezza, tale debolezza si trasforma in valore umano, attraverso l’esperienza pura del sentimento, trasfigurata: “all’improvviso parlando mi sento vincitore / più chiaro e più vivo più fiero e migliore / più vicino al sole”, ed ecco che i riferimenti all’infanzia (“In me nasce un bambino … di sempre che nasce da un bacio unico”) impongono un sentire autentico e allo stesso tempo primigenio, incorrotto e viscerale, non mediato: “la morte è vinta e un bambino emerge dalle rovine / dietro di lui le rovine e la notte scompaiono”.
La notte, che nella solitudine era pura, svanisce di fronte alla potenza di questa assolutizzazione dell’esperienza sentimentale, che in Éluard diventa totalizzante, incontro tra tutti gli uomini e tutte le donne, moltiplicate in un unicum attraverso un gioco di specchi (e gli specchi sono assai frequenti nella sua poesia).
E l’immagine di questo sentimento assolutizzante, pieno e universale, che unisce ogni esperienza umana in una vitalità illimitata, innocente e sacra, pure se “in un mondo spietato”, protegge dalla morte, dalla corruzione, dalla dissolvenza, dalla caduta di senso cui si riferiva con quella “solitudine compiuta”, quel “nulla … oblio senza limiti”, perché “non c’è notte per noi / nulla di ciò che perisce può toccarti” – ed Éluard lo scrive pochi anni dopo la scomparsa dell’amata Nusch, proprio perché il sentimento sopravvive ai singoli uomini, alle singole relazioni, alla stessa specie umana, sembrerebbe suggerire, attraverso il suo riflesso (il suo specchiarsi) in ogni altra esperienza analoga, attraverso la sua assolutizzazione nella dimensione del sogno e del sacro, attraverso la consacrazione della vitalità che l’accompagna. Continua a leggere→




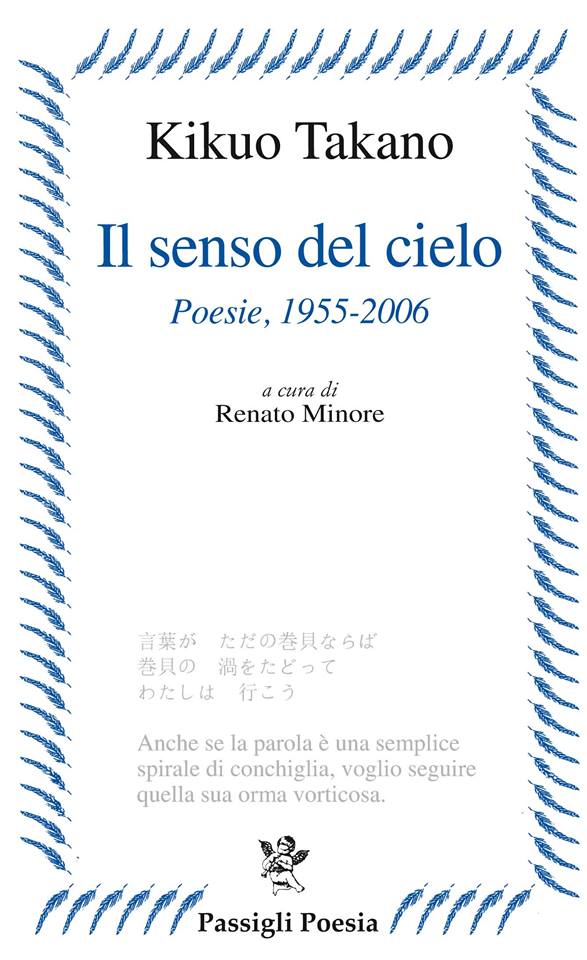
 CO M U N I C A T O S T A M P A
CO M U N I C A T O S T A M P A


