
NOTA CRITICA DI PIETRO ROMANO
Il nesso che unisce gli opposti nell’immagine di un logos che tutto di sé permea è il fulcro tematico dell’opera di Roberto Carifi, Nel ferro dei balocchi (Crocetti, Milano, 2008), in cui si trovano raccolte le poesie scritte in quasi un ventennio, dal 1983 al 2000.
L’infanzia figura come un terreno di indagine sul quale la parola poetica si muove in un’intima solidarietà con il tepore delle immagini che abitano la memoria.
Sin da L’obbedienza, del 1986, il poeta scandaglia il tema della morte come un abisso nel quale scendere per rischiarare una temporalità che si avverte vincolata alle trame di un destino ineludibile. Tale è la percezione attingibile dal testo posto in apertura alla raccolta, che si dà al lettore in una chiave dialogica, quasi Carifi tentasse di ricostruire un dialogo con il fantasma della madre, oramai figura della memoria: «“C’è una luce fortissima, un vento che piega le ginocchia”. /” Dove?” /” Dove non puoi guardare”. / “Dovrò uccidermi, lentamente, come una cosa abbandonata”. / “Non ti capisco”. / “Non parlo più la stessa lingua…non posso”. /” Devo andare”. / “Perché?” / “Qualcuno dà degli ordini… degli ordini inflessibili”. /” Ti aspetterò…” / “È inutile. Hanno sospeso il tempo, c’è una neve che fa tremare, anche qui, in questo campo arato”».
La dicotomia su cui il testo si costruisce avvicina il poeta alla constatazione del confine che separa la vita dalla morte, evidenziando, attraverso le immagini di «una luce fortissima e di un vento che piega le ginocchia», la rapacità di quest’ultima.
Lungi dall’essere espressione di forza rigenerante, la luce appare sempre correlata a una temporalità che, in quanto precaria, incide la vita oggettivandola nella dimensione conoscitiva del dolore: «Quante volte, tra le pagine/ una mano lanciata come un sasso/ negli anni che sono gocce,/ centimetri del tuo sangue/ e la parola adolescente che consumi/ come un cuore inzuppato…/ finché un raggio ferisce tutto/ anche gli attimi invincibili/ e un angelo si solleva,/ con esattezza,/ trafigge la tua domanda/ proprio lì,/ nelle vocali». Rilkianamente, Carifi sembra fare riferimento all’angelo come figura che specchia in sé la vita e la morte, e con essi l’effimero che li innerva, senza però mai redimerlo davvero.
Questa ricerca tematica su un’idea di origine che guida il poeta verso il canto si esprime mediante rappresentazioni pervase da un unico gelo, collocando le visioni in uno stato incerto tra il sonno e la veglia: «Pregano, adesso, in una sfera luminosa/la terra fredda dove l’inesistenza sarà guardata/ tra le stelle filanti e un fratello buono…/ compie due anni la tua infanzia,/ i primi passi nel gelo, quando ti meravigli/ davanti alle rovine e un silenzio benedetto/ protegge la tua gioia…/ forse ti amano, anche lì, nell’occhiata fragile dei morti/ e una mano invincibile ti indica la casa,/ un lumicino accanto al tuo ritratto/ e piangeresti se il tempo non fosse arato/ da un amore più forte, l’obbedienza ad un inverno/ dove di nuovo corri e ti sbucci le ginocchia/ con quel balocco arrugginito, e ridi».
Il freddo che domina l’esistenza è il freddo che precede l’addio, altro tema che lega Carifi a Rilke: i morti evocati dal poeta danno ragione di quella lontananza che «resta tra la nascita e l’orma saccheggiata». La riflessione gravita perciò intorno ai motivi che ingenerano una ferita alle radici dell’esistenza, precipitando l’uomo in una dimensione soggetta all’imperio dei possibili. A tal proposito, in epigrafe alla sezione La porta spalancata, Carifi cita il filosofo Franz Rosenzweig: «Ma per quale destinazione si aprono i battenti della porta», di fatto simbolizzando il fine del proprio canto, che è quello di un travalicamento, di un andare oltre. Il prima diviene quindi afferrabile solo in corrispondenza di ciò che incrina la parola spianando varchi nella memoria: «Siamo tornati alla prima voce,/ il rigagnolo nel prato dove affondano le scarpe/ anche il pupazzo prega perché il nulla/ sia una luce improvvisa sulle nostre corse, / pochi centimetri tra due righe/ e verremo accarezzati da una sorella nuda/ nascosta nel baule…/ ecco le dita pure che stringono il lenzuolo/ ed una gioia sospesa, / quella goccia che hai perduto/ è soltanto una figura».
Particolare pregnante del testo preso in considerazione è l’addensarsi di figure attinenti a un’idea di origine, che sottintendono, nell’indagine di Carifi, anche una ricerca a ritroso sulla lingua e su ciò che la spezza originando parola. I balocchi allora emergono come reperti di un passato trafugato, su cui di continuo agisce con forza la violenza mortifera del tempo: «e resteremo nel ferro dei balocchi/ finché il tempo si calmerà in un precipizio». La condizione di permanere «nel ferro dei balocchi» implica per Carifi il posizionamento del proprio campo d’indagine all’interno delle trame dell’infanzia che, proprio perché tale, «mantiene la poesia sui bordi di una vertigine tragica e gioiosa, nella responsabilità di quel dire esigente che è il poetico».
L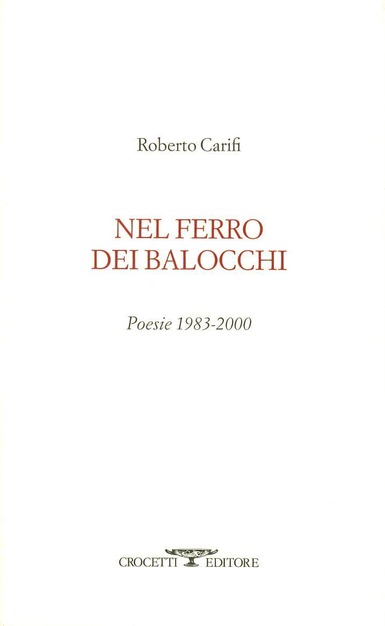 a parola del poeta coincide in tal senso con quella del bambino, in quanto «custodita nel fondo del linguaggio come luogo primordiale della sua voce più dolorosa ed esatta».
a parola del poeta coincide in tal senso con quella del bambino, in quanto «custodita nel fondo del linguaggio come luogo primordiale della sua voce più dolorosa ed esatta».
Al cospetto dei balocchi dell’infanzia, la precarietà che è intrinseca al movimento stesso dell’esistenza sembra annullarsi «nella rigida fissità della morte». In questa chiave d’interpretazione, Nel ferro dei balocchi restituisce al lettore la rappresentazione di un mondo nella sua verità contraddittoria e irrefutabile a un tempo. Questa compresenza di opposti che si incarnano nelle rovine dei giochi dà luogo a un terribile spaesamento, lo stesso su cui si fondano la storia e il pensiero occidentali, dominati da conflitti e violenze inaudibili, come d’altronde è possibile evincere in Occidente, del 1990.
La raccolta, recando la testimonianza delle vittime evocate, rappresenta alcuni tragici scenari che hanno funestato l’Occidente: «Qualcosa è irreparabile nella merenda sbriciolata,/ gli attimi puri della nascita/ quando uno vede le cose allontanarsi/ e prega che non ci sia nessuno,/ nemmeno un padre da perdonare…/ nessuno, vi scongiuro, sia troppo vivo/ tra le lampade spente,/ nel bianco delle corsie, / questa voce che si cancella dove non c’è rimedio/ ogni errore è una vittoria».
La distruzione che si accompagna agli eventi della storia porta con sé la benedizione di una rinascita: «Fuori non c’è più niente:/ ecco la mano che fa a pezzi/ e benedice». Del resto, agli occhi di Carifi, l’errore dei padri pone le basi per una rilettura della Rivelazione cristiana: «È scesa, Marika, di notte/ questa disperazione nelle case/ non c’è più luce e nemmeno il canto, / il canto della mamma/ mentre racconti la prigionia, / una merenda e il viso raggrinzito/ e c’è un Cristo in ogni cosa, un figlio benedetto».
Il Cristo cui il poeta fa riferimento sembra scaturire dal buio che discende con la notte, come se ogni cosa, una volta distruttasi, obbedisse a un moto di rinascita. Nell’irrealtà di questo assoluto spaesamento Carifi trasfigura lo spazio in cui l’esistenza viene a essere in tutta la sua sferzante drammaticità: «Esserci è stare in attesa del pane/ ma questi mucchi sono morti veri, / capisci, veri come il fiato che viene incontro/ dall’altra parte della piazza,/ del filo spinato./ Ti dico di questa guerra/ se oggi è il 14 luglio e potrebbe accadere/ una morte per fame,/ ti dico anche che ci siamo seduti/ come fosse normale/ il gelo di quelle lampade».
Lo spazio degli accadimenti si pone al confine tra essere e non essere e determina la vertigine assoluta in cui si agitano gli opposti: «Da quella porta passeranno in pochi. / Quale, che porta indica la mano ossuta? / Nulla, non indica nulla questo morto che geme. / Conosci il cane che battono, di sotto, nel cortile? / Dov’era la testa c’è un destino che morde. / Ma lui non ne sa nulla, / se non dice il morto». Su tutto campeggia la raffigurazione del Figlio, che eredita, in quanto tale, la malattia del Padre ma che riconcilia tra loro i possibili: «Che dica, l’Orfano, colui che arranca, la parola estrema. Lui, il più esposto, l’abbandonato che sa l’ammutolirsi, la malattia del Padre».
L’intera esperienza poetica di Carifi sembra dominata da aneliti palingenetici, che prefigurano un ritorno all’acqua attraverso l’intermediazione della voce del Figlio dolente:
«Donne che sono state madri, donne senza più figli. E padri, padri senza ritorno. E questa voce, ora infantile, ora un gemito di cane. Parla di notte, a noi rinchiusi, noi che abitiamo acqua, noi che saremo acqua […]». In tal senso, la parola si rivela come un lungo addio cui affidare l’intensità di ogni esistenza: «Non la pietà ma il brivido/ che nutre il lutto. Madre/ lo sa l’uomo che miete l’alba, / che devasta l’ora. / Lo sanno, madre, / e non c’è stella che separi/ il giorno dalla notte. / Si va decisi al pendolo del nulla/ con il quadrante spoglio sulla testa».
Nonostante le istanze rigeneratrici implicite nella poesia, Carifi si mostra ben conscio del fatto che tutto tende verso il nulla, senza rimedio. Per tali ragioni, Nel ferro dei balocchi, svolgendosi come canto dell’addio, sembra proporsi l’intento di sondare le relazioni dissolventi tra figure di sogno e di memoria al fine di scendere nelle profondità del mistero attraverso l’ossessione poetica del tempo e del dolore.
