 NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA
NOTA DI LETTURA DI ALBERTO FRACCACRETA
Poesia filosofica e profondamente legata al contingente, quella dell’olandese Cees Nooteboom è una continua divagazione sull’essere e sull’apparire, un registrare i mutamenti immutati della natura (soprattutto degli amatissimi cactus nel suo giardino di Minorca, dei fichi, della vegetazione lussureggiante ma anche delle oche del vicino), un sommesso ascoltare nomi, suoni, stridii, fragore di giornali, passaggi in lontananza. Poesia dunque di pittura e di musica, di improvvisi e irripetibili squarci, di esaltazioni nominali e avvolgimenti sinfonici: poesia racchiusa in gabbie metriche addentellate — Addio consta di trentatré liriche, ognuna costruita su tre quartine caudate —, con andamento progressivo e poematico che apre e chiude una stagione di riflessioni dello scrittore (in questo caso si tratta di un autunno a Minorca e, significativamente, del periodo di quarantena trascorso a Hofgut Missen durante la prima ondata di Covid-19).
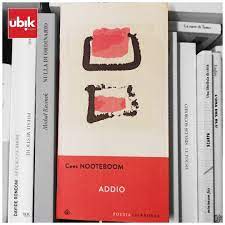
Come scrive opportunamente Andrea Bajani nella postfazione, «a dispetto del titolo, questo libro non è un congedo. L’autore di Tumbas non si congeda da niente. L’addio è semplicemente il muro ultimo, dopo il quale si estende, o si annida l’inesprimibile». Certo, nella sconcertante precisione di un timbro levigato emerge sovrano — negli scarti e nei vuoti semantici da waste land — il silenzio, inteso come frattura e fattura estrema del poetare («Il silenzio, travestito da voluttà notturna, circonda/ la casa, e lui riascolta le voci di un tempo»). Dentro il silenzio sorge, però, per dirla con Adam Zagajewski, un «dialogo pacato», fatto di sguardi — sguardi che diventano poesia — e intese fulminanti dinanzi al testimone muto, simboleggiato, o meglio incarnato dai cactus. Qui avviene l’incontro sempre sospettoso, sempre rimandato con la morte, con il dopo, viaggio estremo prefigurato nella dissoluzione del virus e nella scomparsa degli amici («L’amico morto senza poter più parlare,/ l’altro amico che sull’ultimo letto/ tracciava con le mani un cerchio,// e voleva dire viaggio. Era/ un addio»). Mentre fluisce vorticosamente l’identità in una singhiozzante alterità («Il corteo/ che si mescolava ai loro sogni/ è apparso al lui del mio/ io, l’io del mio lui»), la solitudine e il senso heideggeriano di gettatezza (Geworfenheit) implicano una visione del mondo incentrata sul tema del viaggio non soltanto come giunzione con la morte, ma anche e soprattutto come peregrinare incessante degli elementi dell’universo: il cosmo è già movimento, divenire in dissolvenza, fuoco («Quante vite stanno in una vita?/ Quante volte la stessa testa è qualcun altro?»).
Addio è suddiviso in tre parti, composte da undici testi: numerazioni e fissità che hanno qualcosa di dantesco e che ancora suffragano l’ipotesi di una poesia quale itinerarium e del poeta nelle vesti di pellegrino, nel senso medievale del termine. Il poeta-pellegrino, che riesce sempre a smarcarsi dall’etichetta di hollow man, passa attraverso coni d’ombra («Niente qui è gratis, raccogli// il morire in tutte le sue forme,/ il dolore, l’urlo, il malefico/ abbraccio, il bacio del tradimento/ calcolato») e momenti estatici, tentando di inseguire — sebbene da lontano, sebbene con occhio scettico — anche soltanto l’idea sfumata di una trascendenza.
1.
Questo si chiedeva l’uomo nel giardino
la fine della fine, cosa poteva essere?
Non gli sembrava affatto una forma di sofferenza,
guardò fuori, vide una nuvola dall’aspetto
di nuvola, grigio piombo, troppo pesante
per qualsiasi bilancia, il fico ormai spoglio
contro i sassi millenari del muro,
le oche del vicino, la loro censura,
come si doveva correggere la notte,
la grammatica dell’espropriazione, nessuno
sarà più se stesso, nessuna apparizione,
la ritirata dopo la sconfitta
ma senza una meta.
6.
Il poeta dorme. Questa è l’ora del giardiniere.
Foglie morte, il terreno umido e nero, il cactus
cullato nelle sue spine, figlio
della tempesta. Tra un anno arriverà il fiore
atteso dai mesi, generato
da una sola ora e dal colore che l’accompagna,
il viola della nascita e del lutto. In questo giardino la durata
non ha voce, il tempo non ha comando.
Questa è la sua famiglia, verde e ostinata,
mai timorosa della fine, il silenzio
la poesia in cui si rispecchia il suo essere.
Al cancello del giardino piagnucola il mondo, il
rumore di un giornale.
7.
Il mio strano territorio. I miei amici non hanno
bocche, ma punte e braccia ad angolo,
sorvegliano i muri, aspettano con me le parole
che vengono a farsi rinchiudere
In qualcosa che è una forma. Ho percorso
il mondo per arrivare qui. Loro
sono la meta che non conoscevo.
I loro nomi sono strani e musicali,
le loro forme dentellate, sanno molte più cose
di me, raccontano se stessi
nelle loro forme, ma restano all’interno,
il nostro dialogo è il mio guardare
sguardo come poesia.
Cees Nooteboom, Addio. Poesie al tempo del virus, traduzione di Fulvio Ferrari, postfazione di Andrea Bajani, Iperborea, pp. 96, € 1
