 Progetto editoriale ideato e curato da Fabrizio Fantoni
Progetto editoriale ideato e curato da Fabrizio Fantoni
con la collaborazione di Luigia Sorrentino
—
Questa Roma
Questa Roma, questa Roma
come l’ho amata,
come la ho posseduta
e me sono invasa la memoria!
Come me la sono stampata
nei sogni, fino ad averne
le stimmate
delle strade nel palmo della mano.
(da Giorgio Vigolo, I fantasmi di pietra, 1977)
–
Memoria e profezia nella Roma di Vigolo
di Magda Vigilante
Nella recensione al volume di Vigolo Canto del destino , Giorgio Caproni sottolinea quanto sia stato significativo per il poeta « l’esser nato e cresciuto [ a Roma] piuttosto che in qualsiasi altra città della Penisola ». Secondo Caproni , Vigolo « è di tutti i lirici nostri il più “fascinato” dalla Grande Maliarda, da questa grande Fattucchiera ch’è la Roma pagano-cattolica barocca […] » Si possono facilmente individuare nell’opera vigoliana, poetica e narrativa, due poli fondamentali attorno ai quali si struttura il rapporto dell’autore con la sua città natale. Questi due temi sono quello della memoria nella quale confluiscono sia il passato storico di Roma sia i ricordi personali di Vigolo, e quello della profezia che assume toni onirici o apocalittici per rappresentare il destino finale di Roma, caput mundi, la cui sparizione comporterebbe, secondo un’antica leggenda, la fine del mondo e della civiltà umana.
Fin dalla prima raccolta edita, La città dell’anima , dedicata a Roma, sono presenti le due dimensioni temporali: il passato remoto della città e la sua futura sorte. Nella prosa Santa Maria in Fons Olei, Vigolo rievoca l’antica credenza per la quale « […] la notte medesima che il Figliuol dell’Uomo nacque nella grotta di Betlehem, una fonte d’olio spicciò da questo vivo suolo romano, crisma d’elezione con cui il dio vivente consacrava la fronte della città imperiale e già presceglieva in Roma la sua Gerusalemme futura .» Vigolo suggella così la visione della Basilica di Santa Maria in Trastevere, appunto la Santa Maria in Fons Olei, quale si rivelò a lui e ai suoi amici, dopo che erano discesi dal Gianicolo a Trastevere dove «[l’] opprimente ressa di mura si aprì in una piazza ariosa e una basilica scintillante di musaici ci apparve sullo sfondo ». Nella piazza dove sorge la basilica, egli riconobbe allora «il luogo mistico» nel quale la Roma imperiale veniva consacrata, già dalla nascita di Cristo, nella nuova Gerusalemme, la città di Dio.
L’avvio de La Città vegetale si colloca in un passato non così lontano, ma la presenza di una pioggia incessante, che martellava la città da quindici giorni, immette subito il lettore in una atmosfera già presaga di quanto si svelerà compiutamente solo alla fine della prosa. Per sfuggire «alla vista dolorosa di Roma che marciva con le sue pietre millenarie come i vecchi barconi affondati nel fiume […]», alcune persone, tra le quali il protagonista, avevano deciso di rinchiudersi in una camera bianca dove «tutte le lampade accese» creavano «una bella luce d’oro» che faceva dimenticare la pioggia e il grigio mondo di fuori. A causa degli scrosci violenti della pioggia a vento, i rinchiusi potevano immaginare «di trovar[si] sotto coperta e di navigare in un veliero », quasi rivivessero la biblica esperienza di stare nascosti nell’arca mentre fuori diluviava.
Finalmente però appariva uno «squarcio d’azzurro» e tutti, risollevati, s’avventuravano nella città resa più scintillante e fragrante di profumi dalle piogge che l’avevano lavata. Soprattutto gli occhi si beavano nel rivedere il verde luminoso delle ville romane che costituiscono «una città d’alberi dentro l’altra città di mura». Il gruppo si dirigeva a Villa Borghese e, quando arrivava ad una fontana vicino alla quale v’era «un’aiuola di grosse corolle rosse e azzurre che il grigio velluto delle lunghe piogge non era riuscito a spegnere mai », al protagonista sembrava di assistere ad un déjà-vu. Egli scopriva infatti di essere stato in quel luogo, o quanto meno in un luogo molto simile, durante un sogno angoscioso della sua adolescenza.
Nella precisa rievocazione del sogno la villa perdeva a poco a poco il suo aspetto gradevole e sensuale come quello di «una giovine donna uscita allora allora ignuda e fragrante da un fiume » per trasformarsi in un luogo tenebroso e ostile. Il protagonista ricordava infatti come, nel sogno, egli si fosse inoltrato nella villa insieme alla fanciulla amata mentre splendeva la chiara luce di una giornata primaverile ma, all’improvviso, si era fatto buio e un vento freddo aveva cominciato a spirare. I due giovani innamorati avevano provato «lo spavento folle di restar chiusi nella villa » e invano, il ragazzo, con il suo amore fra le braccia, aveva attraversato correndo i viali per raggiungere i cancelli ormai irrimediabilmente serrati. «La notte [li] aveva fatti prigionieri nella vasta villa solitaria; [li] aveva colto come due piccoli alati in quella sua grande rete misteriosa da cui non si poteva fuggire più ».
Vigolo stesso considera il sogno « un lontano mito » della sua anima nel quale la breve gioia amorosa era sopraffatta dall’incubo di una definitiva prigionia. Ma, al di là del mito, l’angosciosa atmosfera onirica prepara il lettore alla rivelazione finale del racconto, quando il gruppo, dopo aver varcato il cavalcavia verso il Pincio, s’affacciava sulla terrazza per godere della visione sottostante di Roma. Ai loro occhi appariva però «una distesa pallida di neve, uno strano mare all’alba » dove era scomparsa la città «colata a picco in fondo a quello stagno di nebbie come un vascello immenso ».
Solo la Cupola di Michelangelo s’innalzava ancora galleggiando, «come un’Arca, come un’urna di pace sulla città sommersa », mentre appena si percepiva il suono lontano delle campane sepolte sotto le acque. La visione delle città abitate dagli uomini, sommerse per misteriosi cataclismi, aveva già affascinato la fervida immaginazione di Vigolo che, giovanissimo, aveva rappresentato con toni più tragici la medesima catastrofe – ambientata però in un imprecisato paese vicino ad un lago – nella sua prima pubblicazione, la prosa lirica intitolata in modo significativo, Ecce ego adducam aquas .
Per Vigolo nei sotterranei di Roma si svolge ancora la vita così com’era nei tempi antichi. La poesia I Giocatori ritrae in una grotta nascosta i centurioni che ancora s’accaniscono in uno «stregato» gioco di carte. La scrittura di questo componimento fu piuttosto complessa, perché ad una prima versione stampata nel volume Conclave dei sogni ne seguì un’altra con lo stesso titolo, ma notevoli modifiche, edita nella successiva raccolta Linea della vita nella quale Vigolo ristampò i testi del volume poetico precedente. Infine I Giocatori riapparve nel volume La luce ricorda dove erano stati riuniti le raccolte poetiche precedenti e gli ultimi componimenti. In questa ultima versione – qui analizzata- è riprodotta la prima edita in Conclave dei sogni con mutamenti linguistici aggiornati all’uso corrente.
Nella poesia la presenza simultanea della Roma pagana e cristiana è raffigurata nelle magiche carte da gioco dove
[…] Su una carta piange Maria
il Figlio straziato,
su un’altra Venere gli occhi
volge languida e si pettina
gli aurati capelli sul mare
che muta colore
La versione II, dove sono inserite alcune varianti significative, prolunga metaforicamente la rappresentazione dello scontro tra la civiltà classica e la religione cristiana nel gioco stesso dei militari, alcuni dei quali puntano «sui sacramenti», gli altri invece sugli «elementi»: « […] Fuoco e Terra / gittano sul tavoliere […] ». Questi versi non compaiono in I e furono aboliti in III, che ripropone con qualche modifica i versi di I:
Moventi figure, numeri
di pianeti gittano
sul tavoliere
ad alte grida blasfeme;
poi mischiano i grandi
tarocchi e si fissano
nel giuoco difficile e scuro .
Probabilmente Vigolo preferì eliminare i troppo espliciti riferimenti alla dottrina cristiana e all’antica religione pagana.
L’ultima strofa condanna per sempre gli antichi giocatori, privi di sonno e di cibo, a ripetere all’infinito la loro partita la quale ormai avviene da «mila anni». Nella II e III stesura sono quasi identici i versi che evocano la città moderna sorta sopra le teste dei centurioni, mentre differiscono i versi finali che descrivono la triste sorte a cui i militari andrebbero incontro se uscissero nel tempo presente fuori dalla grotta sotterranea. La III ripristina l’ultima strofa in modo identico a I:
Se uscissero adesso
dall’usciòlo nel chiasso
dei traffici e delle luci forti,
cadrebbero in cenere e nulla
come tratti da un sarcofago.
mentre nella II Vigolo stempera con minore efficacia rispetto alla III la sparizione degli antichi giocatori nella trasformazione dei loro corpi in larve evanescenti:
[…] Se uscissero
adesso per la scaletta nel traffico
della strada coi lumi
accesi di giorno
sotto questo cielo che sta per piovere,
guizzerebbero fatui
sopra i duomi e le nuvole
alle risse dell’uragano.
Nonostante nel volume Linea della vita la poesia scaturisca direttamente dal contatto con la realtà, assecondando la nuova concezione poetica di Vigolo, anche i componimenti più immersi nell’attuale aprono spiragli verso epoche remote. Così il poeta «[…] seduto / davanti alla Chiesa Nuova / » in un «fresco tramonto», ha una visione dove
L’Oratorio arretra
in una polvere d’oro
di favola chinese:
un mandarino vestito di seta
scende dalla carrozza d’un cardinale.
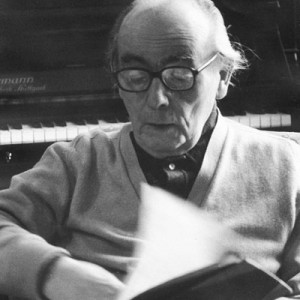 D’altra parte è sufficiente passeggiare per Roma e osservare le antiche insegne di negozi per ritrovarsi nel passato. «”Macelleria fondata / l’anno milleseicento” » si legge sull’architrave di un locale, sotto il sole accecante di luglio, ed ecco che «La luce / della canicola affolla i fantasmi / richiama al quarto vermiglio / i mangiatori ora ombre […] ». Le larve di quelli che furono uomini risalgono «dai freddi prati » dell’Ade ma, non potendo riprendere vigore «dal sanguigno pasto», si contentano di risentire il sapore delle vivande divenuto ormai «tetro».
D’altra parte è sufficiente passeggiare per Roma e osservare le antiche insegne di negozi per ritrovarsi nel passato. «”Macelleria fondata / l’anno milleseicento” » si legge sull’architrave di un locale, sotto il sole accecante di luglio, ed ecco che «La luce / della canicola affolla i fantasmi / richiama al quarto vermiglio / i mangiatori ora ombre […] ». Le larve di quelli che furono uomini risalgono «dai freddi prati » dell’Ade ma, non potendo riprendere vigore «dal sanguigno pasto», si contentano di risentire il sapore delle vivande divenuto ormai «tetro».
La successiva raccolta poetica, Canto del destino , descrive una fase esistenziale di Vigolo nella quale predomina il sentimento di tragicità insito nel proprio destino. Il presente è insopportabile da vivere per il poeta che si rifugia nei ricordi e nel sogno. La sua anima non può distaccarsi dalla finestra della casa sul Lungotevere dove egli nacque. Allora dal davanzale la vista spaziava sugli alberi e il fiume, mentre in lontananza appariva «l’azzurro dei colli d’Alba» . A distanza di tanto tempo, gli sembra di salire ancora le scale di notte, come accadeva in gioventù, e di fermarsi davanti alla porta «che ha il nome / del padre sopra la targa lucente», sentendo però in modo confuso, come avviene nei sogni, che non abita più in quel luogo dove altri ora dormono.
Ma magicamente il sogno (perché il poeta stava sognando) gli spalanca le porte, lo conduce di nuovo sui «favolosi davanzali», mentre sul Lungotevere fa risplendere solo per lui il triste «sole dei morti». Il poeta torna a vivere nel passato, quando si affacciava alla finestra con i suoi cari (la cui presenza è stata preparata da quella luce misteriosa che brillava nel cuore della notte). Egli però avverte nel sogno come gli anni siano ormai passati e come il loro peso abbia abbassato il davanzale fino al piano terreno da dove l’antica visuale risulta capovolta: dal basso ora appaiono «il viale / sconvolto da un uragano, / gli alberi stesi nel fango » che rappresentano le avversità della vita che si sono abbattute sul poeta. Di nuovo però la scena del sogno cambia e un «vento di sereno», proveniente dalla campagna, fa risalire la finestra nell’alto. Il volto sorridente del padre sembra allora comunicare un messaggio di speranza al figlio che, rincuorato, scopre nel soffio liberatore del vento una nuova energia con cui superare i mali del presente:
– Senti, io dicevo al pensieroso,
che bel vento ci viene da quei monti?
E’ il vento che spazza le nubi,
il vento di Non- ci- pensare!
In alcune prose dei volumi Le notti romane e Spettro solare è ampiamente sviluppato il motivo della fine che non risparmierà la città non più eterna. Sotto il titolo Piccola Apocalisse, sono riunite alcune prose de Le notti romane in una delle quali è descritto con estremo realismo il crollo definitivo di Roma. Anche qui, come ne La città vegetale, c’è un gruppo di amici che, insieme al protagonista, vagabondano per le strade del centro finché, stanchi e annoiati, entrano in un piccolo bar «dietro la Galleria».
Subito però avvertono qualcosa di insolito nell’atmosfera del locale dove gli avventori sono agitati e nervosi e, non appena sentono una notizia recata da un passante, che è entrato trafelato, si precipitano sulla strada. Anche il protagonista li segue e scorge sul cornicione di uno dei palazzi più alti «una bimbetta con una candela accesa in mano, che cammina scalza […]» All’improvviso, quasi la misteriosa apparizione recasse l’annuncio della fine, comincia a crollare il cornicione e, in rapida successione, s’inabissano le chiese e i palazzi di Roma.
L’io narrante, divenuto «un superstite inutile», scende e risale «i faticosi valichi delle rovine fino agli smerli degli ultimi muri su certe camere chiare, sgranate alla luce cruda diurna […] » Senza dubbio la descrizione della catastrofe appartiene al lato visionario della personalità di Vigolo, ma come non metterla in relazione con i tragici scenari della Seconda guerra mondiale durante la quale i bombardamenti pure a Roma avevano sventrato palazzi e causato morti ?
Non è dovuto agli uomini però il cataclisma che si è abbattuto sulla città dove «un popolo scarmigliato e seminudo sbucava a turbini dalle crepe della terra: con lenzuoli gittati alla meglio e lacere vesti, sembravano risuscitati . » Piuttosto, come svela il paragone finale, stiamo assistendo non solo alla fine di Roma, ma del mondo intero. Prima di essere travolto da «un altissimo muro d’acqua», avanzante sulla città, il protagonista riusciva ancora a vedere «sul ciglio estremo della cataratta la chiglia d’una barchettina d’argento » a prora della quale risaltava l’enigmatica figura «della piccola sonnambula […] che faceva luce sull’abisso con la sua candela miracolosa .»
La rappresentazione della fine di Roma si trova anche nella prosa La notte delle statue del volume Spettro solare , stesura ridotta e con varianti, del racconto Il Finimondo già apparso ne La città dell’anima . Stavolta però il futuro destino di Roma non è più presentato in modo drammatico, ma con le movenze e i toni di un raffinato divertissement. All’inizio della prosa, Vigolo ricorda come «[d]i quando in quando a Roma, in tempi calamitosi, si torna a parlare, un po’ scherzando e un po’ sul serio, della fine del mondo, secondo il detto di Beda il Venerabile che “finché starà in piedi il Colosseo, starà in piedi anche Roma, ma crollato il Colosseo, crollerà anche Roma e con essa l’universo” .»
Il poeta immagina allora in che modo si attuerà l’antica profezia: tutte le antiche statue di Roma si rianimeranno, come per incanto, quando «la statua di Roma sulla torre del Campidoglio, quella che nella destra palleggia l’orbe della terra […] lo scaraventerà con dispetto nella piazza, come cosa di cui ormai non sa più che fare. L’orbe scagliato colpirà la groppa del cavallo di bronzo e sveglierà il pio imperatore che, dando del calcagno contro la pancia dell’animale, lo farà saltare dal basamento e staccare la corsa per la cordonata di Michelangelo .»
Per primo, quindi, sarà il celebre cavallo a riprendere vita e a lanciarsi «come un bolide» nel caotico traffico della città. Al suo passaggio tutti riconosceranno il segnale che annuncia la fine del mondo. Successivamente Vigolo si diverte a rappresentare lo strepito e la ressa che farà il popolo sterminato delle altre statue dirigendosi verso le porte delle sale di gallerie e di musei. Oltre alle statue del mondo classico, si muoveranno anche quelle della Roma cristiana. Con grande gusto l’autore ritrae i gesti cauti e timorosi con cui le statue dei santi inizieranno a scendere dal cornicione sul colonnato di San Pietro dove le ha confinate Bernini.
L’incessante ondata di risurrezioni trasforma così Roma «in una valle di Giosafatte di tutte le statue, dalle più antiche, giù giù a quelle ottocentesche dei ministri in finanziera e in pantaloni .» Ma, in mezzo a quella spaventevole sarabanda, Vigolo riesce ancora a scorgere con sollievo e con affetto «[l’]aggraziato elefante della Minerva», la più festevole delle statue inoffensive, che graziosamente trotterella «qua e là come un ben pasciuto somarello, con tutta la sua santa pazienza di tenersi in bilico l’obelisco sulla groppa .»
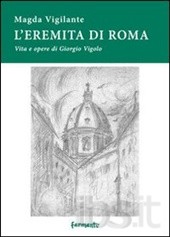 Con l’avanzare dell’età, Vigolo torna a vagheggiare quella epoca beata in cui, fanciullo, passeggiava a lungo per Roma con il padre. La poesia Gianicolo del volume I fantasmi di pietra confronta il passato felice e il triste presente nello stesso luogo in cui il poeta veniva condotto durante l’infanzia. Il cuore del fanciullo si allargava e ritrovava vigore «quando dal clivo di Sant’Onofrio» saliva fino al Granicolo, guidato dalla mano dal giovane padre, il cui contatto rassicurante sembra ancora di risentire al vecchio poeta. La vista spaziava sull’«aperto cielo» e il «vasto giro / di quei monti lontani / dove l’onda dei tetti dileguava […] »attivava una gioia liberatoria nel fanciullo . Adesso, invece, sulla Roma osservata dall’alto si proietta l’altra città , quella «tragica di ansie e di amori sepolti» che Vigolo nasconde nel suo intimo. Tuttavia nella mente permane ancora la stessa sensazione di sollievo e speranza suscitata dal Gianicolo nel cuore del fanciullo «Ma nella mente ha pure il suo Gianicolo! )».
Con l’avanzare dell’età, Vigolo torna a vagheggiare quella epoca beata in cui, fanciullo, passeggiava a lungo per Roma con il padre. La poesia Gianicolo del volume I fantasmi di pietra confronta il passato felice e il triste presente nello stesso luogo in cui il poeta veniva condotto durante l’infanzia. Il cuore del fanciullo si allargava e ritrovava vigore «quando dal clivo di Sant’Onofrio» saliva fino al Granicolo, guidato dalla mano dal giovane padre, il cui contatto rassicurante sembra ancora di risentire al vecchio poeta. La vista spaziava sull’«aperto cielo» e il «vasto giro / di quei monti lontani / dove l’onda dei tetti dileguava […] »attivava una gioia liberatoria nel fanciullo . Adesso, invece, sulla Roma osservata dall’alto si proietta l’altra città , quella «tragica di ansie e di amori sepolti» che Vigolo nasconde nel suo intimo. Tuttavia nella mente permane ancora la stessa sensazione di sollievo e speranza suscitata dal Gianicolo nel cuore del fanciullo «Ma nella mente ha pure il suo Gianicolo! )».
Nella raccolta I fantasmi di pietra , ma soprattutto nell’ultimo libretto poetico La fame degli occhi , predomina il tema della memoria associata non solo alle esperienze vissute dal poeta, ma anche ad una Roma ormai sparita. Chi ricorda più, infatti, il Foro Traiano «com’era una volta fra le case / ancora in piedi intorno alle colonne / mozze sull’erba? » Con rimpianto Vigolo rievoca le sue scorribande notturne con gli amici, durante le quali, uscendo da «fumose osterie», si recavano a vedere attraverso «la grata sul fianco / dei santi Luca e Martina » le misteriose ombre proiettate nei sotterranei della chiesa da una lampada sempre accesa. Tutto il componimento si riferisce ad un tempo passato del quale il poeta è diventato ormai il nostalgico custode.
Il futuro si configura, invece, come attesa paziente della morte, quando lo stesso Vigolo si trasformerà in uno dei «fantasmi di pietra», le antiche statue di Roma, dritte «agli angoli delle strade, / sugli sfondi del cielo o fra le nuvole » , la cui presenza ha sempre accompagnato la vita del poeta, di giorno e di notte e persino nei sogni.
—
(Da Conclave dei sogni, 1935)
Il viso
Malinconia d’esistere con questo
volto remoto che ci esprime l’anima
e la sua storia e i giorni alti e perduti,
senza più averne la memoria e il senso.
Scruti meglio la pietra: in selve amare
più domestica lingua hanno le foglie
e i paesi si leggono: s’intende
l’innocenza dei monti. Ma l’umano
viso, il tuo stesso, che ti senti in carne
fitto all’essenza, che vuol dire?
Indaghi
inutilmente questa tua persona
che sempre hai teco e nei notturni vuoti
s’ingrandisce di sogni, apre il suo libro
su figure dolcissime o tremende.
E allor, quasi prendendo del tuo buio
una rapita conoscenza, credi
finalmente di leggerti. Decifri
l’oscura lingua, sillabi le forti
lettere e i nomi sciogli.
Illuso! in altro
specchio t’ appari. O ti dispieghi in vaste
epoche d’astri e spaziati cosmi
o stringi i tempi in questi sensi umani,
solo saprai di non saper chi sei.
*
Notturnale
Sol ch’io possa vagar Roma notturna
per vie segrete antiche e in me risgorga
la memoria com’acqua di sotterra.
Profonda ai passi miei vibra la terra
d’un ridestato senso ed ogni casa
nel suo sonno di pietra odo parlare,
come parlare in sogno odo i mendichi
che nel portico dormono distesi
in compagnia dei morti. Un lume solo
in questa valle altissima di chiese
vacilla nella grotta tra gli avelli
scolpiti e suda il marmo umido come
una fronte. Le nuvole discese
sono ai sepolcri con la nebbia bassa
che dalle grate allaga le cantine
col suo fiato di laghi e di boscose
campagne: ed ecco, le deserte strade
traboccano di folla, un silenzioso
fiume le invade d’anime: sciamanti
vengon meco nel soffio antelucano
riconoscendo le materne pietre.
A milioni s’addensano in anguste
straducole e milioni d’occhi, insieme
mirando, fan questo pallor dell’alba.
*
(da Linea della vita, 1949)
(Sezione I secoli poeti)
I duomi
Specchiata in fondo al rapido
sangue serbai la fuga
di torri e duomi al cielo,
che fanciullo miravo,
da terra breve stelo,
rapito all’alto ciglio
delle ventose mura.
.
Le nuvole di marzo
splendean fra pioggia e sole,
marine trombe ove le chiese assorte
salivano nel subito chiarore;
ma, se improvvisa l’ombra
le dirupava al suolo,
oh, vertigine aperta,
mi perdevi in un tuono
di fuggenti colombi.
.
Forse in sogno le tavole
dei miei notturni atlanti
quei duomi ancora innalzano
su scalee di giganti;
aeree logge sorgono
sui tetti, ove delira
il folle ghirigoro
della cupola a spira.
Ma al declinante sole
tutto impietriva in gelida
sera: su verde cielo
ora a guardarmi fise
con curiose creste
di pinnacoli, occhiaie di finestre,
chimere di campanili,
si drizzavan le chiese;
e ruggivano vive
con le gole degli organi
a fumate d’incensi.
Io sparivo nel fuoco
di quei visceri immensi
*
(dalla Sezione L’eremita di Roma)
II
Trasognato e felice
per viucole antiche,
vagavo sotto un cielo
vicino alla pioggia. Leggero
ai passi m’era il suolo
e vaniva la via sotto il piede
come un fiume di nuvole;
tanto mite scendeva
a specchio dei selciati
la dolce ora di sera fra le brune
case, e anche le persone ferme
nel vano buio delle porte avevano
non so quale perlata ombra sui volti
Via Monserrato, via del Pellegrino,
Campo di Fiori mi si aprì di gialli
meloni acceso e di cocomeri rossi
nel grigio della sera senza lumi,
fin quando prese a cadere
una pioggia tiepida, lieve,
e le strade si fecero nere.
*
(da Canto del destino, 1959)
La finestra sul Lungotevere
1
L’anima è ferma ancora alla finestra
della casa ove nacqui sul Lungotevere;
non mura innanzi, ma gli alberi e il fiume
e, lontano, l’azzurro dei colli d’Alba.
Quelle finestre fanno ancora luce
sui miei pensieri d’adesso; e, per poco
ch’io mi raccolga, subito si formano
intorno a me quelle chiare pareti
e gli alti specchi dove non giungevo
ancora a vedere il mio viso,
ma solo le nuvole e il cielo.
Quella camera è dentro me indelebile
e ogni notte vi torno ad abitare.
E’ buio, salgo a tentoni le scale,
le prime scale della mia vita; conto
come allora i gradini…Al terzo piano
mi fermo innanzi all’uscio che ha il nome
del padre sopra la targa lucente.
Ho confusa memoria che non abito
ora più qui, che altra gente vi dorme,
che v’entro come un ladro o come tornano
le ombre ai luoghi dove hanno vissuto.
Ma il sogno m’apre quell’uscio e le alte
porte mi schiude, gira le maniglie
bianche, tonde come uovi; mi riporta
sui favolosi davanzali e, solo
per me, di piena notte fa risorgere
sul Lungotevere il sole dei morti.
2
Insieme con i miei cari
eravamo affacciati alla finestra
alta, sul Lungotevere
dove ogni notte torno ad abitare.
La finestra s’era abbassata
fino al piano terreno
per il peso degli anni;
ora dal basso vedevamo il viale
sconvolto da un uragano,
gli alberi stesi nel fango.
Ma a un vento di sereno
che veniva dalla campagna
la finestra nell’alto risalì;
e sorrise l’argenteo
viso del padre
alla fresca luce dei monti
che avevano il colore dei suoi occhi.
– Senti, io dicevo al pensieroso,
che bel vento ci viene da quei monti?
E’ il vento che spazza le nubi,
il vento di Non- ci-pensare!
Vicolo Scanderbeg
1
Scendendo la scalinata
lilla del Quirinale
nella sera di limpido freddo,
la strada della Datarìa mi si affonda
buia dinanzi nel cupo
della città vespertina;
ma in alto sulle case il cielo è rosso
e azzurro come l’ala
dei serafini occhiuta
di splendenti pianeti,
e giù a ponente la cupola
d’indaco fosco s’intaglia.
L’asfalto
della Datarìa lustra, molato
dalle ruote, a un barlume
d’oro nel cielo;
ma su nella piazza
i bianchi cavalli
mettono le ali
come pegasi, volano
dalla fontana alle prime stelle.
2
Ora cado
nella notte, mi butto
sotto il cavalcavia
del Vicolo Scanderbeg,
entro nel fitto
delle case e tutta
dispare la luce, tutto
è favola, dietro la chiesa
che chiude i precordi
dei papi. La luna
è alta, ora, e gelida schiara
il canneto di colonne
dei santi Vincenzo e Anastasio.
Sulla fontana
di Trevi, asciutta,
morta, come un paesaggio
lunare, i gatti
cercano gli scheletrini
dei pesci.
*
(da La luce ricorda, 1967)
I giocatori
.
Giù nella grotta dei martiri
ch’era taverna
di militari
i crocifissi brillano su pozze
di sangue; e lì presso
i veterani
giuocano ancora
a carte stregate.
.
Su una carta piange Maria
il Figlio straziato,
su un’altra Venere gli occhi
volge languida e si pettina
gli aurati capelli sul mare
che muta colore.
Moventi figure, numeri
di pianeti gittano
sul tavoliere
ad alte grida blasfeme;
poi mischiano i grandi
tarocchi e si fissano
nel giuoco difficile e scuro.
.
Da mila anni son lì che giuocano
senza cibo né sonno:
la città sopra loro
s’è fatta moderna e rintrona,
in quel fondo, di tràini
che fanno tremare l’incanto.
Se uscissero adesso
dall’usciòlo nel chiasso
dei traffici e delle luci forti,
cadrebbero in cenere e nulla
come tratti da un sarcofago.
*
(da I fantasmi di pietra, 1977)
I fantasmi di pietra
Roma, questi fantasmi pietrificati
fra i quali io mi aggiro da sempre
e che si disciolgono la notte
e si rovesciano nei miei sogni
come un Tevere
che nel mio sangue s’insala…
ma poi di giorno, eccoli di nuovo diritti
agli angoli delle strade,
sugli sfondi del cielo o fra le nuvole,
i fantasmi di pietra
mi guardano, mi aspettano
che diventi uno di loro.
*
Gianicolo
Quando salgo al Gianicolo e sul mare
a picco di tetti e di chiese
dal suo sommo mi sporgo, una vertigine
anche oggi mi prende
come quando dal clivo
di sant’Onofrio fin quassù salivo
col mio giovane padre. E sento ancora
la mia nella sua mano,
mano del mio Virgilio
che mi traeva su da quella valle
di paure nel sole.
Che respiro l’aperto
cielo mi dava e il vasto giro
di quei monti lontani
dove l’onda dei tetti dileguava
insieme ai miei spaventi;
e anche oggi se torno
sul caro colle, io scorgo con un brivido
nella bassura il doppio
della tetra città che dentro chiudo,
tragica di ansie e di amori sepolti
in funebri architetture.
(Ma nella mente ha pure il suo Gianicolo!)
*
(da La fame degli occhi, 1982)
Foro Traiano
Chi si ricorda del Foro Traiano
com’era una volta fra le case
ancora in piedi intorno alle colonne
mozze sull’erba?
Giù per Via Alessandrina
da fumose osterie uscendo brilli
nel tenebroso intrico
di vicoli dell’Arco dei Pantani,
si andava la notte a vedere
a Via Bonella la grata sul fianco
dei santi Luca e Martina;
dava sui sotterranei, una lampada appesa
a quelle infere volte, sempre accesa,
vagellava movendo ombre spettrali.
Le nuvole calavano ai sepolcri
dai boschi del Palatino
come un giubileo d’anime, uno sciame
di spiriti nel soffio antelucano.
Milioni di riaperti occhi facevano
il pallore dell’alba
Una prosa inedita di Giorgio Vigolo
Nella Sezione Narrativa dell’ Archivio Giorgio Vigolo, posseduto dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, si trova una cartella con l’intestazione autografa Prose 1926-1929 e con la collocazione A.R.C. 16. Sez. EI /9c, dove sono riunite alcune prose tra cui una inedita sulla basilica di San Pietro. Il testo, senza titolo, è costituito da 3 carte autografe, di mm 210×160, scritte in inchiostro nero, solo sul recto, con varianti a matita nera e correzioni a matita rossa e blu. Sulla prima carta, in alto a destra, è riportata la data autografa in inchiostro nero « 30 luglio XXIX». Le carte sono state numerate da 9 a 11 durante la catalogazione dell’Archivio. La c. 10 è stata cassata dall’autore con un tratto di matita blu.
Nella trascrizione della prosa la grafia di alcuni vocaboli è stata uniformata all’uso attuale.
Vigolo descrive in prima persona una visita alla basilica di San Pietro, compiuta durante un’assolata tarda mattina estiva. A differenza di altre prose dedicate alla più celebre basilica di Roma, stavolta l’autore non si sofferma sulla sua grandiosità e bellezza , ma su un piccolo particolare che egli ha scoperto nell’«ultimo finestrone di destra, verso l’abside» dove «campeggia diritto e acuto un cipresso». E’ proprio l’albero che si staglia contro il cielo azzurro ad attirare l’attenzione del poeta, suscitandogli una serie di riflessioni:
Domenica mattina, 28 luglio, sono entrato in San Pietro verso mezzogiorno.
Una nuvola provvidenziale che s’è messa ad attraversare il cielo proprio nel momento ch’io attraversavo la piazza, mi ha permesso di sfidare il bollente calore di quel lago di fuoco e di giungere ancor fresco al vestibolo della basilica.
La quale, mi è sembrata davvero un’immensa rocciosa conchiglia, di forma bizzarra, ruvida e scabra di fuori- levigata, al di dentro, da uno smalto azzurrino; profonda di meandri come un orecchio; piena di murmuri, di soffi circolanti e ventilati.
In fondo a quell’immensa conchiglia io mi sono rincantucciato.
In alto alle navate, i finestroni erano aperti: e dai giardini vaticani il canto delle cicale scendeva nella basilica. Un incanto!
Ho veduto poi il più bel quadro (di gran lunga il più bello!) che ci sia in San Pietro.
Nell’ultimo finestrone di destra, verso l’abside, campeggia diritto e acuto un cipresso, sull’alto rettangolo di cielo azzurro, latino.
L’apparizione di quel verde nume mi ha fatto palpitare.
Un albero: che cosa divina è un albero, ma particolarmente, un cipresso!
E vederselo, inaspettato, apparire da uno spiraglio di questa immane caverna, ove la freddezza dei marmi e delle tombe ha un che di stranamente minerale, metallico e carnale in cui la tenera, innocente presenza degli alberi non ha più luogo.
A pensare: com’è lontano dagli alberi, questo tempio torbidamente umano e storico.
C’è pietra, marmo, porfidi, bronzi, ori: non c’è una foglia, non un fiore. Che vuol dire? Un contrasto, assai suggestivo, di Storia e di Natura?
E’ vero: la pietra è storia: più storia dell’uomo. C’è in essa una testimonianza: il senso della durata: quella pietra stava lì quando noi non eravamo nati, ci starà nei secoli a venire, immutata. Il senso di una presenza remota e futura.
L’albero invece è tutt’altro: una freschezza, un’innocenza, una gioventù così esente, così serena, non saprei dire: ma certo quand’ho visto spuntare quel cipresso, lo vorreste credere, che quasi ero tratto a inginocchiarmigli di fronte? Mi parve scaduto e prescritto tutto il sacro della solenne basilica [questo precisamente ho sentito in quel momento. E non era un atteggiamento paganeggiante, classicheggiante: nemmeno per sogno.
Qualcosa di molto diverso e infinitamente lontano.]
Un senso religioso della natura, passato attraverso il cristianesimo: e al tempo stesso così romano, così latino per la sua bella serenità campestre. Ecco: campestre. La religione di Numa passata nel cristianesimo, verso una limpida redenzione della Natura.
Forse è questo. Dio fatto albero simboleggia un grado di religiosità forse più elevato che non Dio fatto uomo.
Corsi e ricorsi del divino.
Il canto delle cicale opportunamente scendeva nella basilica come la musica liturgica più adeguata a questa mia semplice, agreste, naturale religiosità.
Non inni, non organi: il coro delle cicale.
Credo con questi miei pensieri d’aver santificato l’estate.
Di gennaio altri numi ci appariranno.
Giorgio Vigolo
